Le persone autistiche pensano allo stesso modo degli altri pur percependo il mondo in modo differente. È l’assunto del libro autobiografico Eccentrico, edito da Effequ, di Fabrizio Acanfora, scrittore, musicista, accademico, blogger, noto per la sua attività di divulgazione scientifica riguardante lo spettro autistico. Il testo, che ha vinto il Premio nazionale di divulgazione scientifica 2019, descrive, in una sorta di flusso di coscienza, il modo di pensare di una persona autistica. Ne emerge una visione del mondo originale, ricca di stimoli sensoriali dirompenti e di rituali rassicuranti. Una riflessione profonda che sfocia nell’affermazione della necessità della convivenza di ogni differenza, nel segno del rispetto per l’unicità di ogni singolo individuo.
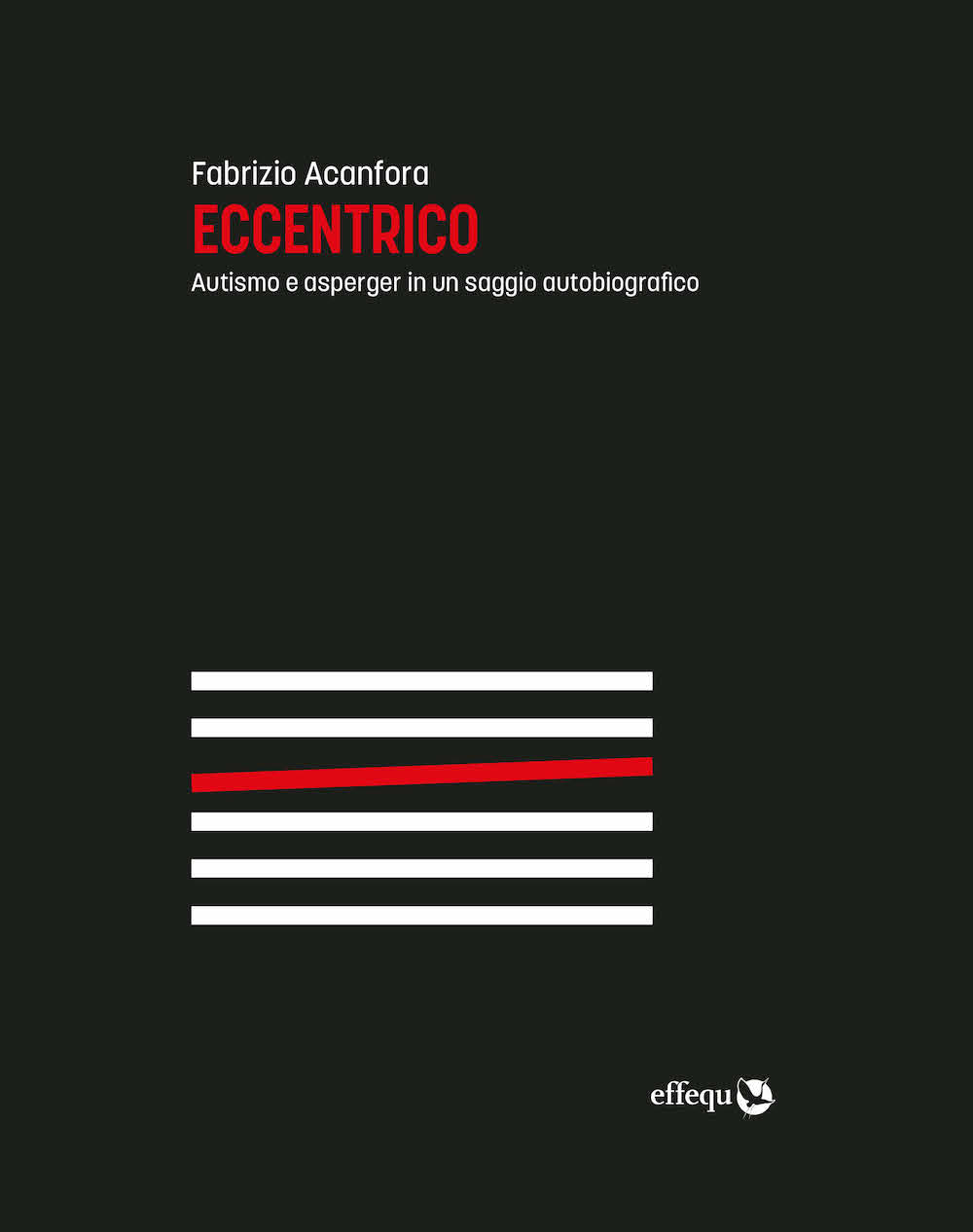 “L’autismo è oggi definito uno spettro – spiega Fabrizio Acanfora – e questa definizione porta con sé l’idea che non esista un confine netto tra l’essere neurotipici e l’essere autistici. Si può pensare a questa condizione come a una serie di caratteristiche presenti in vario modo in tutta la popolazione, ma quando un certo numero di esse, con particolare intensità, è presente in una sola persona, allora è possibile arrivare a una diagnosi di autismo”.
“L’autismo è oggi definito uno spettro – spiega Fabrizio Acanfora – e questa definizione porta con sé l’idea che non esista un confine netto tra l’essere neurotipici e l’essere autistici. Si può pensare a questa condizione come a una serie di caratteristiche presenti in vario modo in tutta la popolazione, ma quando un certo numero di esse, con particolare intensità, è presente in una sola persona, allora è possibile arrivare a una diagnosi di autismo”.
Perché una persona autistica sembra viaggi a velocità supersonica?
“Un sistema nervoso differente porta a percepire ed elaborare gli stimoli esterni e interni in modo diverso dalla maggioranza, e quindi a interagire col mondo in modo peculiare. Il pensiero nelle persone autistiche è influenzato da tali differenze, in particolare da una percezione sensoriale estremamente sensibile, che può portare a quello che viene definito “sovraccarico sensoriale”, in cui la persona ha bisogno di “resettare” i propri sensi allontanandosi dalla situazione percepita come troppo stimolante. Da qui la necessità di aderire alle proprie routine”.
Tra i comportamenti tipici dell’autismo c’è infatti la ripetitività: compiere un’attività in maniera ossessiva, immergersi in un flow perdendo ogni concezione di tempo e spazio. È così?
“Come dicevo, nell’autismo esiste la necessità di rendere il mondo più prevedibile e di poter tenere sotto controllo gli stimoli. Una delle cose che rendono possibile tutto questo è proprio la possibilità di immergersi in attività denominate “interessi speciali”. Si tratta di attività peculiari come collezionare oggetti, raccogliere informazioni, studiare argomenti a volte fuori dal comune. Qualsiasi cosa permetta alla persona autistica di isolarsi dal mondo immergendosi in qualcosa che percepisce come piacevole, gratificante, e di cui riesce ad avere il controllo”.
Lo studio del pianoforte e la costruzione di clavicembali rientrano tra i tuoi “interessi speciali”?

“Per me la musica è stata l’interesse più profondo e duraturo, qualcosa che potrei definire come una passione, se non come una vera necessità. La musica mi permette da una parte di isolarmi e tagliare fuori un mondo spesso troppo caotico, stancante e imprevedibile, e dall’altra di dialogare con le mie emozioni più profonde, di poterle esprimere, di poter controllare il mio corpo attraverso i movimenti delle mani. La musica mi ha insegnato a osservare le cose sia nei minimi dettagli che più da lontano, cercando di integrarle in un quadro coerente”.
Un altro luogo comune vuole la persona autistica priva di empatia, fredda e distaccata. Ma è poi vero?
“Questa storia nacque perché l’approccio alla condizione autistica è sempre stato di tipo medico riabilitativo, per cui la persona autistica veniva vista come un cumulo di deficit. Oggi si cerca di guardare alle caratteristiche dell’autismo come a una serie di differenze che, in alcuni casi, se messe a interagire con un mondo creato e gestito da e per persone neurotipiche, possono trasformarsi in difficoltà, deficit e ostacoli. Questa visione rende possibile la ricerca di accomodamenti che partano dalla prospettiva della persona autistica. Riguardo all’empatia, noi autistici abbiamo una particolare organizzazione del sistema nervoso che ci fa interpretare il mondo in modo differente. Questo discorso vale anche per una serie di codici che le persone utilizzano anche in modo non verbale per comunicare sentimenti e intenzioni”.
Potremmo dire che gli autistici sono “diversamente empatici”?
“Esatto. Se si ascoltano i racconti delle persone autistiche, si constata che quella che viene definita “empatia emotiva”, ossia la capacità di provare sentimenti e emozioni altrui, è anzi spesso estremamente sviluppata, a volte in modo addirittura doloroso. Ma la parte cognitiva dell’empatia, ossia la comprensione del perché l’altra persona stia provando un determinato sentimento, come reagire in certe situazioni, può apparire carente. Lo studioso autistico Damian Milton ha proposto quello che ha definito il “Double Empathy Problem”, in cui sostiene che questo presunto deficit sia dovuto proprio alla differente interpretazione di quei codici a cui facevo cenno. Quindi potremmo dire che l’incomprensione a livello empatico tra autistici e neurotipici è reciproca”.

Le persone autistiche, essendo ipersensibili agli stimoli sensoriali, sono più soggette all’ansia?
“Immagina di vivere in un mondo sensorialmente travolgente, caotico e imprevedibile, in cui le persone sembrano avere una modalità di interazione sociale che non ti appartiene e che tu devi quindi apprendere e attuare in modo razionale, con enorme dispendio energetico. Immagina di vivere in un mondo in cui questa tua diversità venga inoltre stigmatizzata fin dall’infanzia, per cui cominci a percepirti come sbagliata, incapace, inadeguata e sempre fuori luogo. A questo punto anche semplicemente entrare in un negozio a domandare il prezzo di una maglietta diventa un’impresa titanica che riesce a scatenare crisi d’ansia che dall’esterno appaiono inspiegabili”.
Alcune volte la reazione fisiologica di una persona autistica allo stress è di fight-flight-freez (attacca, scappa o paralizzati); alcune altre si scatena una tempesta detta meltdown; altre ancora subentra uno shotdown. La consapevolezza può aiutare a gestire meglio le crisi?
“Queste crisi sono il modo in cui un sistema nervoso in sovraccarico a causa di stimoli sensoriali, intellettivi o emotivi, cerca di “resettarsi”. Un meltdown spesso può essere confuso con una crisi di rabbia, mentre uno shutdown è realmente uno spegnimento in cui la persona si chiude in sé e riduce al minimo l’interazione col mondo circostante. In entrambi i casi la consapevolezza della propria condizione è fondamentale per riuscire sia a prevenire le crisi, evitando il peggio, che per gestirle in modo ottimale. Inoltre, la consapevolezza aiuta l’autistico a non sentirsi “difettoso”, ma a pensare che si tratta di reazioni normali per individui con un funzionamento specifico che interagiscono con un ambiente non adatto al loro funzionamento”.

Star Partners II, Ltd.
Trovi che in una cultura caratterizzata da omologazione dei comportamenti e del linguaggio l’incomprensione dell’atipicità sia più accentuata?
“La cosa più difficile da comprendere è che l’evoluzione sociale e culturale spinge ciascun individuo a ricercare la propria identità, a porsi domande profonde per comprendere se stesso e la propria relazione col mondo. Così capita che sempre più ci si renda conto che quelle categorie in cui abbiamo ingabbiato l’umanità non sono sufficienti per contenere la diversità, la naturale variabilità che ci caratterizza, e qui nascono ulteriori problemi. Se sono nato e cresciuto pensando che le persone di sesso maschile devono fare determinate cose mentre quelle di sesso femminile hanno un loro ruolo specifico nella società, l’idea che tutto questo possa essere un costrutto artificiale mina le mie più profonde convinzioni, e molto probabilmente lo rifiuterò. Questo vale per tutte le differenze, soprattutto per quelle che si esprimono in modo fluido sgretolando letteralmente le categorie. Fanno paura perché non si riescono a comprendere, e la paura spesso sfocia in atteggiamenti aggressivi, di difesa, e così si finisce per bullizzare o odiare l’altro da sé, se non è conforme ai canoni consueti”.
“La diversità è negli occhi di chi guarda” è un tuo saggio su questo tema. Perché sostieni che il concetto di convivenza sia preferibile a quello di inclusione?
“Trovo che l’inclusione presupponga un’esclusione ingiustificata, e già qui c’è un problema. Inoltre, questo concetto si basa sul presupposto che ci sia un gruppo che ha il potere di includere, di permettere l’ingresso ad altri gruppi, evidenziando uno squilibrio di potere tra un’autoproclamata maggioranza e i gruppi marginalizzati, che si trovano a subire l’inclusione. È un concetto fortemente paternalistico, al quale preferisco sostituire l’idea di “convivenza delle differenze”, in cui ogni persona è allo stesso livello delle altre, nessuno decide chi e come includere, ma si è reciprocamente responsabili della convivenza”.
 Nel tuo ultimo libro In altre parole (Effequ) affermi l’importanza di curare il linguaggio, soprattutto in tema di inclusione. Usare le parole giuste può contribuire a cambiare la cultura?
Nel tuo ultimo libro In altre parole (Effequ) affermi l’importanza di curare il linguaggio, soprattutto in tema di inclusione. Usare le parole giuste può contribuire a cambiare la cultura?
“Il linguaggio non è solo un mezzo attraverso cui trasmettere informazioni, come banalmente si pensa. I nostri pensieri sono formati da concetti, che a loro volta sono formati da parole. Le stesse emozioni sono dei concetti in cui raggruppiamo una serie di sensazioni fisiche. Le parole influenzano la nostra biologia interna: basti pensare a quanto sia facile far aumentare il battito cardiaco, la sudorazione e la pressione di una persona aggredendola verbalmente. Avere un linguaggio elaborato in grado di distinguere tra diverse sfumature di un’emozione o un sentimento ci permette di comprenderli meglio e di poterli gestire in modo più efficace, di prendere decisioni più accurate. Il linguaggio contribuisce a creare la realtà nella quale viviamo, dà significato alle nostre vite”.












