La “banalità” della spia. Nel 1953 Ian Fleming pubblica il suo primo romanzo, con James Bond per protagonista, “Casino Royale”. Non molti ci fanno caso. Occorre attendere il 1962 quando nelle sale cinematografiche irrompe un giovane e anche lui non troppo conosciuto Sean Connery. Il film è “Dr.NO”. L’agente 007 con la licenza di uccidere, il suo interprete, e di riflesso Fleming si ritagliano un successo e una fama che durano tuttora.
 In parallelo David John Moore Cornwell, più conosciuto con lo pseudonimo di John Le Carré. Il suo primo romanzo, “Chiamata per il morto”, è del 1961. Il successo mondiale arriva due anni dopo, quando pubblica “La spia che venne dal freddo”, da cui Martin Ritt ricava un film interpretato superbamente da Richard Burton.
In parallelo David John Moore Cornwell, più conosciuto con lo pseudonimo di John Le Carré. Il suo primo romanzo, “Chiamata per il morto”, è del 1961. Il successo mondiale arriva due anni dopo, quando pubblica “La spia che venne dal freddo”, da cui Martin Ritt ricava un film interpretato superbamente da Richard Burton.
Fleming e Le Carré hanno in comune l’essere stati agenti al servizio segreto britannico; un passato di giornalista. Un genere che pur ispirandosi alla realtà, fa fantasticare, la spy-story. Non ci sono regole precise per questo genere, come le venti codificate da S.S: Van Dine per il poliziesco (anche se non manca chi si concede delle licenze). Per la spy-story, ad ogni modo solitamente il protagonista si trova al centro di avventure in località esotiche, le donne raramente resistono al suo fascino; per quello che beve, mangia, fuma, e subisce nel corso della storia si dovrebbe trovare alla fine ogni sorta di malanno; e naturalmente è invece eternamente in forze, e con poco o nessuno sforzo. James Bond, appunto.
Le Carré da questo punto di vista, “stecca”. I suoi personaggi sono “grigi”, anonimi, passano inosservati. Persone “comuni” con grandi problemi irrisolti alle spalle. Pieni di contraddizioni e frustrazioni. Non hanno nulla dell’eroe, anzi. Nei suoi romanzi c’è un “realismo” che probabilmente è la chiave del suo successo: risalta la fallibilità dei sistemi di spionaggio occidentali, con la considerazione implicita che Unione Sovietica e NATO sono sostanzialmente i due volti della stessa moneta. Formalmente divisi da un’ideologia che è più che altro uno schermo, e i contendenti ne sono ben consapevoli. Una recita, e ognuno interpreta il ruolo assegnato: “Siamo tutti uguali, sapete, ecco dove sta la beffa”, dice a un certo punto Alec Leamas, il personaggio principale di “La spia che venne dal freddo”.
E’ qui, la chiave dei romanzi, la “filosofia” di Le Carré. Pedagogo, svela gli inganni delle ideologie. In tempi di guerra fredda un “realismo” che poteva facilmente procurare l’accusa di eretico. Il suo personaggio principale, George Smiley lo si “scopre” appieno ne “La talpa”, ispirato al caso di Kim Philby: il doppiogiochista. Con Donald MacLean, Guy Burgess, Anthony Blunt, John Cairncross, fa parte del “Cambridge Five”: giovani eredi di famiglie altolocate e borghesi che abbracciano la causa del comunismo; da posizioni di rilievo nell’intelligence, si rivelano agenti al servizio dell’URSS fino alla loro defezione e ricomparsa a Mosca. Philby è quello che crea i maggiori danni al Regno Unito e alla NATO: per ventisette anni, e da posizioni operative di rilievo, invia informazioni di altissimo livello, che causano al blocco occidentale gravi perdite di agenti e mezzi. Lo stesso Le Carré è una delle sue vittime.
I romanzi di Le Carrè affrontano tanti di quelli che possono essere considerati i fronti planetari del disordine e temi di preoccupazione universali. I suoi protagonisti operano in quell’evanescente, nebbioso e tuttavia percepibile territorio che sono gli “arcana imperi”: i segreti del potere, i suoi principi, le sue logiche. Ne parla per la prima volta Tacito, nelle sue “Historiae”. Come poi teorizzano Machiavelli e Guicciardini, “la politica diventa un’arma segreta, tutto si discute nel gabinetto del principe, dove il segretario – la parola nasce da questo – è al corrente dei segreti della politica, ma non li può divulgare”. Nel Seicento, un giurista tedesco, Arnoldus Clapmarius, distingue gli “jura sive arcana imperii” dagli “arcana dominationis”: i primi sono i fondamenti universali degli Stati e ciò che ad essi garantisce la conservazione; i secondi invece sono i princìpi occulti ai quali s’ispirano i governanti per non farsi spodestare e dipendono dalla forma della “res publica”.
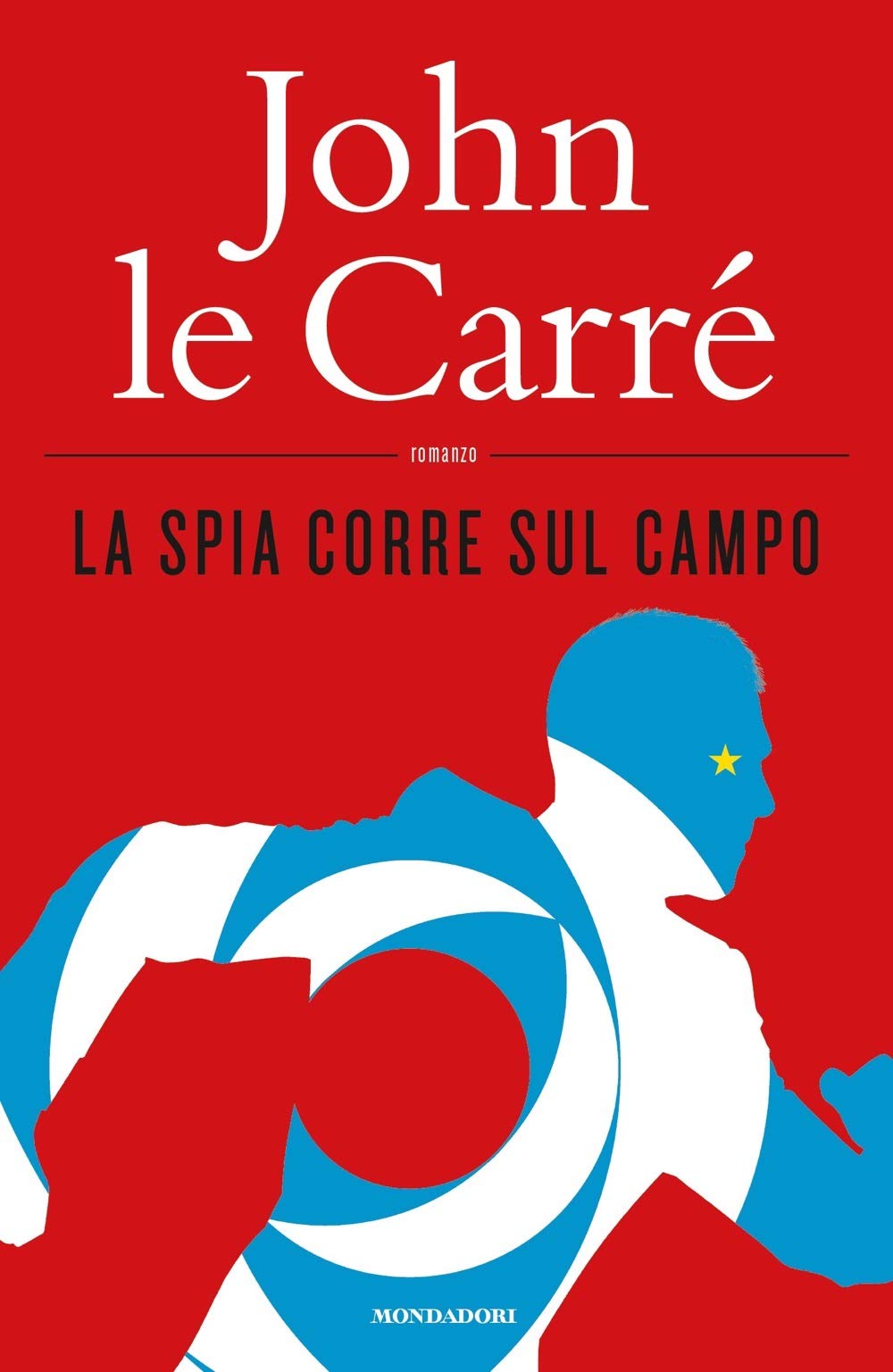 Per tornare a Le Carré, lo scrittore è guidato da una attenta lettura della realtà, e una rabdomantica capacità di interpretare quel che sotto la superficie si agita: la questione palestinese (La tamburina, 1983), le previsioni e conseguenze del crollo dell’impero sovietico (La casa Russia, 1989), il clima di disagio provocato dalla fine della guerra fredda (La pace insopportabile, 1991), l’invasione dell’illecito a livello planetario (Il direttore di notte, 1993), gli scenari della finzione dello spionaggio nelle atmosfere centroamericane (Il sarto di Panama, 1996), gli interessi colossali dei farmaci sperimentati in Africa (Il giardiniere tenace, 2001). L’ultimo libro è dell’anno scorso: La spia corre sul campo: ambientato ai tempi della Brexit e di Trump, ritratto spietato e agghiacciante dei nostri tempi, dove nulla è ciò che appare. I tempi della guerra fredda vengono condensati nel proverbio “L’uomo che ha due donne perde l’anima. Ma l’uomo che ha due case perde la testa” posto come esergo all’inizio de “La spia perfetta”, che Le Carrè così descrive: “Tu una volta hai tradito me, ma, cosa più importante, hai tradito te stesso. Tu menti anche quando dici la verità. Anche tu hai le tue lealtà, i tuoi affetti. Ma verso cosa? Verso chi? Tu sei una spia perfetta. Ti manca soltanto una causa”. Adesso invece è consapevole della disinformazione planetaria quando rispondendo ad un’intervista affermava: “Viviamo in un’epoca di straordinario autoinganno, dove la realtà sta da una parte e la percezione pubblica della realtà esattamente dall’altra”.
Per tornare a Le Carré, lo scrittore è guidato da una attenta lettura della realtà, e una rabdomantica capacità di interpretare quel che sotto la superficie si agita: la questione palestinese (La tamburina, 1983), le previsioni e conseguenze del crollo dell’impero sovietico (La casa Russia, 1989), il clima di disagio provocato dalla fine della guerra fredda (La pace insopportabile, 1991), l’invasione dell’illecito a livello planetario (Il direttore di notte, 1993), gli scenari della finzione dello spionaggio nelle atmosfere centroamericane (Il sarto di Panama, 1996), gli interessi colossali dei farmaci sperimentati in Africa (Il giardiniere tenace, 2001). L’ultimo libro è dell’anno scorso: La spia corre sul campo: ambientato ai tempi della Brexit e di Trump, ritratto spietato e agghiacciante dei nostri tempi, dove nulla è ciò che appare. I tempi della guerra fredda vengono condensati nel proverbio “L’uomo che ha due donne perde l’anima. Ma l’uomo che ha due case perde la testa” posto come esergo all’inizio de “La spia perfetta”, che Le Carrè così descrive: “Tu una volta hai tradito me, ma, cosa più importante, hai tradito te stesso. Tu menti anche quando dici la verità. Anche tu hai le tue lealtà, i tuoi affetti. Ma verso cosa? Verso chi? Tu sei una spia perfetta. Ti manca soltanto una causa”. Adesso invece è consapevole della disinformazione planetaria quando rispondendo ad un’intervista affermava: “Viviamo in un’epoca di straordinario autoinganno, dove la realtà sta da una parte e la percezione pubblica della realtà esattamente dall’altra”.

Oreste del Buono, da sempre attento e appassionato indagatore e cultore di generi apparentemente “minori”, coglie l’essenza, quando scrive: “Si comincia a sospettare che lo stesso spionaggio e lo stesso terrorismo potrebbero essere per John Le Carré solo degli utili ingredienti, dei pretesti plausibili, degli strumenti d’eccezione per trattare con il maggior abbandono il suo interesse principale, fondamentale, irrinunciabile, che è semplicemente, quasi banalmente direi, l’amore”.
Una volta un vecchio generale del Mossad in pensione, disse: “Nel nostro mestiere, quando accade qualcosa, se si cerca la sua spiegazione nel cui prodest?, si può essere certi che si va nella direzione sbagliata”. E’ la lezione che si ricava da Le Carré. Il più grande, tra gli scrittori di spy story; il più lucido. Il più amaro.











