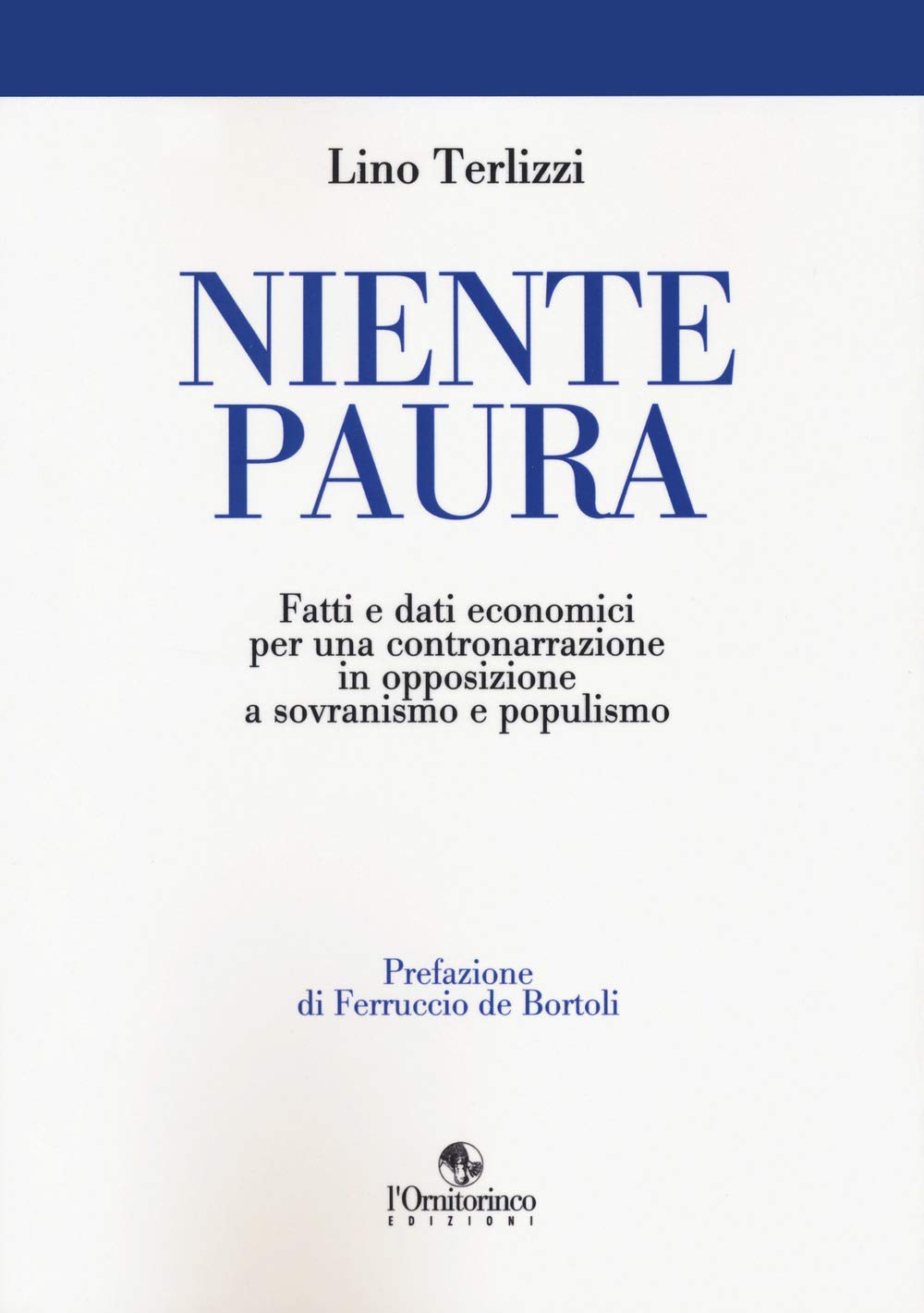 Il primo passo da compiere per fermare l’avanzata del populismo è una contronarrazione precisa basata su fatti e dati. Difficile dare ricette per curare le crisi croniche dei sistemi politici, ma nel suo Niente paura. Fatti e dati economici per una contronarrazione in opposizione a sovranismo e populismo (L’Ornitorinco, 2020) Lino Terlizzi propone una diagnosi dell’evoluzione del fenomeno del populismo nelle società occidentali, con particolare attenzione al sovranismo, il populismo di destra. Specializzato in questioni economiche, già vicedirettore del Corriere del Ticino, collaboratore del Sole 24 Ore e giornalista televisivo, nel suo libro Terlizzi racconta di come è attraverso la creazione più o meno razionale della paura nell’elettorato che i movimenti populisti sono in grado di ampliare il loro consenso, traendone importanti dividendi politici.
Il primo passo da compiere per fermare l’avanzata del populismo è una contronarrazione precisa basata su fatti e dati. Difficile dare ricette per curare le crisi croniche dei sistemi politici, ma nel suo Niente paura. Fatti e dati economici per una contronarrazione in opposizione a sovranismo e populismo (L’Ornitorinco, 2020) Lino Terlizzi propone una diagnosi dell’evoluzione del fenomeno del populismo nelle società occidentali, con particolare attenzione al sovranismo, il populismo di destra. Specializzato in questioni economiche, già vicedirettore del Corriere del Ticino, collaboratore del Sole 24 Ore e giornalista televisivo, nel suo libro Terlizzi racconta di come è attraverso la creazione più o meno razionale della paura nell’elettorato che i movimenti populisti sono in grado di ampliare il loro consenso, traendone importanti dividendi politici.
Secondo l’autore, «paura della globalizzazione, paura dell’apertura politica ed economica, paura dei cambiamenti nel mondo del lavoro, paura di chi non è come noi, paura dell’immigrazione» sono sentimenti in larga parte non realmente giustificati. Le narrazioni populiste sfidano apertamente la politica tradizionale e le correnti di pensiero novecentesche: popolarismo, socialismo e liberalismo. «Non capisco perché i liberali, i popolari, ma anche i socialdemocratici […] non rivendichino quanto ottenuto negli ultimi decenni», si chiede Terlizzi. Una risposta possibile è che questi hanno perso credibilità agli occhi di vaste porzioni elettorali. Corruzioni, ruberie e generale inadeguatezza di una parte della classe dirigente di certo non hanno aiutato a costruire negli occhi degli elettori l’immagine di un ceto politico degno di stima e fiducia.

Profondamente anti-mercato e di impronta decisamente statalista, i movimenti populisti intendono rivoluzionare il welfare system: il rischio – vista l’attitudine spesso autoritaria o quantomeno dirigista dei leader di questi partiti – è che la ridistribuzione delle risorse degeneri nell’annoso, improduttivo e parassitario assistenzialismo. Gli schieramenti populisti «mirano ad un consenso facile e quindi in sostanza dicono: spendiamo per voi, vi diamo i soldi, fa niente se il deficit e il debito pubblico aumentano», spiega Terlizzi. Per i movimenti populisti, le tematiche economiche rivestono particolare attenzione nella loro gonfia retorica spiccia e semplificatoria, ma altrettanta cura non viene adoperata nell’uso di cifre, dati e numeri, il più delle volte inesatti o manipolati a proprio favore. L’esempio più recente di quanto chiunque si appelli alla demagogia ignori le realtà oggettive è la vicenda Covid-19: semplificata, dileggiata e perfino negata all’unisono dai leader populisti in tutto il mondo, che per mostrarsi “duri” di fronte al (loro) popolo hanno contribuito a sacrificare parte del medesimo sull’altare del coronavirus, tramite atteggiamenti e parole palesemente irresponsabili.
L’abbraccio di una sorta di populismo sanitario – cioè l’uso della demagogia anche in fase di pandemia per coltivare il proprio elettorato al di là della realtà e dei fatti – si sposa perfettamente anche con l’ignoranza di molti capetti sciovinisti in termini di economia. Le banche vengono attaccate di principio dai leader populisti; l’importanza del credito bancario per famiglie e imprese viene sottostimato. E il risultato, spiega Terlizzi, è quello di buttar via il bambino con l’acqua sporca: certamente alcune banche – che nel complesso sono essenziali per il sistema economico – devono essere punite per la condotta adoperata negli ultimi anni, ma i luoghi comuni e gli stereotipi in merito andrebbero evitati.

Stesso discorso per la globalizzazione: la grande colpevole, in ottica populista, dell’impoverimento della cosiddetta gente. «La globalizzazione ha favorito la crescita economica», spiega Terlizzi che, citando l’ILO (2006-2017), illustra come ogni anno la media mondiale dei salari sia aumentata tra l’1.5 e il 3.4 per cento; in un periodo di bassa inflazione. Cosa che non è del tutto scontata al giorno d’oggi: non solo perché il livello del carovita è basso, ma anche perché seguendo le ricette economiche demagogiche dei populisti, questa verosimilmente esploderebbe. Stampare moneta – una delle cure che molti populisti intenderebbero applicare alla realtà economica del proprio paese – da una parte eleverebbe il tasso d’inflazione (che se incontrollata penalizza specialmente le classi meno abbienti), dall’altra non sarebbe sostenibile nel lungo termine (si vedano a tal proposito gli scenari venezuelani o argentini, decisamente non auspicabili).
Con l’era del populismo siamo tornati nell’ottica del protezionismo e della chiusura; la demagogia è la chiave per interpretare i fatti; il popolo viene anteposto alle élite in una ridicola dicotomia triviale, manichea e nociva per la democrazia. Democrazia messa in pericolo dall’incremento costante, in diverse realtà europee e non, dell’intolleranza e dell’Antisemitismo, il tutto mischiato con l’intenzione esplicita dei partiti sciovinisti di erigere barriere, frontiere, muri, recinti. Se è pur vero che nessuno o quasi osa pronunciare la parola “autarchia”, è pur vero che molti leader populisti di destra concepiscono il concetto di sovranità come assenza di legami e vincoli internazionali, dimostrandosi a favore di un isolazionismo in stile anni Trenta.

Capro espiatorio della retorica populista è poi l’Unione Europea, il cui mercato integrato ha avvantaggiato tutti i membri del Vecchio Continente. Bruxelles, causa di tutti i mali secondo i sovranisti, è in particolar modo accusata di essere a trazione franco-tedesca («c’è da chiedersi quale sarebbe stata l’alternativa», si chiede Terlizzi) e di ignorare le istanze popolari degli altri stati. Additare l’asse Parigi-Berlino è la prassi nell’universo dei partiti populisti europei, specialmente tra gli ex PIIGS, dove scellerati arruffapopolo demagogici se la prendono con le politiche di austerità, dipinte come nefaste per “la gente”; una scusa patetica per evitare di risolvere la micidiale assenza di rigore nei conti pubblici, culturalmente accettata in diverse realtà sociali. Tra l’altro, osserva Terlizi, «i paesi che sono riusciti a frenare debito e deficit pubblici sono anche quelli che hanno ottenuto nel tempo le crescite economiche più solide».
L’autore ha un occhio benevolo nei confronti dell’Italia, da anni laboratorio del pan-populismo europeo: purtroppo, il Belpaese non è credibile – o inaffidabile – agli occhi di molti investitori internazionali che dovrebbero finanziare il suo debito. La cura necessaria per il riavvio dell’Italia sarebbe da una parte «il taglio delle spese improduttive; l’altra via immediata è l’aumento delle imposte, ma ciò può […] ostacolare la crescita economica.» Altro che citare a sproposito il Giappone – come fanno i demagoghi più raffinati e colti – per giustificare il proprio enorme debito pubblico e l’aumento che ne deriverebbe se le dispendiose politiche populiste fossero messe in atto. Ridurre il debito pubblico è imperativo per l’Italia: non un capriccio di Bruxelles, quanto un favore «anche per gli italiani di adesso e delle prossime generazioni», perché «il fallimento o meno di uno Stato dipende anzitutto dai conti pubblici e dunque anche […] dal debito pubblico.»
Un altro capitolo interessante di Niente paura è quello legato all’identità. Terlizzi esplora le dinamiche sociologiche del populismo contemporaneo. È difatti la massima cifra dei movimenti sovranisti esagerare i grattacapi dovuti all’immigrazione. La soluzione, secondo l’autore è, come sopra, una contronarrazione equilibrata, un approccio che organizzi una convivenza sociale che non tocchi gli estremi del “tutti fuori” (destra) o “tutti dentro” (sinistra). «Integrarsi è frutto di due volontà», spiega Terlizzi, che vede il lato positivo di un’immigrazione controllata, regolata e moderata. «Nelle società democratiche l’integrazione forzata non può essere un obiettivo; lo è purtroppo in molti casi nei regimi autoritari e integralisti.» Combattere l’intolleranza è necessario e al tempo stesso gestire il fenomeno è importante per non perdere il senso d’identità nazionale. Secondo Terlizzi collegare identità è sicurezza è una forzatura; la soluzione risiederebbe nel trovare «una grande e paziente azione politica, culturale, sociale, che torni a separare le due questioni».
Infine, il populismo distorce il concetto di difesa del popolo, «identifica gli interessi di questo con le proprie posizioni politiche e indica queste posizioni, arbitrariamente, come le uniche in grado di rappresentare gli interessi popolari; […] i populisti cercano di indebolire la democrazia rappresentativa e di stabilire un rapporto tra i loro movimenti e gli elettori […] che […] tenta di aggirare la centralità delle istituzioni democratiche.» Populismo è paura del futuro, dell’ignoto: è un comodo rifugio verso il concetto astratto di nazione, di protezione, di presunta safety.












