Siamo in piena epoca di post femminismo o semplicemente il femminismo sta cambiando nome, oltre che pelle? Da New York a New York, tutto sembra giocarsi entro il perimetro della Grande Mela per quanto riguarda l’universo neo femminismo. Prima del movimento #MeToo, gravemente compromesso dai recenti fatti emersi dalle pagine del New York Times che investono frontalmente l’attrice italiana, il life style femminile era stato rivoluzionato esattamente vent’anni fa dal serie tv cult “Sex and the city”, incentrato sulla vita newyorchese di quattro amiche il cui affiatamento propone un modello femminista che immóla persino i vincoli di sangue all’amicizia dell’ultim’ora. Di tutt’altro avviso sembra il femminismo precedente di Louisa May Alcott, quello che in questi mesi compie ben centocinquant’anni assieme alle sue “Piccole Donne”, con protagonista l’aspirante scrittrice Joh March che farà fortuna, ancora una volta a New York.
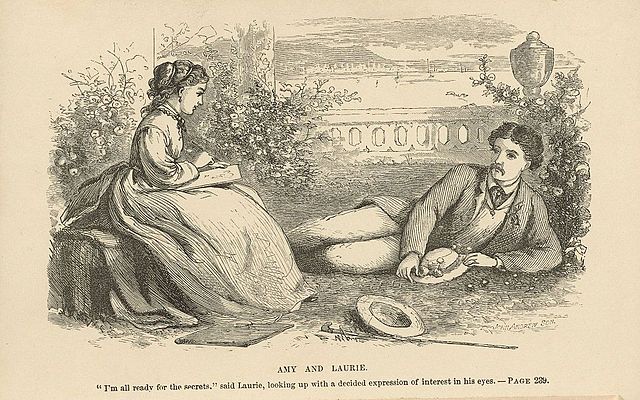
Lo stillicidio odierno dei numerosi epigoni letterari, televisivi e cinematografici del femminismo alcottiano – citiamo giusto qualche titolo a carattere esemplificativo: “Le tre sorelle” di Anton Checov e “Ragione e sentimento” di Jane Austen . Per citare solo alcuni titoli che affollano le librerie: “La custode di mia sorella” (Corbacci), “L’ Usignolo” (Mondadori), “Fangirl” (Piemme), “La vita segreta delle api” (Mondadori), “L’ altra donna del re” (Pickwick), “Le sorelle” (Tea), “La gemella silenziosa” (Garzanti), “La sorella” (Sperling&Kupfer), la saga de “Le sette sorelle” (Giunti), numeri dei quali vantano una trasposizione cinematografica. L’ultimo arrivato in termini di tempo è l’affascinante saggio “Sorelle e sorellanza nella letteratura e nelle arti” (Franco Cesati Editore).
Potremmo proseguire ulteriormente solo con i titoli più recenti, sembra benedire il rassicurante sister system, il nuovo femminismo che benedice il sincero rapporto di sorellanza, più elegantemente definito “sororità”. Proiettandoci in terra italiana è evidente altro fenomeno sospeso tra femminismo tradizionale e “sororità”: per tanto tempo si é pensato di rendere buon servigio alla questione femminile cercando di incastonare l’ unica donna italiana vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura, Grazia Deledda, in seno alle lotte emancipazioniste aderenti a un femminismo tradizionalmente inteso. La realtà dice tutt’altro. La scrittrice, prima donna italiana candidata al Parlamento, prende categoricamente le distanze dagli inciampi di quel movimento che si perde talvolta in ristrettezze psicologiche e si ripercuotono sullo sviluppo antropologico e il successo politico sociale di troppe istanze femministe.

Grazia Deledda rifiuta nettamente i due tipi antropologici studiati dalla sociologia di genere recente: la sindrome dell’ape regina e il complesso anciliare della donna rispetto alle personalità femministe di maggior carisma. Alla Deledda, in vero, non manca, dichiaratamente, la sensibilità verso problematiche e tematiche di riequilibrio di genere ma il suo femminismo ha un nome preciso: sororità. Con ogni donna cerca di trarre il bene di un rapporto sororale, quello perfetto. Quella che stiamo compiendo è a tutti gli effetti una torsione prospettica in direzione anti femminista, o meglio in direzione sororale. Il femminismo deleddiano, giova ripeterlo, non trova alcun addentellato con la dimensione collettiva della lotta femminista tradizionale. Al contrario Grazia non valicherà il perimetro di un individualismo, di un femminismo profondamente personalizzato in cui é compreso solo il rapporto diretto da donna a donna, a detrimento di un femminismo collettivo e astratto.
Il fatto antropologico che origina e orienta l’agire deleddiano è la sororità. Mai dissimulò il proprio scetticismo verso il femminismo generalista. Confidava allo scrittore Remo Branca nel 1909, all’ indomani dalla prima candidatura al parlamento del Regno d’ Italia: «Alle donne devo solo ostilità, avversità e ogni genere di biasimo. La sola gloria che la donna pare riconoscere è il dominio, ma il controllo del regno domestico, l’attesa dell’uomo sacrificato e lontano, strappato alle cure muliebri dal massacrante lavoro negli ovili o al servizio della patria in guerra». Si badi bene ad un dato cronologico di emblematica rilevanza: il manifesto dell’antifemminismo deleddiano viene pubblicato nel 1909, tre anni dopo il primo congresso del Movimento Femminista Italiano, inaugurato da Deledda e Maria Montessori. In seno allo storico congresso si affrontò il problema del lavoro, dell’istruzione, della salute e dei diritti politici delle donne. Il fatto che Grazia, dopo tre anni, se ne dica profondamente delusa induce a pensare alla maggior tendenza verso un femminismo privato, individuale, sororale, maggiormente produttivo per indole e per pragmatismo.
Di sororità, è il rapporto di sorellanza propriamente intesa, con le tre sorelle Vincenza, Peppina e Nicolina. Da un rapporto di sororità scaturisce il profondo legame con Mirella, figlia della sorella Peppina. Di sororità sarà il rapporto che intesse con Sibilla Aleramo. Stesso legame sororale visse con Matilde Serao, che dovette fronteggiare una crisi matrimoniale sfociata in tragedia. E così fu anche nel rapporto con Eleonora Duse e Maria Montessori, donne dal vissuto pubblico sfavillante e dal privato assolutamente doloroso. Il rapporto interfemminile perfetto è, per Grazia Deledda, quello sororale, quel legame antropologicamente privo di ogni antagonismo e agonismo. Ricca di saggezza sororale è la sua scelta di varcare il mare per conseguire la propria indipendenza. Rimanendo a Nuoro, nel cuore barbaricino dell’ isola di Sardegna sarebbe rimasta troppo sorella per essere madre, per essere donna, nell’ impossibilità di offrire un apporto i maturità alle sorelle amate.
Il quoziente di sororità, come noto, non è annientato dalla partenza alla volta del continente, tutt’altro, potremmo dichiarare, senza tema di smentita che il rapporto più significativo per Grazia, quello che vivrà, coltiverà e custodirà fino all ultimo dei suoi giorni sarà il rapporto di sororità in ogni sua declinazione. Come si diceva, sororale è la matrice del rapporto di maternità d elezione che Grazia nutrirà nei confronti della figlia di Peppina, la piccola Mirella Morelli. Mirella Morelli sembra uscita dall’inchiostro fantasioso di un romanzo di formazione d’epoca romantica. Così non è, ma certamente era destinata ad entrarci già dal giorno della sua nascita, nel 1922. Senza la caparbietà e la sensibilità culturale della giovane mai avremmo conosciuto i segreti più intimi dell’eroica barbaricina, virtù passata, con ogni evidenza, di madre in fill’e anima (madre putativa in lingua sarda). È di sororità, infine, come si accennava poco addietro, il rapporto che Grazia Deledda intesse con Sibilla Aleramo, al secolo Rina Faccio. Violentata all’età di quindici anni da un dipendente della vetreria del padre, Sibilla rimane in cinta. La famiglia opta per il matrimonio riparatore. Nel 1906 in Una donna Aleramo racconta la difficoltà, la vergogna per una donna separata di vivere una condizione stigmatizzata dalla società intera e costretta a vivere lontana dal suo bambino, in stato di quasi totale miseria. Grazia, sensibile a tanto dolore, decide di aiutarla, in totale anonimato, donandole una grossa somma di denaro. Che la strada femminista debba ripartire, oggi come ieri, da una più rassicurante e pacifica sororità?










