La citazione giusta, evocata al momento giusto, è come un lampo tra le nuvole delle parole. Dura poco ma illumina tutto, e spesso permette, con un tocco di originalità, di uscire dal confine verbale delle cose ripetute o che si sanno già.
Ovvio, dirà qualcuno, ma per chi qui scrive, la scoperta, anni fa, fu una specie di rivelazione.
Quella rivelazione “fu la cagion che diede inizio” alla compilazione di due dizionari che mi permetto di definire, senza arrossire, unici, insoliti e, come spero di dimostrare, utili.
Tra tutti i tipi di libri, i dizionari non richiederebbero spiegazioni di sorta, perchè sono parenti stretti delle ormai quasi scomparse pagine gialle. Ma ogni carta stampata ha la sua storia, che qui vi voglio raccontare.
In ordine di pubblicazione i due dizionari sono, rispettivamente,
- “Your Daily Shakespeare – an Arsenal of Verbal Weapons to Drive your Friends into Action and your Enemies into Despair”
- “Il Nostro Dante Quotidiano – 3500 Modi di Cavarsela con Dante”.

Ritornando alla storia… nonostante erudite asserzioni al contrario, ritengo che il corso della vita sia dettato dal torrente della sorte. Anche se è pur vero per tutti che, volgendosi indietro agli anni nostri, è possibile scoprire le trame del come e del perché la nostra vita è stata quello che è.
Nella fattispecie, il sottoscritto, dopo aver studiato il greco per cinque anni e il latino per otto, dovette constatare che potenziali datori di lavoro erano sommamente indifferenti alle lingue morte.
Nel frattempo il governo italiano aveva fatto spargere la voce che l’Italia aveva bisogno di tecnici. Ed io, con un’ingenuità che adesso mi appare abissale, ci ho creduto. Col risultato che ho finito per prendere una laurea in ingegneria.
Dopodiché, intrapresa la via indicata dallo studio, prima ho lavorato qui a Portland, Oregon con una multinazionale, la quale mi spedì prontamente in Europa. Il mio lavoro consisteva nello sviluppare l’infrastruttura logistica e l’apparato di distribuzione e di vendite in Europa, Medio Oriente ed Africa.
Dovrei dire marketing manager, ma è termine di manica larga, perchè può indicare un buon pieno, ma anche un gran vuoto.
Ero continuamente in viaggio, e il “tempo morto” in trasferta diventò una grande opportunità per leggere.
Per di più, nelle frequenti consultazioni in sede, osservavo il progresso, quasi inarrestabile, di un linguaggio comune che ha persino acquistato un nome, il managerese. Che include sia l’esprimere concetti semplici con paroloni altisonanti e complicati giri di frase, o usare la stessa tecnica per confondere o nascondere significati più sospetti.
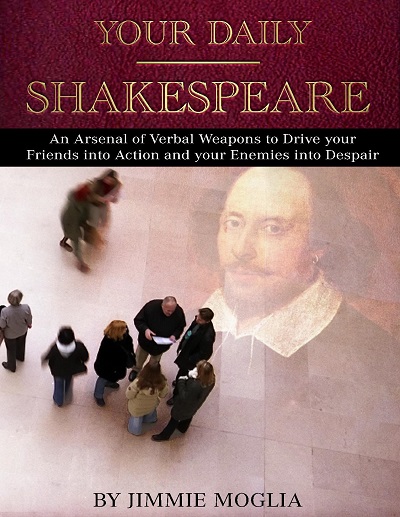
Comunque sia, durante un lungo viaggio, leggendo “King Richard III” di Shakespeare, mi colpì una domanda che Richard pone al reticente Stanley sulla situazione militare del momento. Stanley risponde in linguaggio criptico e simile all’odierno managerese. Al che Richard, irritato, esclama: “what need’st thou run so many miles about, when thou mayst tell thy tale the nearest way?” [Perché prendi una strada così lunga (per rispondere), quando potresti esprimerti nel modo più diretto?]
Letterariamente, o dizionaristicamente parlando, questa frase fu l’equivalente della visione di Paolo sulla via di Damasco. Perché era proprio la domanda che rifletteva la mia reazione ai discorsi in managerese, a cui mi stavo involontariamente abituando.
Ci deve essere – mi son detto – un dizionario di Shakespeare che elenca le citazioni, in corrispondenza non alle rispettive commedie e tragedie, sonetti e poesie, ma alle situazioni in cui il proverbiale uomo qualunque può imbattersi quotidianamente.
Messomi alla ricerca, dovetti presto concludere che tale dizionario non esisteva. O meglio, l’unico lavoro che potesse considerarsi un’approssimazione, era un volumetto, trovato in un negozietto di libri antichi a Londra, vicino al British Museum – compilato da un certo Thomas Dolby e stampato nel 1832.
Però …. era scritto in font numero 6 ed era carente non solo di consigli d’uso, ma anche di riporti a citazioni correlate. Non aveva l’importante indice analitico, né conteneva un riferimento al contesto storico, o alla trama in cui le citazioni appaiono nell’originale di Shakespeare.
Ricordandomi sorridendo di Oscar Wilde, “When I want a good book to read… I write it,” intrapresi il lungo cammino (15 anni) che si concluse con la pubblicazione di “Your Daily Shakespeare.”
Vi lavoravo durante i viaggi e nei week-ends. L’ostacolo più ostico, per me, non è stato tanto il contenuto quanto la struttura del dizionario. Infatti, quando era quasi finito, ho dovuto essenzialmente riscriverlo per adattarlo al formato che ritengo più utile per l’utente-lettore.
Sicché l’edizione finale contiene, per ogni voce:
- La situazione
- La citazione
- Consigli d’uso e riferimenti ad altre citazioni correlate ma con “nuances” un po’ diverse
- Descrizione del contesto in cui i versi appaiono nell’originale di Shakespeare
- Ampio indice analitico con più di diecimila voci
- Trama di tutte le commedie e tragedie di Shakespeare
Ma, continuando con la storia, dopo qualche anno in Europa ritornai a Portland. E qui, in un momento di ottimismo, timore, stravaganza e sregolatezza, ho fondato una ditta di sviluppo di hardware e software, che ho poi condotto per 25 anni.
Visto come “Your Daily Shakespeare” era stato ben accettato, decisi di compilare un dizionario simile in impostazione e stile per la Divina Commedia di Dante.
Venutone a sapere, il Governo della Toscana me ne commissionò il completamento. E da qui nacque, “Il Nostro Dante Quotidiano – 3500 modi di cavarsela con Dante.”
Ho creato un’animazione per dare un’idea del libro, ma tanto per mettere nero-su-bianco, cito qualche esempio a caso:
- Logica, l. applicata
Forse tu non pensavi ch’io loïco fossi! (Inf. XXVII, v.122)
Consigli d’uso. Quando la parte avversaria è sorpresa dalle tue deduzioni.
Nell’originale. Con un ragionamento logico, un diavolo persuade San Francesco che l’anima di Guido da Montefeltro merita l’inferno. Con diabolico sarcasmo, il diavolo si dichiara un logico (loico) al neo-dannato.
- Libro, l. o documento perverso
La bocca mi baciò tutto tremante,
Galeotto fu il libro e chi lo scrisse:
quel giorno più non leggemmo avante. (Inf. V, v.137)
Consigli d’uso. Quando un’informazione, un annuncio, un certificato, etc. hanno causato un tuo errore, “Galeotto fu il certificato e chi lo scrisse.”
Nell’originale. Fu la lettura di una storia d’amore a ispirare la passione reciproca di Paolo e Francesca.
- Insulto, testa di c.
… lo membro che l’uom cela. (Inf. XXV, v.116)
Consigli d’uso. Trasforma in epiteto letterario una comunissima e frequente attribuzione, “E’ una testa del membro che l’uom cela”.
Nell’originale. Siamo nel settimo cerchio, dove uomini si trasformano in serpenti e viceversa.
- Passo, necessità di accelerare il p. prima che sia buio
«Lo sol sen va», soggiunse, «e vien la sera;
non v’arrestate, ma studiate il passo,
mentre che l’occidente non si annera». (Pur. XXVII, v.62)
Consigli d’uso. Esortazione ad accelerare il passo durante una passeggiata sul finire del giorno. O osservazione poetica sul tramonto.
Nell’originale. Un angelo invita Dante e Virgilio, accompagnati dal poeta Stazio, ad affrettare (studiate) il passo prima che sia notte buia (l’occidente non si annera). Dante e compagnia devono attraversare le fiamme che occupano il settimo girone.
- Fatica, f. iperbolica
… piuma sembran tutte l’altre some (Pur. XIX, v.103)
Consigli d’uso. Caratterizza un’enorme fatica.
Nell’originale. La soma al cui confronto tutte le altre sono piume è quella di tenere il papato – almeno così afferma Papa Adriano V, che fu Papa per trentotto giorni nel 1276.
…. Ahimè non è finita. E’ bello trovare facilmente le citazioni cercate, ma non sarebbe altrettanto bello potersele ricordare, con metodo divertente e utile, non solo per le citazioni, ma anche per esercitare la memoria? La quale, a detta degli esperti, si comporta come un muscolo, e più è esercitata, meglio funziona?
Come affrontare il problema? Nella cantina della mente avevo riposto un’idea che ogni tanto riaffiorava spontaneamente quasi senza pensarci sù – vale a dire l’importanza del bello nell’arte dell’apprendimento in generale, e della memoria in particolare.
Mi spiego. Al liceo, come altri studenti, avevo avuto difficoltà ad apprendere certi concetti astratti, per esempio in filosofia. Ma in una sezione che non era la mia, c’era un professore che aveva inventato quella che definiva la pittura filosofica.
Il suddetto professore, Emanuele Gennaro, letteralmente dipingeva concetti astratti traducendoli in immagini. Alla radice del mio progetto c’era (c’è) un’idea talmente radicata nella mente di tutti che quasi fa parte del nostro DNA – ma nello scorrere, nelle necessità, o nel bailamme della vita di tutti i giorni non ci pensiamo. Tuttavia, basta qualche attimo di riflessione per riconoscere che idee in apparenza astratte, hanno alla loro radice un’immagine.
Esempio banale. Ognuno di noi sa bene la differenza tra l’onestà e la disonestà – o tra l’onestà e la furberia. Se proviamo a definire il concetto, possiamo utilizzare un giro di parole o un esempio. Ma se vogliamo andare più a fondo, come fanno lessicologi, semiologi, e studiosi della storia delle lingue, si raggiunge al limite il confine tra il significato e l’immagine (o il suono) che lo rappresenta.
Chi non è convinto dalla precedente sommaria, e quindi carente, spiegazione, basta che osservi le bellissime immagini nelle chiese medievali – o le spettacolari miniature della stessa epoca. E’ vero, a quei tempi, si trattava di spiegare concetti e idee a chi non sapeva leggere. Ma alla radice il processo è il medesimo – vale a dire, la conversione di un’idea astratta in un esempio non solo visivo, ma anche e soprattutto, attraente. Persino Shakespeare conferma l’idea che il sapere è intimamente collegato al piacere del conoscere. In “The Taming of the Shrew,” due amici discutono su cosa studiare e uno dice all’altro: “no profit grows where is no pleasure taken”.
Da qui è nata l’idea dell’applicazione software “Mnemonic Frames”, che permette a utente di memoria media di memorizzare facilmente (e lo dico senza esagerazione), moltissime citazioni. Nel caso, mi riferisco a Shakespeare e Dante, ma il metodo è estensibile a discipline letterarie e scientifiche.
Tra la serie dei videos storici che produco per una stazione TV locale e anche per vari colleges, uno descrive la genesi e il nocciolo dell’applicazione “Mnemonic Frames”. In poco più di 25 minuti è impossibile comprimere una ricerca le cui radici mi riportano al tempo del liceo. Ma spero, col video, di aver reso l’idea.
E nello spirito delle “Mnemonic Frames,” ho anche creato un’applicazione che, a mio avviso, celebra il matrimonio tra il libro stampato e l’Internet.
I dizionari di Shakespeare e Dante, le “Mnemonic Frames”, la loro applicazione agli smartphone, appartengono o fanno parte, a loro volta, di un altro progetto che, anche questo, da tempo avevo riposto nella cantina della memoria, sempre con l’intenzione di riprenderlo.
Leggere, scrivere, estetica e musica sono correlati – anzi, in un certo senso appartengono alla stessa famiglia. Quasi tutti siamo d’accordo che le parole hanno, o possono avere, un ritmo. E una caratteristica del “buon scrivere” è il ritmo che il lettore percepisce quasi senza accorgersene, ma che mobilita la sua attenzione.
Il rapporto tra parole e ritmo è evidente nella poesia – dove la correlazione assurge quasi al livello della musica. Entrambi, poesia e musica, sollevano lo spirito portandolo negli spazi lontani della mente.
Il lettore forse si ricorderà di aver letto o sentito qualche volta l’espressione la musica delle parole. Chi ha osservato o usato l’espressione, dimostra, senza lunghe spiegazioni, un’importante realtà – che l’estetica, nel senso più ampio del termine, accomuna parole, musica e immagini.
E l’idea non si limita alla letteratura. Per esempio, quelli che dicono, “A me non piace la matematica,” esprimono due verità in una frase sola – la prima ovvia, la seconda è implicita, sta dietro le quinte, ma è evidente quando esposta.
Il piacere cui l’espressione non mi piace la matematica si riferisce, è il piacere dell’estetica. O meglio, il non aver trovato l’angolo estetico tale da rendere il soggetto appetibile.
Nei miei esperimenti, per interesse personale, e senza alcun ombrello accademico, ho potuto constatare più volte la verità dell’assunto.
Ho cercato di far conoscere le mie ricerche nel mondo accademico, ma per i pochi capitani dell’erudizione che ho potuto contattare sono un servo della gleba, un “vile meccanico” come diceva il Manzoni, e – come tale – indegno di attenzione.
Il che m’importa poco, anzi niente. Certo mi piacerebbe poter contribuire, in qualunque piccola misura, a fare dell’estetica il fulcro e il sistema portante dell’educazione.
Tuttavia, e molto più terra-terra, mi bastano i commenti e le lettere inviate da studenti che hanno usato con successo i miei dizionari, sia di Shakespeare che Dante – lanciando una freccia poetico-verbale al momento giusto e lasciando l’insegnante allibito e sorpreso all’inaspettato potere espressivo dello studente. E… più raramente commenti positivi persino da professori, tipicamente in università straniere.
Il sito “Your Daily Shakespeare” contiene tra l’altro, più di 500 articoli e saggi su argomenti del momento, dove l’idea è di incorporare i principi di quanto detto sopra. Ce n’è da far addormentare anche il lettore afflitto dalla più invincibile insonnia.
Ma ritornando ai dizionari, e agli autori che li hanno ispirati, leggere Dante in italiano o Shakespeare in inglese ha un effetto simile a quello della musica classica. Non è necessario conoscere i principi dell’armonia per gustare la musica o capire perché un brano o una serie di accordi suscitano questo o quel tipo di emozioni. Ci si accorge del bello senza bisogno di spiegarlo.
Infine, intercalando giudiziosamente Dante (e Shakespeare) nella conversazione, o talvolta nel testo, anche in comunicazioni cosiddette ufficiali, è come spargere il parmigiano dell’originalità sulla pasta del già scritto, ripetuto, detto o sentito.









