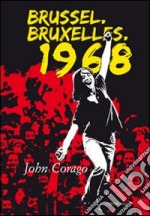Il libro dell’amico John Corago, edito da Cantagalli con il titolo Brussel, Bruxelles, 1968 camuffa, sotto la storia del rapporto tra un padre emigrato da Letojanni e il figlio che lo raggiunge in Belgio grazie alla borsa di studio per l’università di Bruges, l’indagine psicologica e morale sulla situazione giovanile di chi, nato a cavallo del 1950, si trovò nel mezzo dell’esplosione della contestazione. Nel ‘68 eravamo compagni di banco all’università, Corago ed io: la lettura del libro è stata un viaggio psichico a ritroso, dentro una dimensione, e una gioventù, dissoltisi nel tempo.
Il romanzo inizia con l’arrivo di Nico alla stazione di Bruxelles: ad attenderlo papà Carmelo, minatore e sindacalista militante, riferimento per tanti emigrati siciliani. Nel dialogo tra i due si inserisce Karin, viennese borghese e delicata che Nico incontra e ama. I moti studenteschi di quell’anno rappresentano la cornice dentro cui si dipanano l’affetto tra i due uomini e il romanticismo dei ragazzi, fino a divenire l’elemento di confronto e contraddizione tra i personaggi. La solida formazione sindacale e politica della classe lavoratrice, e in particolare di Carmelo che ne è leader, si scontra col velleitarismo tuttovolente e parolaio dei giovani contestatori. Nico, istintivamente unito ai coetanei ma con ben altra biografia alle spalle, si chiede se debba rompere col padre granitico nelle sue convinzioni e con la fidanzatina moderata.
Bruxelles, luogo fisico nel quale si snodano le situazioni, nonostante il romanzo ne indichi piazze e strade, chiese e musei, risulta come sfocata, categoria psichica più che concreta indicazione geografica. L’autore sembra volerla caricare di valori e simboli, in qualche modo collegati alla nascente vocazione di capitale europea, luogo di sintesi e auspicate soluzioni. Nel dipanarsi degli eventi, i protagonisti maggiori si lasciano coinvolgere negli accadimenti, anche drammatici, sviluppati dalla trama. Trovano, nel sommovimento sociale nel quale sono trascinati, opportunità insospettate per guardarsi dentro e confrontarsi con le proprie certezze. I due giovani consolidano, nella lotta politica e sociale alla quale partecipano a modo loro, il rapporto che li lega. Nico sperimenta il bello del compromesso con il padre classe operaia e la ragazza borghesia conservatrice perbenista. Carmelo scende a patti coi propri dogmi.
A quelli della mia generazione, le 400 pagine di Corago daranno nostalgia e rammarico. La nostalgia verrà dalla sensazione di essere risospinti in un universo di atmosfere e stili di vita lontani molto più dei 45 anni di calendario. Il rammarico verrà con la consapevolezza che ben pochi dei sogni e ideali che si ebbero come generazione, sono stati trasformati in realtà. Il che è vero soprattutto con riferimento all’Italia, per come le cose della politica e del sociale si sono aggrovigliate non lasciando quasi spazio alla speranza.
Nel romanzo di Corago, l’Italia del ’68 è soprattutto quella dei paesini da dove la gente emigra nella nascente Europa unita, e della bellezza di arte e natura che Karin viene a godersi al braccio di Nico. Come il giovane personaggio del romanzo, molti di noi “studiavano”, viaggiavano per avventura e conoscenza, si dedicavano a metter su un mondo migliore. Altri, violenti o debosciati, profittavano dei venti di libertà per darsi a droghe, sesso idiota, occupazioni distruttive. I primi, attraverso i libri e il viaggio, divennero adepti della bellezza, dell’arte e della solidarietà umana. Almeno quell’eredità dovrebbe sopravviverci.