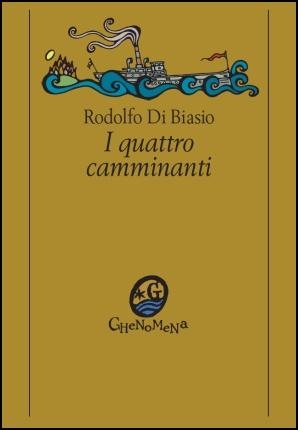Settantacinque anni, per un poeta, sono una bella età. Un tempo si diceva un’età veneranda. Se poi il compleanno coincide con un altro anniversario – venticinque anni di collaborazione ad “America oggi” – allora il modo migliore per formulare gli auguri a Rodolfo Di Biasio consiste proprio nel ricordarne l’opera su queste pagine. A partire, naturalmente, da «I quattro camminanti», il romanzo che narra le vicende di quattro fratelli emigrati in America all’inizio del Novecento.
Il loro viaggio è una fuga dalla fame e dalla miseria inscritte nel duro lavoro dei campi. E’ anche un percorso di formazione che addestra l’uomo alla prova della separazione. E l’America è il posto in cui un destino diverso è ancora possibile a patto che si abbia il coraggio di affrontare lo strappo dalle radici. Di qua restano i confini del mondo conosciuto, il paese coi suoi siti e i suoi riti, con le sue parole screpolate in forma di proverbio, con la rassegnazione di chi la sventura se la porta nel sangue. Di là la possibile evasione, il sogno che si allarga guardando il mare. Nel paese la fissità del tempo, in America la rottura del sortilegio. Scrivendo «I quattro camminanti», Di Biasio ha voluto sottolineare il valore affettivo delle radici. Un valore, anche moralmente, così sentito che ognuno dei personaggi diventa un narratore, uno che ascolta e che racconta per creare un reticolato di amorosi sensi che “passano” dai genitori ai figli e da un fratello all’altro e dai figli alla madre e da questa all’intera comunità del paese di partenza. Le parole, dette oppure scritte nelle lettere, costituiscono un ponte che varca la vastità dell’oceano e congiunge e riunisce chi era stato separato dalla prepotenza degli eventi.
Si incontra, in questo romanzo popolato da uomini viaggiatori, una straordinaria figura femminile, Paolina, la madre dei quattro camminanti, che a tratti ricorda Maruzza Malavoglia. Quando i suoi figli si allontanano dalla casa è come se membra vive del suo corpo si staccassero da lei. Ma ella possiede la saldezza delle piante che affondano radici in una terra che non si smuove. E proprio lei troverà nel racconto la via migliore per tener viva la memoria dei figli lontani:
.jpg)
In foto, Rodolfo Di Biasio
“Nonna Paolina, quando già il nonno Pasquale era morto e molti di noi nipoti o non l’avevano visto o non lo ricordavano più, avrebbe poi raccontato tutto questo negli anni subito dopo la guerra, d’inverno quando tentavamo di vincere il freddo”.
Nell’opera di Di Biasio il tema del legame con la terra natale costituisce una costante tematica, come pure i riflessi della guerra sulla vita familiare, la memoria del passato e la proiezione verso un futuro incerto. Sono i grandi temi che attraversano le raccolte di racconti, da «Il pacco dall’America» a «La strega di Pasqua», corde capaci di tenere insieme un mondo di cose da salvare prima che sia troppo tardi. Rodolfo Di Biasio, oltre ad una intensa attività critica esercitata attraverso le numerose collaborazioni a giornali, a riviste letterarie, alla RAI e culminata nella redazione di un imprescindibile saggio sulla figura di Giuseppe Bonaviri, ha intrecciato alla scrittura in prosa una intensa, concentrata produzione poetica.
Fin dalle prime raccolte di versi – «Niente è mutato» (1962), «Poesie dalla terra» (1970), «Le sorti tentate» (1977) – il paesaggio dell’infanzia e dell’adolescenza, le case di pietra e i vicoli aguzzi di un paesino del basso Lazio provato dalla guerra si caricano di riflessioni esistenziali. Le ore del giorno e gli eventi privati convergono verso indagini che preannunciano approfondimenti metafisici. Ma è nel 1995 che Rodolfo Di Biasio dà alle stampe «Patmos», il punto più alto della sua ricerca poetica. Qui, al centro della riflessione c’è l’inadeguatezza del poeta, la sua insufficienza a comprendere il tutto. E’ una violenta epifania che lo assale durante un’escursione all’isoletta nel mar Egeo. La poesia tenta l’irta strettoia dell’analisi. Ecco allora esplodere, fin dall’incipit, una potente vertigine: le coordinate spazio-temporali, dapprima ristrette e concentrate nell’“hic et nunc” di una determinata spiaggia, quella di Patmos, in una determinata sera, all’improvviso si dilatano a dismisura per coprire arcate temporali di portata secolare. Dall’avventura di Ulisse, tremila anni fa, al nostro presente. Il disorientamento provocato da questa inaspettata dilatazione millenaria esprime lo smarrimento dell’uomo di fronte al mistero dell’esistenza, la sua incapacità di afferrarne il senso.
La frattura aperta tra l’uomo e l’universo è nella inconciliabilità degli alfabeti, quello del mare che urla la sua rabbia cosmica e quello dell’uomo, non più preparato ad ascoltarla. Quando l’armonia è perduta e ogni sforzo per ritrovarla è destinato a configurarsi come doloroso vagheggiamento, nostalgica ricerca di un eden, il poeta guarda al presente e constata che è impossibile allacciare con esso relazioni piene di significato.
Ciò che avevamo guadagnato grazie alla solida e feconda eredità dei padri è andato perduto e non riusciamo a intravedere la traiettoria che ci possa guidare: “Forse perché più non parliamo / o se crediamo di parlare / ci facciamo remoti bozzoli / chiuse conchiglie / Ci condanna al silenzio / l’usura di un polverio di voci / senza radici e scopi”.
I vivi, i morti, i superstiti, le ore del giorno, le stagioni dell’anno e le annate della storia, tutto in un eterno, circolare rincorrersi. La natura custodisce i segreti che l’uomo cerca da sempre, ma li svela a suo modo. Il mistero della nascita, per esempio, luminosa apparizione dell’essere nel flusso infinito del tempo. Oppure l’enigma delle corrispondenze tra l’attimo e l’eternità: l’istantanea, ultima vibrazione della foglia prima di morire e l’incommensurabilmente lento moto dell’universo. In mezzo – tra questi due estremi – la vita dell’uomo costellata di scelte e di accidenti, gli eventi prefigurati, in qualche modo perseguiti e voluti, e le sortite del caso, disordinate e imprevedibili: “Ancora inverno: / il puntuale inverno / e il suo grido di muschio / E’ più fermo questo: / come più ferma la pena del passero, / il suo sonno in desolate radure / Dai pozzi nei piovaschi / altre stagioni / o tracce ingrigite / di sortite improbabili / Null’altro / in questo spoglio silenzio / Batte qui il sangue i suoi labili segni / e s’addentra l’anima / procede sempre più sola / tenta essa / la regione inarrivabile del puro”.