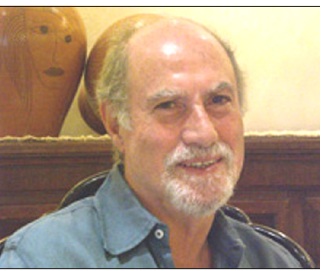Un raffinato gioco letterario e intellettuale il nuovo libro di poesia di Luigi Fontanella, docente alla State University di New York: «Bertgang. Fantasia onirica» (prefazione di Giancarlo Pontiggia, postfazione di Carla Stroppa; Moretti&Vitali, Bergamo 2012, pp. 89). Già dal titolo si rivela per quel gioco di specchi che è. “Bertgang” in tedesco significa “colei che risplende nel camminare” (da “bert”, rilucere, e “gang”, andare). È il cognome di una persona che si chiama Zoe, parola che in greco significa “vita”. Zoe Bertgang è un personaggio-chiave della novella di Wilhelm Jensen, «Gradiva. Fantasia pompeiana», che Freud ha analizzato nel famoso saggio, «Delirio e sogni nella “Gradiva” di Jensen». “Bertgang” a sua volta si pone come traduzione tedesca di “Gradiva”, che significa “colei che avanza”: questo è il nome che Norbert Hanold, il protagonista del racconto di Jensen, dà alla figura di un bassorilievo che sta studiando, e a una donna che crede di vedere negli scavi di Pompei, abbigliata anticamente e in quella stessa posa, con la mano che solleva un lembo della lunga veste, mentre attraversa una strada, nell’ora in cui il sole è allo Zenit. Il personaggio racchiude quindi Bertgang-Gradiva (“Ah Gradiva, Zoe, Gradiva!” si legge a p. 52), con quel procedimento che si chiamerebbe, nel lavoro onirico, “condensazione”. Tema senz’altro accattivante per Fontanella stesso, autore di «Controfigura», romanzo dedicato al tema del doppio.

la copertina di «Bertgang»
Il gioco di specchi meta-letterario, che caratterizzava il romanzo, si ritrova in questo poema (poema narrativo o racconto-in-versi), «Bertgang», appunto, nel quale Fontanella si pone a valle degli scritti e di Jensen e di Freud, per riscrivere in versi la storia di Jensen filtrata dallo sguardo di Freud, alla fine di una filiera che va dalla scrittura in prosa a quella saggistica a quella poetica, a dimostrazione ulteriore del “continuum” che è la scrittura stessa (e ne è dimostrazione anche l’edizione del libro, nel quale il poemetto è teso tra l’analisi letteraria del prefatore e quella appassionatamente tecnica della postfatrice). Il gioco di specchi riguarda dunque anche i generi letterari, e si complica ulteriormente con il “romanzo familiare” dell’autore Fontanella: Bertgang-Gradiva è anche la propria donna, alla quale è dedicato il libro, e che viene colta nell’atto che contraddistingue la Gradiva (“a Irene, che un giorno vidi passare in una strada di St. Louis”); e Fontanella non dirige da anni una rivista che si chiama “Gradiva”? Il che la dice lunga sul significato di nuovo confronto con se stesso che il libro assume per l’autore.
La complessità dei riferimenti è sciolta agevolmente dalla mano del poeta, tanto che Pontiggia, nella prefazione, sottolinea come di (eventuali) pesantezze teutoniche non ci sia più nulla in Fontanella, il cui lavoro viene piuttosto ricondotto alle atmosfere, francesi, dei «Contes et récits fantastiques» di Gautier. Più un Octavien che un Norbert, dunque. Con grazia alata, nonché con un’ombra di mistero, si apre il poemetto di Fontanella: “Nella breve ora degli spiriti / una giovane ragazza uscì di casa / e si diresse con passo rapido e leggero / verso la dimora di Meleagro. Qui giunta / scomparve come d’incanto / fra le colonne della corte” (p. 23).
Il senso di leggerezza è sottolineato dalla presenza di una “graziosa farfalla” che svolazza intorno alla ragazza. Se qui la farfalla, come è Fontanella a ricordare in nota, è la messaggera dell’Ade che viene a richiamare lo spirito nell’oltretomba, il suo volo e la leggerezza che suggerisce sembrano ripresi, nella stanza successi va che rappresenta un flashback narrativo, dal cinguettio d’un canarino, che chiuso in gabbia, anela al proprio volo. Il fatto che tale canto costringa lo studioso a sollevarsi dai suoi libri, per affacciarsi alla finestra da cui vede una donna che ricorda la Gradiva (cosa che lo spinge al viaggio), non può non far venire in mente, a un lettore italiano, l’“Elogio degli uccelli”, testo centrale nelle «Operette morali» di Leopardi, che così comincia: “Amelio filosofo solitario, stando una mattina di primavera, co’ suoi libri, seduto all’ombra di una sua casa in villa, e leggendo; scosso dal cantare degli uccelli per la campagna”, lascia la lettura e inizia a scrivere che essi, gli uccelli, sono “naturalmente le più liete creature del mondo”: Leopardi auspica un pensare e uno scrivere che ne sappiano imitare il volo.
Il passo di Fontanella è: “[…] Annoiato / e saturo dopo lunghe ore / piegato sui miei libri / una mattina udii fuori dalla finestra / il cinguettio d’un canarino / rinchiuso in una gabbia (come lo ero io fra carte e documenti) / che solo con il proprio canto / lanciava al mondo l’innato / impulso a fuggirsene dalla sua prigione” (p. 24). Questo per sottolineare l’ascendenza tutta letteraria dell’ispirazione di Fontanella, ma anche dell’essenzialità di uno sguardo fatto nuovo. Il Norbert di Fontanella osserva poco dopo: “Colsi un ramo d’asfodelo / pensando quanto inutile / fosse tutto il mio sapere / e quanto indifferente il mondo ad esso” (p. 26).
Dal pensiero al sogno, e quindi all’arte. Fontanella, come dichiara egli stesso, ha inteso condurre “un esperimento anche e soprattutto linguistico (riprodurre in poesia, con un proprio ritmo, l’aura magica e ‘remota’ nella quale si svolge la vicenda narrata da Jensen e così acutamente ripercorsa da Freud) […]” (pp. 63-64). Il ritmo è scandito da un certo gioco metrico e da rime anche nascoste, così come, in modo più accentuato che altrove, si può notare già in I,2, quindi quasi all’inizio: “Tanto era la strada che avevo fatta / dalla mia città a quella contrada / da me tanto amata per pura / passione di dottrina. Annoiato / e saturo dopo lunghe ore / piegato sui miei libri” ecc. (p. 24): la
sottolineatura nostra serve a indicare le rime, o quasi-rime, o assonanze che concorrono a dare questo ritmo e quest’aura particolare; ancora da segnalare, l’uso del verbo talvolta in fine di proposizione e al contempo di verso: “di dolore se solo aria avessi toccato / di spavento se corporea l’avessi constatata” (p. 31).
Il riferimento qui è al “sentimento ambiguo” che pervade il protagonista, desideroso di toccare la mano della donna che gli è apparsa. L’aura particolare, sul piano contenutistico nonché delle figure retoriche, è infatti poi riconsegnata al lettore proprio in questa ambiguità, nel confine incerto tra dimensione reale e onirica: parlando dell’apparizione a Pompei, Fontanella scrive, ossimoricamente, di una “pura / immagine di sogno ma reale” (p. 27).
Di seguito, la presunta Gradiva, dice di chiamarsi invece Zoe: anche qui, a conciliare gli opposti, la persona morta si chiama invece Vita. E ancora Norbert le chiederà: “O fragile Figura, vivi o / immagine sei della mia illusione?” (p. 31; più avanti, a p. 49, un’altra espressione di questa ambiguità: “Vano sogno dunque il mio e solo vera / la mia follia […]”). Anche l’insistito ricorso all’“ enjambement” dà il senso di sospensione di giudizio, nonché di respiro, di fronte all’enigma.
“Enjambement” che troviamo ancora a stringere e strappare dall’abbraccio una coppia vittima dell’eruzione di Pompei.
“Una giovane coppia di amanti / di fronte alla catastrofe / si era stretta in n ultimo / abbraccio… guardi, questo è un fermaglio / raccolto nella cenere accanto alla ragazza” (p. 35): così come Norbert è informato dello “sfaccendato proprietario” di un locanda che sorge vicino agli scavi e che non a caso, in questa novella dell’ora meridiana, si chiama “L’Albergo del Sole”.
Il fermaglio è forse proprio quello di Gradiva ed è lei dunque la ragazza incontratasi con l’“amante amato” e morta in quel 79 d.C.? Da un incubo notturno, nel quale Gradiva è intenta ad afferrare con un filo d’erba usato come laccio una lucertola, Norbert è destato, di nuovo, dal canto d’un uccello (qui, sulla pagina, tra sogno e realtà, s’incontrano anche “terrestre”, la lucertola, e “celeste”, l’uccellino). Insomma, tutto l’intreccio sta a dimostrare come la Zoe rimossa torni nelle spoglie di Gradiva, la cui presenza arpiona quel lontano ricordo caduto nell’oblio: ciò significa, per dirla con l’exergo riportato da Orazio in apertura, che la natura, pur ricacciata, si ripresenta; cosa che Fontanella ribadisce anche con diretto ricorso al freudismo: “Rimozione / non è dissoluzione del ricordo” (p. 57). Sia Pontiggia in apertura, che Stroppa (che muove poi in direzione di Jung) in conclusione se la prendono con Freud accusato di voler razionalizzare l’emozione: emozione che Fontanella sa di nuovo restituire. Osservazione giusta: va tenuto conto però che Freud è stato anche capace, e questo “è” la psicoanalisi, di svelare l’emozione che sta dietro la ragione. In un movimento circolare, da Jensen (emozione, letteratura) a Freud (ragione, scienza), Fontanella, che non sembra invece voler prendere distanze da Freud, ci riconduce felicemente all’emozione iniziale.
Nello stesso tempo, tra asfodeli, papaveri, rose rosse sorrentine, torna con la psicoanalisi ai suoi esordi come studioso del surrealismo: il tempo (tema fontanelliano), come nel sogno, viene annullato, o almeno sospeso…