«Scusa Provenzali, soltanto dieci secondi per dire che quella che ho appena tentato di concludere è stata la mia ultima radiocronaca per la Rai, un grazie affettuoso a tutti gli ascoltatori, mi mancheranno». L’ultimo spettacolo prima del sipario fu la partita di campionato Cagliari-Parma, giornata conclusiva del campionato 1995-96. Vinsero i sardi 2-0, ma nessuno se la ricorda. Gli applausi, in quello stadio e idealmente in ogni altro stadio, furono solo per Sandro Ciotti che andava in pensione. Fine di un’epoca, fine di un’emozione.
Improbabili colletti a punta venuti dagli anni ’70, cravatte a tinta unita, scarpe sempre fresche di lucido. Eleganza vintage e faccia da pugile, capelli radi pettinati all’indietro: Ciotti aveva uno stile inconfondibile condito da ironia e cultura. Colpiva immediatamente quella voce roca – il marchio di fabbrica – che era una passata di cartavetrata sui muri delle nostre case. E’ stato per tutti The Voice, come l’amatissimo Sinatra. Le sue corde vocali grattugiate hanno rivoluzionato la radio. Erano state scalfite nel ‘68 da un edema, dopo 14 ore di diretta sotto la pioggia alle Olimpiadi del Messico. Lui ci aveva messo il carico da undici, non rinunciando ai due pacchetti quotidiani di sigarette americane senza filtro. Oggi ricorrono vent’anni dalla sua morte, le radioline a transistor sono un residuato bellico eppure nessun italiano può fare a meno di ricordarlo ascoltando Tutto il calcio minuto per minuto.
Di quel programma immortale, punto fermo della domenica pomeriggio, Ciotti è stato la trave portante assieme a un gruppo di colleghi eccezionali. Una confraternita di fuoriclasse, lui più di tutti. Eppure la vocazione da ragazzino, malgrado l’esempio del padre Gino giornalista, pareva un’altra. Nato a Roma nel ’28, padrino di battesimo il poeta dialettale Trilussa, si era appassionato alla musica. Allievo al Conservatorio di Santa Cecilia, prendeva lezioni di violino da Corrado Archibugi, membro dell’orchestra di Toscanini e insegnante di Claretta Petacci, prima che lei diventasse l’amante del Duce. Ma il richiamo del pallone si faceva sentire forte. Il giovane Sandro era un discreto calciatore, cresciuto nel vivaio della Lazio – la squadra del cuore. Militò nella Viterbese, quindi nel Frosinone, campionato 1950-51, in Promozione Interregionale. Destro naturale, giocava mediano con la maglia numero otto: 29 presenze e zero gol. Poi l’Anconitana e il Forlì in quarta serie. Chiuse nel Terracina, stagione 1955-56. Nel contempo suonava con alcune orchestre da ballo – ah, la musica – e soprattutto scriveva su La Voce Repubblicana. Era il giornalismo il suo destino.
I primi passi sulla carta stampata sanno di sport, naturalmente, ma anche di musica e cinema. La radio però è un’attrazione fatale. Va in giro per servizio con in spalla il Nagra, registratore antidiluviano pesantissimo e ingombrante, collaborando in Rai a diverse rubriche molto seguite: Mondorama, Voci dal mondo, Schermi e ribalte, Telescopio, Novità da vedere. Fa il conduttore di K.O. Incontri e scontri della settimana sportiva, una delle prime trasmissioni di satira musicale e sportiva. Finché nel ’58 entra in pianta stabile nell’ente di Stato. La carriera è folgorante. In pochi mesi diventa inviato, ideando altri programmi di successo: L’angolo del jazz (1959), Il film all’italiana (1967), Il liscio (1974). Ma è il football a dargli la popolarità: è sua la rubrica L’uomo del giorno all’interno di Domenica Sport, curata da Sergio Zavoli e Nando Martellini dagli studi di via del Babuino. Il calcio è il suo mondo d’elezione, lo spettacolo l’altro grande amore: dal 1962 al 1970 con Lello Bersani è il fulcro di Ciak, prima rubrica radio interamente dedicata al cinema.
Ma lo sport in diretta non può fare a meno di lui. A fine corsa il palmares elenca 2400 incontri di calcio commentati, 15 Giri d’Italia, 9 Tour de France, 14 Olimpiadi. Il suo regno è stato Tutto il calcio, diviso a malincuore con l’altro signore dell’epoca: Enrico Ameri. Erano diversi e avversari come Coppi e Bartali, li accomunava unicamente la predilezione per lo scopone scientifico. E in fondo il loro dualismo sottotraccia è stato uno degli ingredienti fortunati della trasmissione. Ameri era tecnicamente più pulito, con la voce impostata e l’eloquio fitto; Ciotti lasciava spazio alla divagazione, sempre funzionale però alla descrizione dell’evento. Se l’uno faceva il regista metronomo, l’altro era il fantasista. L’inventore di espressioni come: mediano di sostegno, mezzala di raccordo, terzino fluidificante. La rivalità, malcelata da entrambi, ebbe il picco quando Ameri apostrofò Ciotti a microfono aperto, lamentando di essere stato interrotto nella cronaca dal classico “Scusa Ameri” per un inutile gol: credendo di non essere in onda, Enrico diede del coglione a Sandro. Patatrac. L’episodio, ascoltato da milioni di persone, incrinò definitivamente il loro rapporto.
Penna, taccuino, fumo blu ad avvolgere il microfono in cabina, Ciotti faceva prosa e poesia insieme, infilando nelle radiocronache svolazzi memorabili. Qualche esempio? Fiorentina-Inter, 3 novembre 1985: <Parziale di Firenze, le squadre sono andate al riposo con la Fiorentina in vantaggio per 2-0 grazie alle reti messe a segno da Passarella al 27esimo su rigore e al 45esimo da Berti. A Firenze il cielo è striato d’azzurro come da contratto, l’autunno è un’ipotesi e quasi nessuno parla del matrimonio di Pippo Baudo>. Oppure: <A Napoli la giornata è splendida, manca solo Caruso che canti O’ sole mio>.
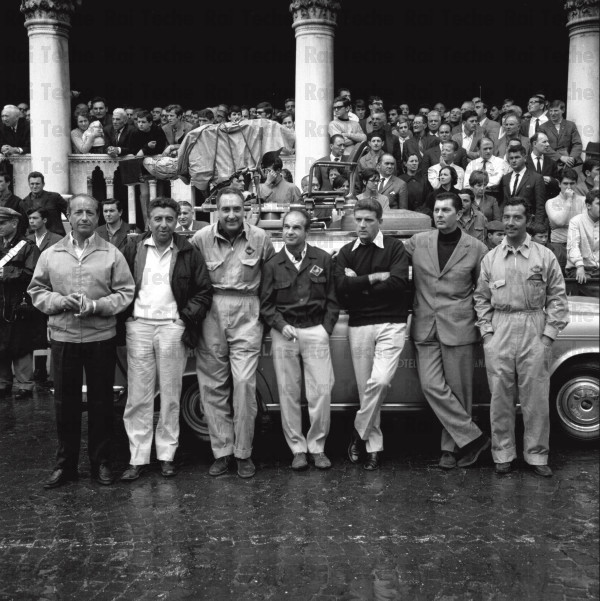
Scriveva di lui Gianni Mura: <Ciotti non avrebbe sbagliato un congiuntivo nemmeno sotto tortura. Ha portato eleganza, pulizia della lingua, competenza>. Inappuntabile il suo incipit caratteristico: <Il terreno di gioco è perfettamente agibile, la ventilazione inapprezzabile, gli spalti al limite della capienza. La direzione arbitrale è affidata a Pieri che si avvale della collaborazione dei guardalinee Sauro e Tarantola>. Anche la passione per le donne, tradotta nella scelta di non sposarsi, si riverberava nelle radiocronache: <A Bari la giornata è calda e languida come gli occhi di Ornella Muti>, <Qui a Marassi la giornata è luminosa e fredda come lo sguardo di Greta Garbo>.
Le perle si annodavano in una collana infinita di parole. Se non pronunciò la frase storica a lui attribuita – qual <Clamoroso al Cibali> che è un apocrifo – resta l’autore di intuizioni formidabili. Durante una domenica qualunque, venne interrotto da un giovane inviato che in tono concitato segnalò un gol dicendo: scusa Ciotti, sono Ciotti. E lui di rimando, quasi ponendo una questione filosofica: <Cerchiamo di capire chi siamo>. Scaramantico fino al midollo, aggirava l’insidia del malaugurio a modo suo: <Siamo al minuto che intercorre tra il sedicesimo e il diciottesimo>. Si permetteva di tifare solo per la Nazionale: <Santo Dio, era ora! Era ora!>, esplose al pareggio liberatorio di Baggio nel finale di Italia-Nigeria, Mondiali americani nel ’92, prologo alla vittoria azzurra in una partita che pareva stregata. La sua conoscenza del calcio era internazionalmente riconosciuta, così come la professionalità. Non è un caso se il fenomeno Johan Cruijff lo volle regista del biografico Il profeta del gol, <altrimenti io non faccio il film>. Mattatore anche in televisione, condusse dieci edizioni della Domenica Sportiva. Aveva l’abitudine di salutare gli spettatori con l’espressione <Amici miei, e non della ventura>: parafrasi delle parole di Beatrice che scende nel Limbo e affida Dante a Virgilio, definendolo <l’amico mio, e non de la ventura>. In realtà Ciotti alludeva scherzosamente al cognome di Simona Ventura, che lo affiancava in trasmissione.
Poi c’era la musica. Inviato a Sanremo, raccontò quaranta edizioni del Festival. Dei cantanti sapeva vita e miracoli. E anche morte, purtroppo: nel ’67 gli toccò dare la notizia della fine tragica di Luigi Tenco, primo a entrare in quella stanza d’hotel con Lucio Dalla, rifiutando sempre la versione ufficiale del suicidio. Si divertiva alla tastiera, gli piaceva giocare, era amico dei più grandi. Il suo gioiello è Veronica, canzone nata una sera alla Bussola davanti a una scenetta imprevista: <C’era una madre che si era persa la figlia e andava avanti e indietro, tenendo in mano il suo giacchino, chiamando: Veronica! Veronica! Dov’é Veronica?>. Ciotti si mise al piano e attaccò di getto: <Veronica, amavi sol la musica sinfonica / ma la suonavi con la fisarmonica / Veronica, perché?>. Il resto lo aggiunsero Enzo Jannacci e Dario Fo, che ammise: <Era una canzone da ubriachi>. Partiti dal quel verso, i tre raccontarono la storia di una prostituta milanese che lavorava in un cinema-teatro di via Canonica: <Davi il tuo amore per una cifra modica / al Carcano, in pè>. Cioè in piedi.
Ciotti è morto al policlinico Gemelli il 18 luglio 2003, dopo una lunga malattia. Aveva 74 anni. I funerali vennero celebrati davanti a una grande folla nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, a piazza del Popolo, conosciuta come la chiesa degli artisti. Mai sede fu più giusta per un addio.












