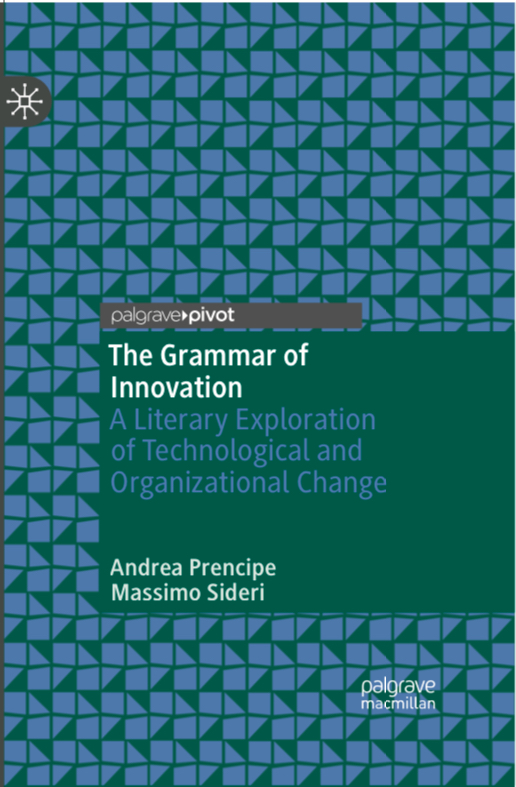Mercoledì 30 aprile 2025, presso la Casa Italiana Zerilli-Marimò della New York University, si terrà la presentazione del volume The Grammar of Innovation (Palgrave Macmillan, 2024), firmato da Andrea Prencipe e Massimo Sideri. L’incontro, organizzato in collaborazione con AIRIcerca – New York Chapter e intitolato Is Innovation Grammatically Correct?, sarà l’occasione per una conversazione aperta e interdisciplinare, che vedrà protagoniste voci dal mondo accademico, culturale e aziendale.
Prencipe non è solo un accademico. È un uomo che legge Calvino e lo mette al centro di una riflessione ambiziosa: l’innovazione ha bisogno di letteratura, perché senza immaginazione non può esistere. “Il titolo è volutamente provocatorio”, precisa, perché l’innovazione non ha regole fisse, anzi: è proprio l’atto di crearne di nuove. Abbiamo scelto di parlare di grammatica per suggerire che, come ogni lingua, anche l’innovazione si costruisce nel tempo, tra logica e intuizione, tra ordine e libertà”.
Ma se c’è una grammatica, esiste anche una sintassi? Un ordine delle parole? E soprattutto: cosa accade se si invertono i termini — se la tecnologia precede i bisogni umani invece di seguirli? “Si altera il senso stesso della frase. Si compromette l’etica dell’innovazione”, risponde. “L’offerta non può sempre precedere la domanda, altrimenti perdiamo il legame con ciò che è davvero necessario. Ma allo stesso tempo non possiamo attendere che ogni bisogno si manifesti chiaramente. A volte le grandi scoperte anticipano le esigenze. È questa tensione continua tra il già noto e il possibile che rende l’innovazione uno spazio così fertile”.

The Grammar of Innovation si struttura sulle sei “lezioni americane” che Calvino scrisse poco prima della morte: leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità, coerenza. Ognuna è esplorata nel libro attraverso la lente del suo contrario: pesantezza, lentezza, indeterminatezza, invisibilità, unicità, incoerenza. Una grammatica fatta di contrasti, perché è proprio lì che, secondo Prencipe, si accende la scintilla creativa. “Abbiamo bisogno di persone che siano educate al cambiamento. Non solo formate, ma ispirate, capaci di cogliere i segnali deboli che arrivano da mondi lontani, da linguaggi altri. Come faceva Calvino, che leggeva informatica, scienze, filosofia, non solo romanzi. Il suo sguardo era quello di un esploratore. Ed è questo sguardo che serve oggi per innovare”.
Nel libro, ogni lezione diventa un laboratorio narrativo dove si intrecciano teoria dell’organizzazione, storia della tecnologia, filosofia del lavoro, studi sulla strategia aziendale e suggestioni letterarie. Ma più che una tesi, è un percorso. Un modo per disfare il mito dell’innovazione come progresso lineare per restituirla alla sua vera natura: umana, ambivalente, imperfetta. Uno degli esempi più concreti arriva dalle reti neurali: “La tecnologia su cui si fondano gli algoritmi di intelligenza artificiale esiste dagli anni Sessanta. Per molto tempo è rimasta inattiva, quasi dimenticata. Solo oggi, grazie a nuove condizioni, è diventata decisiva. Questo ci insegna che anche l’innovazione può dormire, può aspettare il suo momento”.
Il libro si sofferma anche su ciò che resta fuori dal discorso dominante, su quello che non viene detto. Prencipe insiste su questi spazi perché è lì, secondo lui, che le idee iniziano a muoversi, spesso sotto traccia, preparandosi a emergere. “’innovazione nasce all’incrocio tra parole e silenzi”, scrive, e in questa frase c’è forse la chiave dell’intero progetto: la grammatica che propone non è un insieme di regole da seguire, ma un invito ad allenare lo sguardo, a prestare attenzione ai passaggi sottili del cambiamento, leggendo i processi non solo per quello che mostrano, ma anche per quello che ancora non riescono a dire.
Dove altre discipline cercano di costruire strutture e schemi, la letteratura offre una forma di pensiero che accetta il dubbio e l’ambiguità come parte del processo. E oggi, in un contesto in cui l’innovazione viene spesso ridotta a competenza tecnica, Prencipe ricorda che abbiamo bisogno tanto della visione quanto della capacità operativa, perché senza uno sguardo più ampio, anche le soluzioni rischiano di diventare cieche.
A discutere di tutto questo, durante la presentazione newyorkese, ci sarà insieme a Prencipe, Ennio Ranaboldo, CEO culturale con un passato tra editoria, impresa e mercati globali; Dennis Yi Tenen, docente a Columbia, autore di ricerche sulla computazione letteraria e il pensiero interdisciplinare; Josh Whitford, sociologo dell’organizzazione, da anni impegnato nell’analisi delle dinamiche produttive; Benedetta Audia, esperta di cooperazione internazionale, che porta la voce delle trasformazioni nei contesti meno centrali del mondo. A moderare l’incontro sarà la giornalista della CNN Francesca Giuliani Hoffman, con il suo sguardo attento ai temi culturali e alla complessità contemporanea.