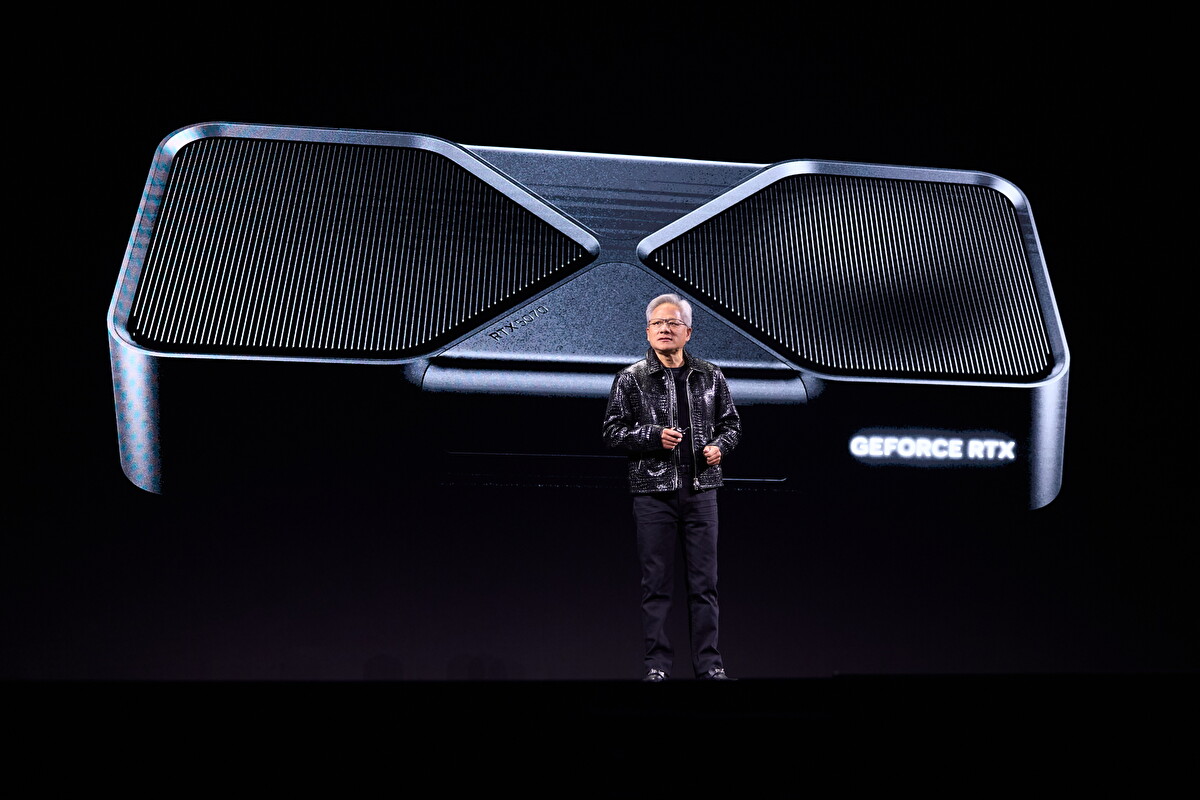Quando si parla di scuola nel cinema, si parla di un luogo che non è mai solo una scuola. Ogni film ambientato tra i banchi diventa una lente per scrutare le dinamiche più profonde della società, un microcosmo in cui si giocano partite morali, politiche, esistenziali. Se la lezione più classica oppone chi educa per dominare a chi educa per liberare, il cortometraggio di Giovanna Molina, in anteprima il 18 febbraio alla 75ma edizione del Festival di Berlino, sfida questa dialettica con un approccio diverso: non il dramma frontale dell’autoritarismo contro la ribellione, ma un’immersione nella memoria e nella scoperta di un’esperienza formativa unica.
Il film prende spunto da un vissuto personale: una scuola Quaker frequentata frequentata dalla regista e dal co-autore Louisa Grenham. Un ambiente che a prima vista non sembrava straordinario, ma che col tempo ha rivelato la sua eccezionalità. “Era un luogo in cui la comunicazione e il confronto erano fondamentali”, racconta Molina, “ma me ne sono resa conto solo dopo. Sentivo il bisogno di esplorarlo cinematograficamente”.
La narrazione, pur rimanendo nell’ambito della fiction, adotta un linguaggio documentaristico. Le riprese in camera fissa e osservativa, la sceneggiatura modellata sugli attori, la spontaneità delle interpretazioni: tutto concorre a restituire la sensazione di un’esperienza vissuta più che messa in scena. “Sembrava più un laboratorio teatrale che un set cinematografico”, spiega la regista. “Volevamo catturare la realtà, non ricostruirla”.
Anche nella sua estetica il film si sottrae alla convenzionalità. Vittoria Campaner, direttrice della fotografia, ha scelto un linguaggio visivo ispirato alle immagini di un annuario scolastico: volti in primo piano, gesti minimi, uno spazio ridotto che diventa teatro di un universo emotivo. Il bianco e nero accentua l’introspezione, dando ai personaggi una dimensione quasi sospesa. “Mi interessa lavorare sulle espressioni, entrare negli occhi delle persone”, spiega Campaner. “Il bianco e nero aiuta a concentrare l’attenzione su ciò che conta davvero”.
Ma cosa conta davvero? In questo cortometraggio, la scuola non è solo il luogo della formazione, è il luogo della costruzione identitaria. C’è un momento in cui uno studente confessa la sensazione di non essere mai del tutto presente, di vivere sempre attraverso lo sguardo degli altri. È una condizione che appartiene non solo all’adolescenza, ma all’esistenza umana più in generale. L’educazione, in fondo, è anche questo: imparare a vedersi e a riconoscersi.

Non mancano i contrasti, le frizioni, le difficoltà di un ambiente che, pur progressista, porta con sé le complessità di qualsiasi comunità. Un personaggio birazziale fatica a trovare il suo posto, nonostante il contesto accogliente. Il confronto è costante, ma non sempre facile. Come in ogni film sulla scuola, anche qui si intravede una tensione tra l’ideale e il reale, tra ciò che dovrebbe essere e ciò che è.
Inserito nella sezione Generation, il film trova il suo respiro nel dialogo tra generazioni, tra passato e presente, tra memoria e identità. “Spero che chi lo guarda possa riflettere su chi era e su chi è diventato”, dice Molina. Un pensiero che è il cuore stesso della pedagogia Quaker: il continuo interrogarsi su se stessi, la ricerca di un senso nel proprio percorso.
Ma il viaggio non si ferma qui. Molina e Campaner sono già immerse in un nuovo progetto, un lungometraggio che esplorerà altre sfumature dell’identità e dell’alienazione, questa volta in un contesto differente. Il cortometraggio resta, concluso nella forma ma ancora vivo nel suo effetto: non chiude, non definisce, piuttosto lascia domande aperte, spazi vuoti in cui chi guarda può trovare il proprio significato.