Metti un pomeriggio che scorri la classifica finalmente completa, coi primi venti, dei libri più belli del secolo XXI secondo il New York Times, giocando a “questo l’ho letto questo no”. Metti che arrivando al numero 1, scopri che sulla vetta c’è My Brilliant Friend: sì, per la giuria del NYT L’amica geniale di Elena Ferrante (ovvero la traduzione ad opera di Ann Goldstein) è il libro più bello di questi primi 24 anni del secolo. Metti poi che sui social scopri un tripudio di commenti nelle poche ore da quando la classifica è uscita – e la domanda sorge irrefrenabile una volta di più: perché il mondo letterario italiano ce l’ha con Ferrante?
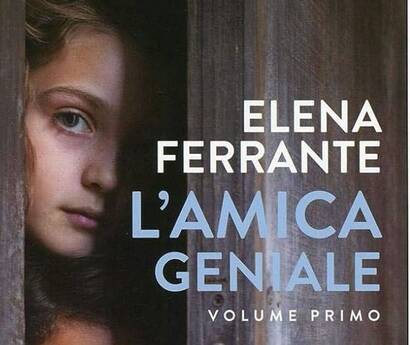 Il pubblico no, il pubblico la adora in Italia come nel resto del mondo, dove è stata tradotta in oltre cinquanta lingue; dai quattro romanzi della storia di Lila e Lenù è stato tratto anche uno sceneggiato tv a sua volta venduto dalla Rai in molti paesi. Però la misteriosa autrice (le ipotesi ci sono, i nomi si fanno ma non c’è nulla di ufficiale, né è mai comparsa in pubblico), che ha fatto la fortuna della piccola casa editrice e/o, non ha mai vinto il prestigioso Premio Strega. L’ultimo romanzo della quadrilogia, Storia della bambina perduta, arrivò finalista nel 2015 fra numerose polemiche.
Il pubblico no, il pubblico la adora in Italia come nel resto del mondo, dove è stata tradotta in oltre cinquanta lingue; dai quattro romanzi della storia di Lila e Lenù è stato tratto anche uno sceneggiato tv a sua volta venduto dalla Rai in molti paesi. Però la misteriosa autrice (le ipotesi ci sono, i nomi si fanno ma non c’è nulla di ufficiale, né è mai comparsa in pubblico), che ha fatto la fortuna della piccola casa editrice e/o, non ha mai vinto il prestigioso Premio Strega. L’ultimo romanzo della quadrilogia, Storia della bambina perduta, arrivò finalista nel 2015 fra numerose polemiche.
(E del resto, la storia della letteratura italiana contemporanea ne elenca di donne che sono state tenute sottotraccia o criticate ferocemente o considerate di carattere impossibile – prima fra tutte Elsa Morante).
Forse è proprio il non presenzialismo, il rifiuto di frequentare i salotti dell’ignota autrice che irrita il mondo delle belle lettere italiche. Di tutto s’è detto di Ferrante (anche che il successo anglosassone sarebbe dovuto alla traduzione di Goldstein che ha abbellito la sua lingua). Fatto sta che dopo numerosi premi all’estero e l’amore del pubblico, eccolo lì: a primeggiare sopra Non lasciarmi andare di Kazuo Ishiguro, La strada di Cormack McCarthy, 2666 di Roberto Bolano, Le Correzioni di Jonathan Franzen o il celebratissimo Wolf Hall di Hilary Mantel.

Il NYT ha stilato la lista chiedendo i dieci libri preferiti di centinaia di critici, lettori e scrittori, da Stephen King a Jonatham Lethem a Sarah Jessica Parker (l’attrice), a James Patterson a Jenna Bush Hager (scrittrice, giornalista e figlia del presidente George W). Ha selezionato i 100 più nominati, facendoli apparire giorno per giorno a gruppi di venti, cominciando dalla coda: i primi venti sono apparsi oggi.
Si può obbiettare che come tutte le classifiche, lascia il tempo che trova. Ma L’amica geniale ruota su una idea rivoluzionaria, proprio l’idea che serve in questi nostri tempi, l’idea che racconta delle donne e dell’Italia in una sintesi senza pietà. Ci sono due bambine intelligenti in un paese che riemerge a fatica dal dopoguerra, in una Napoli poverissima dove il Boom arriva come un’eco lontana. Capaci entrambe, entrambe determinate, una forse di più. La differenza la fa la scuola, anzi la famiglia: una bambina continuerà a studiare, l’altra si fermerà alla quinta elementare perché alle medie non ce la mandano.
Tutti i guai della sua vita si legano a questo destino troncato, mentre l’altra – attraverso il liceo, e la borsa di studio alla Normale, e l’insegnamento, e la scrittura di romanzi celebrati, e l’ascesa sociale – non si libererà mai dal tarlo, la triste certezza che tutto le deriva dal contatto con la genialità di quell’amica che ha lasciato indietro, perché era femmina e in famiglie dove già si studia poco, le femmine sono quelle che non studiano per niente. Amori, figli, rivolgimenti degli anni Sessanta e Sessanta; tutto passa per il filtro di questa occasione mancata e irrecuperabile, per lo scavo doloroso dentro se stessa che Lenù è obbligata a fare specchiandosi a rovescio nella sorte di Lila.
È una storia di rivalità e solidarietà, di amore e di rabbia. Se ha conquistato il mondo, e le donne del mondo, è perché risuona nel profondo. La giuria del NYT lo sancisce, anche senza aver mai visto in faccia l’autrice, né preso un caffè insieme, né scambiato un favore.












