Simona Zecchi è una giornalista “all’antica”, di quelle “ficcanaso”, che consuma i tacchi in cerca di documenti, magari dove qualcuno li aveva sotterrati per non farli più trovare. Giornalista testarda, che non scrive una riga senza caricarsi di “pezze”, quelle che rendono serio e credibile ciò che si scrive. Simona è quindi una giornalista rompiscatole, come dovrebbe essere ogni giornalista degno del mestiere. La Voce di New York ha l’orgoglio di averla tra i suoi preziosi collaboratori, e recentemente di Simona abbiamo pubblicato l’inchiesta sul rapimento di Aldo Moro e del possibile coinvolgimento della ‘Ndrangheta.

A distanza di oltre 40 anni dall’omicidio di Pier Paolo Pasolini, Simona Zecchi ha scritto un libro tanto atteso quanto necessario, un saggio che sta confermando a quegli italiani che credono ancora che in democrazia la verità non sia un optional, come per quell’ orribile massacro consumato all’Idroscalo di Ostia il 2 novembre del 1975 non sia stata mai fatta giustizia. Giustizia per il poeta, lo scrittore, il regista, che capiva e quindi sapeva e, con coraggio, da vero intellettuale, scriveva. Il libro di Simona Zecchi sulla fine di Pasolini sta scuotendo quell’Italia – ci ostiniamo a credere che esista ancora – chi crede che in una società democratica, quando è ormai troppo tardi per la giustizia, almeno con coerenza si debba riscrivere la propria storia per scacciare il ritorno di certi demoni.
Questo libro inchiesta sulla morte di Pasolini, si appoggia su fondamenta cementate da documentazioni fotografiche, documenti inediti, interviste e testimonianze mai rilasciate prima, che solo una giornalista d’inchiesta di razza come Simona Zecchi poteva mettere insieme. Con Pasolini. Massacro di un poeta (Ponte alla Grazie, 2015) questo il titolo del libro, Simona Zecchi riesce ad avvicinarsi fino a sfiorare la verità, quella che poliziotti, magistrati, giornalisti di regime, storici e registi non hanno mai saputo o voluto raggiungere. Già, “finalmente tutta la verità sull’agguato più doloroso delle nostra storia”.
Simona, tu credi alla verità? E nel caso di Pasolini, la verità, sarebbe ancora raggiungibile?
“Cercare la verità o i vari aspetti che, nei casi più controversi e irrisolti del nostro paese, hanno spesso nascosto risvolti inquietanti, è cercare di ricomporre un quadro che si è voluto per diverse ragioni lasciare incompleto. La storia del massacro a Pasolini si inserisce nel quadro storico recente, anch’esso tuttora irrisolto, della strategia della tensione. E in questo quadro anche come giornalista investigativo e uomo intellettuale lui ha avuto un suo ruolo, pericoloso o scomodo per più ragioni e da più angolazioni. Far emergere le evidenze dalle verità sempre esistite ma nascoste, andate perdute o fatte emergere solo a tratti: questa è la vera analisi.”
Poliziotti, giudici, avvocati, giornalisti, persino qualche pseudo amico o parente del poeta… Nel tuo libro appaiono in molti, troppi, quasi tutti corrotti, “deviati” o comunque codardi. Appaiono, anche se con responsabilità diverse, quasi tutti “complici” del cover–up per quello che veramente accadde quella maledetta notte. Questo comportamento di chi avrebbe potuto aiutare le indagini e invece non fece nulla o addirittura depistò è l’eccezione dell’Italia di quei tempi o appresenta la regola? Ma a che categoria di popolo appartengono gli italiani degli anni settanta?
“Ti ringrazio per questa domanda, perché spiega che il ‘complottismo’ non esiste, esistono i fatti e le ragioni per cui il cover up avviene. La “malattia” sta nel non riconoscerli. Certamente non si è trattato di ‘sole’ manipolazioni o di depistaggi (quelli che ho “incontrato” nella mia indagine e che è più possibile dimostrare li mostro tutti nel libro, molte cose non ho potuto dimostrarle e ho lasciato andare) ma anche di negligenze, incurie cose casuali, troppe, come hai potuto leggere, le limitate capacità e tecnica investigative di allora. Tuttavia in quegli anni si è contribuito a far sparire prove, elementi, fatti proprio affinché questi non venissero alla luce e questo modo di procedere ha trascinato con sé molte vicende cruciali di quei tempi tra stragi, finti suicidi, attentati e omicidi fatti compiere ad altri. Un rivolo che è diventato mano mano un fiume ingrossato con il risultato di cambiare il volto e il futuro di questo paese. Per quanto riguarda invece la complicità culturale è il cerchio che si chiude intorno a Pasolini, che ha sempre rappresentato un problema per l’Italia. Quindi l’analisi culturale che viene fuori è cruda anche in tal senso ma non perché rientri nel cover-up, è per meglio dire una sua concausa (per alcuni aspetti, vedi gli amici di borgata) e conseguenza”.
Qual è stato il momento più difficile che hai dovuto affrontare per scrivere e pubblicare questo libro?
“A livello di ricerca è stato tortuoso (quando non dovrebbe essere così) accedere alle carte, tutte quelle che hanno composto a livello giudiziario l’unico processo realizzato per la morte di Pasolini (carte 75/76, carte di un procedimento chiuso quindi di pubblica visione), mentre via via avevo acquisito le carte delle altre inchieste aperte e chiuse in fretta. E poi certo vi erano ancora in corso le indagini preliminari aperte dalla procura e durate ben 5 anni; era comunque giusto attendere la fine delle indagini e non intralciare la magistratura: non avrei potuto scrivere questo libro senza almeno la parte fondamentale di queste carte. E’ soltanto possibile ricomporre verità o parti di essa prendendo in considerazione tutto ciò che ‘è stato’ in termini di testimonianze documenti e cronache, questo aiuta a trovare non sempre ma spesso le parti sommerse. Un’altra parte difficile di questo lavoro è combattere con se stessi contro le proprie certezze da smontare e da ricostruire, eventualmente accettando che i fatti vanno da un’altra parte rispetto le proprie convinzioni; a esempio come faccio sulla parte che riguarda l’Appunto 21 e la morte di Enrico Mattei: anche io all’inizio credevo fosse una pista attendibile per quanto riguarda il movente. Sì può si deve, se è il caso, cambiare idea”.
Pasolini era prima un intellettuale o un artista? E che funzione pensava dovessero avere queste figure nella società?
“Pasolini era entrambi ma prima di tutto era uno scrittore, un intellettuale (a una domanda del genere “come si definirebbe” rispose così: ‘metta pure: scrittore’ nda). Lasciava una ‘via’ per poi riprenderla e fare innesti, sperimentava sia con il linguaggio che con i generi, tra saggi, cinema, letteratura, teatro, poesia, documentari e giornalismo. (Anche il giornalista Pippo Fava, ucciso dalla mafia, si muoveva in questo modo). Pier Paolo Pasolini pensava che un intellettuale dovesse porsi al di fuori delle trame del Palazzo per raccontarle all’opinione pubblica e denunciarle, porsi come voce critica contro il potere costituito ma anche contro ciò che grazie a quei poteri con il tempo sedimentatisi, si era creato, ossia false icone e speranze”.
Nel famoso articolo Cos’è questo golpe c’è una parte meno nota e sicuramente meno cara alla sinistra in cui Pasolini afferma, parlando del ruolo dell’opposizione (PCI), a cui piacque sempre e solo ricordare la definizione che Pasolini lì dà di ‘isola separata, paese pulito in un paese sporco’: ‘L‘opposizione si identifica con un altro potere: che tuttavia è sempre potere’. Questa cornice viene subito dopo “l’isola” ed è importante per capire che ruolo intendeva soprattutto non dovesse avere un intellettuale per Pasolini.
‘Di conseguenza – continua – gli uomini politici di tale opposizione non possono non comportarsi anch’essi come uomini di potere. Caso specifico, che in questo momento così drammaticamente ci riguarda, anch’essi hanno deferito all’intellettuale un mandato stabilito da loro. E, se l’intellettuale viene meno a questo mandato – puramente morale e ideologico – ecco che è, con somma soddisfazione di tutti, un traditore’.
Quindi anche per il PCI, secondo Pasolini, l’intellettuale da loro plasmato doveva rispettare quel potere. Il ‘momento’ di cui parlava in quell’articolo era il contesto delle stragi di stato (da pochi giorni, l’8 novembre 1974, erano stati raggiunti da provvedimenti giudiziari i cospiratori del golpe borghese; l’articolo è del 14 novembre e nello stesso anno si era verificata la strage di Piazza della Loggia)’. “
Sembra che tu opti, nel libro composto da una ricerca puntigliosa e accurata su una documentazione di foto e reperti di indagine invece “dimenticati” in molte altre inchieste, per la pista dei neo fascisti, che sarebbero arrivati perfino da Catania, coadiuvati con la malavita romana, compreso l’ingenuo e manovrato ragazzo di vita Pelosi. Pasolini stava cercando di recuperare, pagando un riscatto, le “pizze” del film “Salò” che erano state precedentemente rubate da un deposito di Cinecittà, e così sarebbe stato attratto in quell’agguato. Ma, sembra, che il tutto sia manovrato dall’alto: insomma, l’appuntamento, il pestaggio e la morte sono portati a termine da questa manovalanza, ma l’ispirazione e le coperture arrivano dall’alto. Chi ha ucciso e chi ha voluto la morte del poeta-scrittore impegnato per la verità?
“E’ un complesso schema che si è messo in moto lasciando che altre cointeressenze venissero coinvolte con diverse complicità, è una questione di interessi e di manovre che hanno diversi “gestori” non esiste il “grande vecchio” ma un sistema che sapendo quanto potesse dare fastidio Pasolini a tutti i livelli ha fatto sì che alcune figure gestissero la cosa prima di quella notte, durante la mattanza e dopo, durante il processo. E come si può leggere per certi versi anche durante le diverse inchieste aperte negli anni. Pelosi non è esattamente soltanto un’ esca inconsapevole, la sua è stata anche una mediazione che ha messo in conto che poteva succedere qualcosa ma che forse non si aspettava un omicidio. Pelosi sapeva che chi aveva ricattato lo scrittore voleva anche dargli una lezione, non sapeva fino a che punto si sarebbero spinti forse. Nell’interrogatorio reso al magistrato la prima volta dopo tanti anni, nel dicembre del 2014, si legge tutta questa ambiguità che per metà è voluta e che d’altra parte invece è genuina.
I livelli criminali vengono utilizzati spesso da certi apparati. E’ successo con la storica banda della Magliana (che con l’omicidio Pasolini non ha a che fare) e poi in una situazione rovesciata con Mafia Capitale (dove invece sono i criminali che gestiscono i corruttori). Livelli o cerchi concentrici che hanno fatto sì che Pasolini quella notte non uscisse vivo. Certo è una ipotesi giornalistica che è però supportata da elementi che è difficile mettere all’angolo o confutare. Detto questo non credo in una verità giudiziaria,ormai, però si può stabilire una verità storica anche con la commissione d’inchiesta, se si istituirà seriamente.”
E questa “verità'” che Pasolini, lui sì già “sapeva”, e che invece con la sua morte doveva rimanere coperta per tutti questi anni, era quella del libro rimasto incompiuto Petrolio? Leggendo il libro sembra che tu abbia dei dubbi a proposito, e invece ti dirigi verso la pista delle stragi, da Piazza Fontana in poi. E infatti introduci la corrispondenza che Pasolini ha in carcere con chi è sotto processo per quelle stragi….
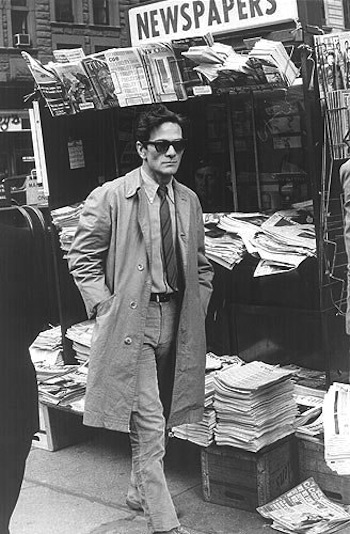
“Quella parte di inchiesta sul movente è da me lasciata aperta nel libro, è una parte che ancora si deve scrivere secondo me. Ho trovato altri elementi che portano altrove e ragionato, analizzato (quello che è proprio anche del giornalismo investigativo) e sempre a fronte di elementi scovati che allontanano la traccia del movente dal mero fatto di un capitolo incompiuto quale quello che dovrebbe essere stato l’Appunto 21. Con questo non intendo dire che non sia esistito, tutto porta a pensare che invece esistesse, quanto invece che in Petrolio, che doveva rappresentare secondo le intenzioni una grande summa letterario giornalistica sul potere in Italia, lo scrittore avrebbe potuto inserire qualcosa che prima non era mai venuto a galla sulle stragi. ‘perché è tutto fermo sulle stragi’? Questo scriveva. E data la sua forza autoriale avrebbe potuto sconvolgere un sistema. Non si uccide un Poeta (nel senso pieno della sua accezione) per qualcosa di già noto ma per qualcosa di ancora ignoto e ovviamente pericoloso. Persino dell’esistenza della P2 già si sapeva giornalisticamente parlando, evento che poi esplose davvero solo nell’81 certo. Uno stato occulto non rischia in quel modo per quanto già è di pubblico dominio (Cefis, l’Eni, Mattei) Il contesto della prostituzione maschile è servito per sporcare l’uomo e il letterato”.
Sta uscendo un film su Pasolini, “La macchinazione”, per la regia di David Grieco e interpretato da Massimo Ranieri. Lo hai visto? Che ne pensi? E che ne pensi di tutti i film o documentari che finora hanno indagato sulla sua morte?
“Sì ho visto il film e penso che purtroppo sia stato in parte, non del tutto, una occasione sprecata perché ha consegnato parti monche di verità. Certo alcune cose sono comuni a quanto da me o da altri ricostruito o da me rafforzato con le evidenze (anche perché è ormai praticamente acclarata una parte di quanto è successo nonostante la verità ufficiale falsata giunta sino a noi) ma alcuni contesti storico-criminali e anche l’omissis di ruoli di alcuni personaggi vicini a Pasolini (come Sergio Citti a cui il film “La Macchinazione” è dedicato) consegnano una verità monca, per fare degli esempi. Il problema è che la sola testimonianza per il cinema (o il giornalismo) d’inchiesta rischia di fare l’opposto di quanto si intende fare. E’ il 4° film sulla morte e il film nell’immaginario e nei cuori di chi osserva ha un’influenza diversa da un libro, poteva essere fatto qualcosa di diverso.
A oggi il film che secondo più di ogni altro ha contribuito a ricostruire quei fatti utilizzando anche la narrazione è ancora il film di Marco Tullio Giordana “Pasolini delitto italiano”. Certo i contenuti per forza di cose (era il 95) sono superati. Un film che è andato oltre invece in questo senso è stato quello di Federico Bruno “La verità nascosta” poco o per nulla distribuito e sul quale si possono avere diverse opinioni non tutte concordi ma che comunque ha osato molto e da cui molti hanno attinto. La sua voglia di verità è genuina e ha sempre collaborato con giornalisti e scrittori. Ferrara: no comment. E’ un problema culturale.
Giorni fa Massimo Ranieri credendo di dire durante una intervista una grande cosa ha detto ‘Pasolini era un grande omosessuale’ e invece dico io provocatoriamente chi è il nostro ‘grande eterosessuale’? E questo come ha influito nella rappresentazione di Pasolini nel film? In ogni caso certo ognuno di noi cerca di andare nella stessa direzione, ossia oltre la verità giudiziaria ormai fallace, e tutti noi contribuiamo in buona fede”.
Tra tutti gli amici di Pasolini, molti intellettuali “impegnati”, chi si è battuto in tutti questi anni di più per la verità? Dal libro molti non ne escono bene… Oriana Fallaci sembra una delle poche eccezioni. Secondo te indica subito la pista giusta, quella dei neofascisti?
“Alcuni intellettuali a lui più vicini hanno preso coscienza che la verità poteva essere un’altra non da subito; altri, ancora peggio di quanto facciano a destra dove però è abbastanza normale, non ne vogliono sapere; altri ancora se possibile continuano a ‘massacrarlo’ a voler cancellare il suo messaggio. Tra tutti l’unica a non averlo mai lasciato da solo nemmeno da morto in modo coerente e tutto personale è stata Laura Betti, fu lei che curò il primo libro su quella “storia sbagliata”, libro a cui molti intellettuali aderirono anche solo per farla contenta o per amore certo sincero verso Pasolini, ma non perché guidati dal dubbio che la verità potesse essere un’altra. Furio Colombo durante il 40ennale dichiarò che al tempo ancora non erano riusciti a capire, elaborare quanto successo. Dario Bellezza ci mise 20 anni; Dacia Maraini, Alberto Moravia (che gli rimase accanto nelle varie traversie con la giustizia quando in vita) e Enzo Siciliano ci misero certo molto di meno e si attivarono. Credo senza fare accuse di malafede che il suo corpo in alcune coscienze era tutto ancora così ‘caldo’ del sangue versato e lo choc enorme. La Fallaci nonostante i temi che la dividevano da Pasolini, ha fatto molto dal punto di vista giornalistico: abbondanti stralci di conferme della sua controinchiesta del tempo si trovano nelle ultime carte investigative”.
Hai scritto in un articolo e riferendoti al tuo libro: “Perché scoprire com’è andata, com’è morto davvero Pier Paolo Pasolini (e solo dopo il perché, il movente insomma) vuole dire riappropriarci del Poeta”. E’ quindi più importante capire come è morto, del perché è morto Pasolini?
“E’ importante prima capire come è andata, poi il perché. Faccio un esempio: se non si determina la dinamica fascista sul corpo se questa c’è stata (cosa che faccio nel libro con foto e analisi a confronto) non si può passare a spiegare il ruolo di certe organizzazioni di destra create infiltrate e spesso eterodirette da certa parte di Stato. Infatti, la Fallaci che aveva sospetti e buone fonti su questa pista non le ha incluse mai nella sua inchiesta, così come Antonio Padellaro nel Corriere di allora perché non c’erano abbastanza elementi. Di contro si fa solo tesi e da qui al complottismo (davvero) ci vuole poco. Il perché e il come sono importanti allo stesso modo, il chi può essere conseguente. E il chi però spetta individuarlo alla magistratura con gli indizi che anche un giornalista lascia. Ecco perché questa riflessione, di cui questo è soltanto un esempio”.
Fare giustizia sulla morte di Pasolini, non solo per dar giustizia a lui e i suoi cari, ma significa anche pretendere giustizia per la storia “deviata” dell’Italia? Se quella maledetta e piovosa sera di novembre del 1975 Pasolini si fosse salvato, se fosse vissuto “miracolosamente” ancora per qualche anno, magari fino a ieri, le sue denunce, il suo modo di essere artista e intellettuale impegnato, avrebbero potuto dare una scossa al paese senza verità? Avrebbe potuto Pasolini ancora vivo cambiare la storia della Repubblica?
“Credo che la coscienza delle generazioni a seguire, inclusa la mia che forse ha pagato più di tutti (i 40enni) avrebbe avuto un’altra direzione e forse su Aldo Moro, se fosse comunque accaduto, ci sarebbe stata un’altra riflessione o forse un altro epilogo politico del paese, ma certo visto che me lo chiedi sono soltanto opinioni, riflessioni”.
E comunque, anche quando intellettuali e scrittori di un certo livello, come Leonardo Sciascia, hanno continuato a vivere e denunciare ( vedi “Il caso Moro”, i vari romanzi sulla mafia e il rapporto con lo Stato…), non accadde nulla. L’Italia è un “paese speciale” nel far rimbalzare la verità nei muri di gomma del potere, o è sempre stato così per tutte le democrazie? Qui si pensa, per esempio, agli Stati Uniti del caso JFK…
“L’unica nostra forza è continuare a cercare la verità e a mettere dei punti fermi anche per le vicende attuali, vedi il “caso” Giulio Regeni o, se vuoi, ti faccio un lista di tutte le storie recenti di malagiustizia o di giustizia oscura…”
Cosa vorresti che col tuo libro succedesse? Se Pasolini potesse venirti in sogno come un genio della lampada, e ti dicesse “Simona, esprimi un desiderio”, cosa gli chiederesti al poeta?
“Se il mio libro riuscisse a contribuire a far ristabilire pezzi di verità in modo fermo e inappuntabile sarebbe un bel traguardo, il mio lavoro punto. Pasolini resta vivo nelle cose che ha fatto e scritto, spero di avergli restituito nel mio piccolo la dignità”.












