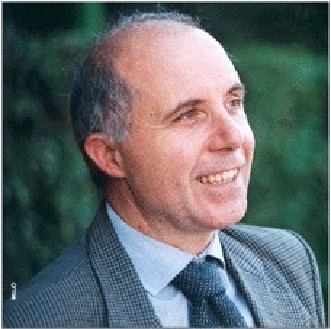Novotcherkassk, capitale dei cosacchi del Don, 2 giugno di cinquant’anni fa. Il partito comunista ha scaricato sulle spalle degli abitanti le inefficienze del sistema, aumentando del 30% il costo di carne e burro, e questi protestano. A Mosca non gradiscono che i discendenti di tartari e slavi della steppa, di grande tradizione guerriera, oppositori armati del bolscevismo sino al 1928, da sempre in cerca di assetto politico autonomo, si ribellino al potere costituito, e ordinano all’Armata Rossa di intervenire.
E’ massacro: sul terreno restano ventisei morti e novanta feriti. Successivamente sette manifestanti sono fucilati “per perturbazione dell’ordine sovietico” e centoventidue spediti al gulag, con pene tra dieci e venti anni. I corpi delle vittime sono dispersi, e sul massacro cala il silenzio della censura. Molti dettagli saranno conosciuti solo negli anni ’90, grazie alla glasnost gorbacheviana, il movimento riformista di apertura alla verità che i russi non hanno mai amato, non sentendolo vicino alla loro cultura politica, ispirata al dispotismo asiatico più che alle tradizioni diffuse in Europa dall’illuminismo.
Rileggere la cronaca di quei giorni aiuta a capire quale fosse la logica del potere in Urss, anche in piena destalinizzazione. Ad iniziare le manifestazioni contro i rincari sono gli operai delle officine di locomotive elettriche. Si sentono legittimati a farlo, visto che lavorano in fabbriche di uno stato che racconta ogni giorno la storiella di essere fondato sulla classe operaia e di esercitare per delega un potere che solo ad essa appartiene.
Il direttore dello stabilimento, che sembra ignori come sia finita Maria Antonietta nei giorni della rivoluzione francese dopo aver pronunciato una frase dello stesso tipo, risponde ai lavoratori che se non hanno soldi da comprare salsicce, mangino pirojki (involtini al ripieno di cavolo e uova sode). A gestire la crisi viene spedito Anastase Mikoyan, influente membro del Politburo.
Osserva quanto accade, arrampicato su un albero, un ragazzino del posto, che sogna la carriera militare, Alexandr Lebed. Sarà generale autoritario e controverso uomo politico, protagonista della stagione democratica della Russia di Eltsin, dopo il rifiuto di ordinare il bagno di sangue alla “Casa bianca” durante il golpe contro Gorbachev.
La sera del 2 giugno 1962, gli automezzi dei pompieri fanno sparire il sangue dalle strade. Il giorno dopo, di fronte alla popolazione sconvolta dai lutti, la municipalità organizza il “Ballo dei giovani”.
Il partito deve ritenere di aver abbattuto un nemico, non di aver assassinato cittadini in legittima protesta, e festeggia.
Ai mugugni e all’esibizione di dissenso, i comunisti oppongono la minaccia di deportare la popolazione cosacca in Asia centrale. Tutti i cittadini del caleidoscopio sovietico sanno che non si tratta di minaccia irrealistica: trapianti del genere appartengono alla loro storia. Nel 1941 comunità tedesche finirono deportate da Ucraina (200.000) e regione del Volga (350.000) in Kazakhstan e Siberia, per timore che solidarizzassero con gli invasori in arrivo da Berlino.
Gli israeliti furono sollecitati a spostarsi in Birobid nel 1928, per dar vita a una enclave ebraica nell’estremo oriente al confine con la Manciuria cinese.
Il popolo è intimorito e non dimentica la lezione di Novotcherkassk: per ritrovare una voce di protesta in Urss bisognerà attendere il 1989, con gli scioperi dei minatori.
Lo stato nuovo che subentra ai doveri dell’estinta Urss, solo nel 2001 assume la responsabilità del massacro, e attribuisce un supplemento di pensione ai sopravvissuti.
A quel fine stanzia una cifra ritenuta proporzionale al danno: 277 rubli al mese a persona. Al cambio, meno di dieci dollari.