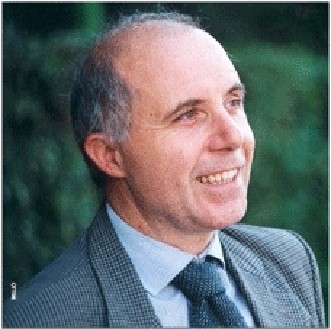Stefano Saletti e la sua Piccola Banda Ikona sono stati protagonisti, martedì, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, di “Notte Mediterranea”, omaggio alle lotte per la democrazia nei paesi rivieraschi. Il filo rosso che ha attraversato la lunga esibizione, con interpretazioni canore e musicali che hanno spaziato dal nazionalismo catalano alla guerra civile spagnola, dalla rivoluzione dei garofani portoghese alla resistenza greca ai colonnelli, sino alle rivolte italiana e arabe, ha inteso corroborare la seguente affermazione: la democratizzazione del sud Europa degli anni ’70 e quella in corso nel mondo arabo appartengono alla stessa vicenda di liberazione.
A sostegno di questa falsificazione tutta ideologica della vicenda storica mediterranea dell’ultimo mezzo secolo, la “Banda” ha proposto, nel concerto, un’operazione artistica altrettanto scorretta, trasformando brani dalla precisa e distinta connotazione storica ed etnomusicale in una sorta di macedonia coloratissima ma insapore e inodore, perché staccata da radici e identità. Bisognerebbe accostarsi a brani che hanno mosso e commosso intere generazioni, rispettando il contesto in cui sono nati, esaltandone i connotati originari, non forzandoli dentro schemi gratuiti per scodellarli al pubblico sul piattino di ritmi e arrangiamenti dettati dal botteghino. La cifra dell’interpretazione e degli arrangiamenti deve sempre essere rigorosa riguardo ad identità e origini, in particolare con la musica popolare e di autore, per non rischiarne l’assimilazione negli schemi di balera e strapaese.
La liberazione di Grecia, Portogallo e Spagna negli anni ’70, come la Resistenza degli italiani al fascismo decenni prima, si sono espresse con vicende e finalità distinte, che si ritrovano con chiarezza nei testi e nei ritmi dei rispettivi canti di lotta.
Quanto accaduto nel Nord del Mediterraneo nel corso del Novecento non può essere confuso con la natura né delle vicende balcaniche di fine secolo né delle insorgenze ora in corso in paesi come Egitto, Tunisia, Libia, Siria. Il Nord del
Mediterraneo appartiene intrinsecamente all’Europa, e ogni sua vicenda di liberazione sociale e politica se ne è sempre mostrata consapevole.
Non è stato sempre così per le nazioni balcaniche, e non lo è stato mai per i popoli dell’Occidente e dell’Oriente arabo mediterraneo. Proprio il non risolto rapporto tra Europa e Mediterraneo fornisce una delle chiavi di lettura della crisi che colpisce i cosiddetti “Piigs”, tutti, ad eccezione dell’Irlanda, collocati sul bordo mediterraneo del continente europeo. L’aureo libretto di Giorgio Fuà sullo sviluppo tardivo in Europa spiegò a chi volesse capire (e non furono in molti), già nei primi ’80, che si poteva garantire il futuro del sud Europa (e quindi del Mediterraneo, perché lo zoccolo sudeuropeo sarebbe stato ponte per lo sviluppo arabo e africano in genere) solo attraverso una cooperazione internazionale basata sul riconoscimento della sua specificità e arretratezza. Né l’Ocse che aveva commissionato la ricerca del professore anconetano, né le istituzioni europee hanno praticato quel virtuoso orientamento.
Tra i paesi che Fuà prendeva in considerazione c’era, oltre a tutti gli attuali Piigs, la Turchia. Del gruppo è l’unico che, superata la lunga instabilità generata dal precedente duopolio partitico condito da ripetuti golpe militari, sia in crescita sostenuta e tenda ad imporsi come potenza regionale.
Fa riflettere che a suo tempo l’Ue abbia rifiutato l’adesione turca. Se dovessimo andare al tracollo dell’euro, con la notte del Mediterraneo e del Sud Europa, sarà dipeso anche da errori di strategia come quello.