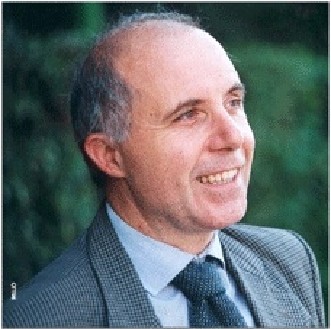In risposta alle cicliche crisi finanziarie intervenute tra il lunedì nero dell’ottobre 1987 e l’attuale dissesto dei Piigs (Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia, Spagna), sono state adottate da molte democrazie occidentali misure di contenimento
della spesa pubblica, in particolare sforbiciando salari e pensioni, e riducendo i costi del “welfare”. Le scelte sono state presentate come “neutrali” e “tecniche”. Sono in realtà a carattere politico, per almeno due ragioni: le decisioni dei governi sono “sempre” politiche, gli stati dispongono comunque e “sempre” di una gamma vastissima di opzioni e il necessario risanamento della finanza pubblica avrebbe potuto essere alimentato da altre fonti.
Se queste affermazioni corrispondono al vero, può dirsi che le revisioni in corso nella struttura dei “budget” di stati e altri soggetti pubblici mutano il rapporto tra cittadini e mano pubblica. Non viene curata la bulimia onnivora del ceto di governo (corruzione e sprechi della macchina pubblica, finanziamento pubblico di associazioni private dette partiti, privilegi e “benefits” della dirigenza dirigenza, scarsa produttività degli apparati), responsabile del dissesto finanziario e dei colpi di mano della speculazione, ma percosso il “buon” cittadino che lavora e produce, già vessato da sistemi fiscali
che ignorano la tassazione di scopo e tendono soprattutto a fare cassa dai redditi documentati. Il risultato politico è che si va disarticolando la natura dello stato democratico edificata pezzo dopo pezzo dagli alleati occidentali negli anni della guerra al nazi-fascismo, a partire dalla Carta atlantica di Churchill e Roosevelt (agosto 1941) e dal rapporto Beveridge (novembre 1942). Lo stato di tipo nuovo, sorto dai disastri del primo dopoguerra, accettava di competere con imprese e cittadini nel mercato a parità di diritti e doveri, di smorzare la storica propensione al “warfare” per edificare il “welfare”.
La revisione appare particolarmente pesante in Europa, dove l’armonizzazione tra mercato e socialità ha espresso i comportamenti più convinti ed effettivi, nella versione socialdemocratica renana e in quella della dottrina sociale cattolica. Quell’economia sociale di mercato ha ricostruito le nazioni del secondo dopoguerra, allevato un ceto operaio e
impiegatizio dignitoso e consapevole, allargato le fasce di istruzione, generato popolazioni con alti livelli di salute e igiene, che guardano serene alla terza età. Quel sistema, sul piano politico, ha consentito di battere il comunismo totalitario, ha alzato la partecipazione alla politica e stabilizzato il sistema. Si dimentica che la finanza, in sé, non costituisce ricchezza. E’ tale se e in quanto rappresenta ricchezza altra davvero esistente, come mostrano le altalene quotidiane di borsa dove i titoli fluttuano in base al valore attribuito dagli investitori. L’imperativo della quadra dei conti ad ogni costo è un nonsenso economico e finanziario, se comporta recessione, diminuzione di ricchezza effettiva, mortificazione del capitale umano. La politica economica non può avere al suo centro che il benessere della gente, non il saldo contabile.
I finanzieri e i professori di economia che stanno assumendo in molti paesi responsabilità di governo rileggano la lezione del New Deal. Troveranno che dopo i ripetuti crolli tra il ’29 e il ’34, grazie a Roosevelt la borsa di New York avrebbe registrato “crash” soltanto nel maggio ’40 (-7,47% e -6,64, il 14 e il 21) in concomitanza con l’invasione tedesca della Francia, e nel settembre 1946 (- 6,73%). Per assistere a un nuovo “crash” si sarebbe dovuto attendere il maggio 1962.
I “crash” ciclici iniziati col catastrofico ottobre 1987 appartengono all’era dell’abbandono del riformismo rooseveltiano.
Reagan è presidente dal 1980 al 1988; Margaret Thatcher è primo ministro dal 1979 al 1990.