Viaggiavo in Portogallo, anni fa, lungo la costa Verde, a nord di Oporto, lembo estremo europeo battuto dall’Atlantico. Attraversando in auto la cittadina di Póvoa de Varzim, superata la Igreja de Nossa Senhora da Lapa, noto una lapide ad “azulejos”, le maioliche tipiche della zona. Mi fermo, leggo, fotografo. Condivido ora con i lettori la storia che vi era narrata, appresa avendo nelle orecchie il rombo dell’oceano.
Aiuta a capire cosa significasse lavorare in mare in condizioni a rischio, con familiari e amici, in terraferma, a guardano inorriditi il gonfiarsi delle acque. Tutto accadde nella giornata del 27 febbraio 1892, centoventi anni fa, con l’inabissamento quasi simultaneo di otto pescherecci, tre di Afurada e cinque di Póvoa. La lapide lungo la strada “supplica” il passante di pregare per le anime dei 105 pescatori uccisi dalla tempesta, e chiede aiuto per le vedove e gli orfani rimasti. Oggi Póvoa de Varzim è località turistica di pregio, con spiagge e un casinò. Intorno all’antico porto di pesca teatro principale della tragedia, operano ristoranti, alberghi, attrezzature di servizio ai visitatori. All’epoca la contava poco più di 20 mila abitanti, contro i 66 mila odierni, e la sua economia ruotava intorno al pescato. Di fatto Póvoa era il centro più popoloso dell’economia peschiera portoghese.
Quel 27 febbraio il cambiamento meteo fu repentino, e non diede modo alle barche, uscite in mare il giorno prima in tutt’altra situazione atmosferica, di rientrare. In particolare Póvoa aveva nelle acque, profonde 65 braccia, quarantatré lance. Il Portogallo intero le avrebbe presto piante, raccogliendo sulla spiaggia i cadaveri che il mare restituiva. Gli Azulejos hanno fatto allegoria sull’accaduto. La barca che si infrange sul grande scoglio si chiama “Fe Em Deus”, Fede in Dio, a sottolineare il senso di religiosità che circondò una tragedia dove la solidarietà umana tra pescatori e famiglie si tradusse in episodi di autentico spontaneo eroismo. I pescatori sollevano tra i marosi le braccia come se fossero anime penitenti del purgatorio immerse nelle onde bollenti della purificazione. L’“azulejo” di Póvoa de Varzim potrebbe ben comparire tra le illustrazioni di Gustave Doré alla Commedia dell’Alighieri. Nella zona è tuttora viva la pietà popolare per quanto accadde quel giorno di febbraio. Antropologi e psicologi del luogo hanno dovuto confrontarsi con gli effetti sulla popolazione di un fatto che la storiografia lusitana ha iscritto nella “Epopea degli umili”, facendone il caso più emozionante della “storia tragico-marittima degli abitanti di Póvoa”. Aiuta la coltivazione della memoria il temperamento malinconico e cavalleresco di quella gente del settentrione atlantico iberico.
Tracce di questa lunga solidarietà sono documentate anche in rete, con le storie da non dimenticare, e i “blog” di giovani che ricordano gli antichi familiari scomparsi in mare. In uno si racconta: “Non ci fu casa nella quale non entrasse il lutto. Le imbarcazioni superstiti furono colorate di nero, e furono alzate bandiere nere a mezz’asta nella navigazione verso Vigo. Gli ori e i monili delle donne dei pescatori furono avvolti in panni scuri e da quel momento tutta la ‘classe’, uomini e donne, passarono a usare vestiti scuri che da allora ad oggi restano predominanti tra le persone più anziane”. Dopo la tragedia, con il sostegno solidale dell’intero Portogallo, fu creata la Casa dei pescatori, istituzione che, grazie anche all’opera dell’intellettuale Caetano Vasques Calafate, si sarebbe estesa in molti porti peschieri del paese.
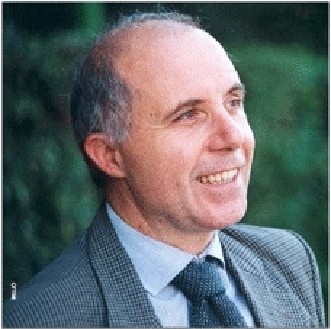










![Un'immagine della conferenza all'ONU [foto, Riccardo Chioni]](https://lavocedinewyork.com/wp-content/uploads/oldmedia/0000/file-00735-media-75x75.jpg)
