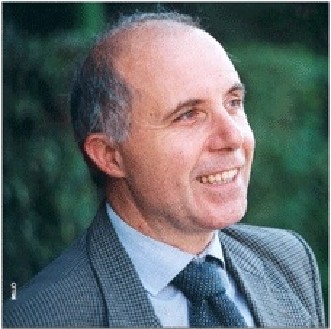Ha detto Giovanni Paolo II: “Una volta che si è tolta la verità all’uomo, è pura illusione pretendere di renderlo libero. Verità e libertà, infatti, o si coniugano insieme o insieme miseramente periscono”. Ha scritto Max Weber: “… non si dà aberrazione dell’attività politica più deleteria dello sfoggio pacchiano del potere e del vanaglorioso compiacersi nel sentimento della potenza, o, in generale, di ogni culto del potere semplicemente come tale”. Due autorevoli denunce dei limiti che il potere frappone al dispiegarsi della verità, citate nelle corpose monografie (tra i tanti: Castronovo, Mini, Sarcinelli, Davigo) che “la rivista” Arel (l’agenzia di ricerche e legislazione presieduta da Enrico Letta) ha da poco dedicato a due dei maggiori temi della riflessione umana: potere e verità.
Non si danno probabilmente nella vita pubblica termini altrettanto incompatibili. Chi vuole potere economico, in particolare finanziario, mente al fine di arricchirsi incamerando l’altrui ricchezza. Chi ambisce al potere politico, lo prende spesso con l’inganno o la violenza mascherata. Il raggiro appare protagonista delle relazioni politiche ed economiche domestiche e internazionali. Resta il paradosso di società che, come la nostra, hanno istituzioni di mercato e politiche costruite sul patto della reciproca fiducia, e che però sembrano rassegnate alla impossibilità di verità. Peraltro, il più menzognero dei poteri risulterebbe proprio lo stato, e non solo nei sistemi che definiamo dittatoriali o autoritari. Il patto interno di verità tra stato e cittadini, e internazionale tra gli stati, è regolarmente violato anche dai paesi a regime democratico, nel segno di valori come “l’interesse nazionale”, “la sicurezza dello stato”, “il benessere collettivo”.
Esemplare la faccenda della storiella sulle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, fatta circolare dal tandem anglo-americano per spingere le opinioni pubbliche ad appoggiare l’intervento armato in Iraq. Il potere mise la “ragion di stato”, davanti all’esigenza di verità. Né sarebbe stato mai chiamato a rispondere della falsificazione, dalle istituzioni nazionali di controllo della democrazia (parlamento e magistratura), o dalle Nazioni Unite, evidentemente convinte della legalità di una menzogna che trasformava un atto illegittimo come l’aggressione ad uno stato sovrano in ammissibile difesa preventiva contro uno stato che minacciava attacchi irreparabili.
E’ comprensibile che gli stati immaginino di poter basare i propri comportamenti su logica e morale svincolate dall’esigenza di verità. Ma devono astenersi dal soddisfare quel “richiamo della foresta”, assoggettandosi alla trasparenza della verità, come li invitava a fare già Woodrow Wilson, quasi un secolo fa, al tavolo di Versailles. In alternativa, sul piano interno i cittadini smetterebbero di attendersi comportamenti “veritieri” dal loro stato rinunciando conseguentemente al patto di fedeltà reciproca, sul piano internazionale gli stati baserebbero i rapporti sulla diffidenza che deriva dalla certezza della menzogna di tutti con tutti. Un risultato non molto distante dalla distruzione pura e semplice della vita associata interna alle nazioni, e tra le nazioni. Lo stesso vale per l’economia: se davvero tutto fosse fondato sulla mancanza di verità, chi accetterebbe più la validazione di un assegno e persino una banconota senza pensare che siano opera di falsari? chi un impegno di pagamento o investimento futuro senza vedervi il rischio di raggiro?
Verità e potere devono necessariamente riconciliarsi, tanto più in una società che si definisce aperta e globale. La comunicazione, internet, possono molto in questa direzione, purché il potere, come accade in Cina, e come per altri versi si minaccia in questi giorni negli Stati Uniti, non interferisca nelle verità esposte in rete.