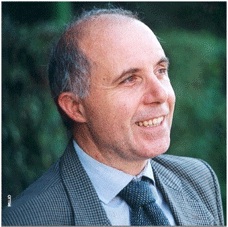A metà maggio Giulio Tremonti ha dichiarato che la stagnazione di sviluppo dell’Italia dipende dal Mezzogiorno. Ha aggiunto che si tratta di una questione politica e che, senza il Mezzogiorno, il paese potrebbe crescere anche più della Germania. Il ministro dell’economia ha precisato che la penisola continua ad essere “duale” benché ciò non comporti, si noti la graziosa concessione, che debba essere “divisa”. Il responsabile delle politiche economiche nazionali ha mancato di precisare a chi appartenga la responsabilità della situazione, presumibilmente perché nell’elenco avrebbe dovuto inserire se medesimo.
E’ ozioso chiedersi se per il Mezzogiorno la riunificazione con il nord sia stato un affare. E però in molti continuano a chiederselo. Saranno gli umori di un anno di celebrazioni unitarie che non sta generando consapevolezze obiettive e condivise, costretti come siamo nell’emergenza politica ed economica. Saranno le bordate arroganti che certi politici del settentrione continuano a sparare contro gli eterni ritardi del Mezzogiorno (ci mancava solo la munnezza di Napoli!). Appaiono sempre più numerosi quelli che, dal Vesuvio in giù, rispondono con un no alla oziosa domanda, stramaledicendo don Peppino Garibaldi e magnificando la lungimiranza di Cavour che il Mezzogiorno voleva lasciarlo dove stava, uno dei tre pezzi dell’Italia da lui concepita.
A dar retta allo storico inglese David Abulafia, allo stato unitario il sud arrivò dopo un medioevo “molto ricco”; “produceva ampie quantità di cibo, indispensabili per la sopravvivenza delle regioni settentrionali”. Erano i tempi prosperi di Svevi, Angiò, Aragonesi: Campania e Sicilia calamitavano mercanti del nord in cerca di cotone e seta, oltre che di cibo. La decadenza, per lo storico, fu responsabilità dello sfruttamento coloniale dei Borbone, calati in zona nel XVI e XVII secolo. Napoli e Palermo continuarono tuttavia a rivaleggiare con Firenze in quanto a gloria e peso europei, con Roma indistinta nelle vicende papali. Il Meridione si avvantaggiava del rapporto con un Mediterraneo che, prima della scoperta atlantica, aveva espresso perni di sviluppo come Bisanzio, Medio oriente e nord Africa arabi. Va detto che, anche in quella lunga epoca di relativo benessere, il Mezzogiorno, ancorato alle politiche pubbliche e al latifondo, dall’accumulazione finanziaria non seppe mai generare una diffusa borghesia produttiva e protoindustriale.
Quando Garibaldi risalì lo stivale apparecchiando per casa Savoia il dono del regno delle due Sicilie, non ebbe consapevolezza di prepare le condizioni per l’arretramento delle popolazioni “liberate”, le cui prime tragiche avvisaglie si sarebbero avute, una decina di anni dopo, con la guerra del brigantaggio: quella catastrofe, secondo Indro Montanelli, fece più vittime di tutte le battaglie per l’indipendenza contro l’Austria.
Svimez, ha appena pubblicato dati utili al ragionamento. Se nel 1861 il prodotto interno lordo meridionale pro capite, pil, è praticamente pari a quello del centro nord, dall’ultimo decennio dell’Ottocento parte inarrestabile il declino che dopo un secolo di unità, nel 1960, dimezza il valore del pil pro capite meridionale rispetto a quello del centro nord. Da allora una lenta risalita con fasi alterne e mai oltre il 60%, attualmente posizionata al 58%. Nell’industria lavorava nel 1861 il 23% della popolazione attiva del mezzogiorno e il 15,5% di quella del centro nord: rispettivamente 1 milione 200 mila e 1 milione 560 mila persone. Oggi il numero assoluto di occupati industriali nel sud supera di poco la cifra del 1861, nel centro nord è quasi quadruplicato.