La fondazione di diritto pontificio “Aiuto alla chiesa che soffre” ha presentato il suo rapporto annuale sulla libertà religiosa nel mondo, arrivato alla dodicesima edizione. L’incontro, alla Stampa estera di Roma, è stato di grande impatto, anche per lo spessore dei relatori, tra i quali Pascale Esho Warda, caldea di etnia assira, già ministro per le politiche migratorie del governo di transizione iracheno guidato da Awad Allawi tra il 2004 e il 2005.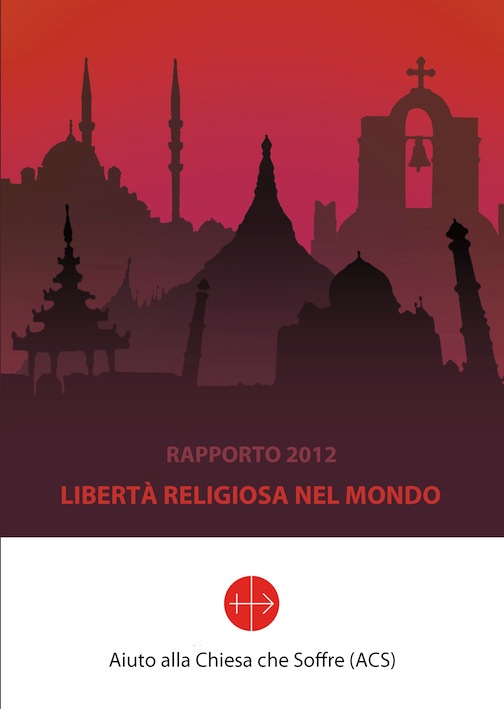
Dalla fondamentale lezione di Samuel Huntington le differenze religiose, spesso legate a quelle etniche, sono sempre più percepite come fattori prioritari delle crisi che il sistema internazionale si trova ad affrontare. Tra le più difficili da risolvere, in quanto basate anche su irriducibili fattori emozionali, non solo su interessi generalmente di più facile composizione, le crisi con radice etnico-religiosa hanno, tra i tanti effetti, quello di ridurre la capacità delle popolazioni a professare il loro credo, un diritto tutelato dal diritto internazionale e dalle Nazioni Unite.
Non casualmente il rapporto viene aperto dalla prefazione di Paul Jacob Bhatti, già ministro federale per l’armonia nazionale e le minoranze del Pakistan. Suo fratello, titolare prima di lui dello stesso incarico, per il deciso impegno in favore delle comunità oppresse ed emarginate fu assassinato nel 2011 da estremisti religiosi. Paul Jacob all’epoca viveva in Italia, dove esercitava la professione di medico, ma sentì inesorabile il richiamo a proseguire la missione del fratello: “abbiamo il dovere di lottare per chi è troppo debole per parlare e difendersi da solo”.
Benché consapevole che i cristiani sono attualmente la più perseguitata comunità di credenti al mondo, il rapporto evidenzia come stiano crescendo discriminazione e violenza verso ogni forma di religione, grazie anche all’ampliarsi del terrorismo islamista. Sono ovviamente le minoranze etnico-religiose ad essere indiziate di crescente sofferenza e repressione, per la vigliacca convinzione di impunità che le maggioranze spesso professano.
Il rapporto rileva cambiamenti in 61 dei 196 paesi presi in esame: solo in 6 i cambiamenti si sono tradotti in miglioramenti. In 26, con un livello di violazione della libertà religiosa definita “media” o “elevata”, non si sono registrati cambiamenti significativi. Sommando i due gruppi di paesi con cambiamenti o stabilità negativi, si arriva a quasi il 30 per cento del totale, il che consente di affermare che quasi il 30 per cento dei 196 paesi viola in modo significativo la libertà religiosa.
Sui “miglioramenti” l’analisi degli autori, un gruppo transnazionale di sociologi e politologi, fornisce un dato di forte interesse: avvengono per lo più grazie ad iniziative locali, non per effetto di politiche centrali. Né gli analisti sfuggono dal confrontarsi su un dato paradossale: sempre più opinioni pubbliche attribuiscono proprio alle religioni la responsabilità delle repressioni che toccano talune comunità che per tradizioni sono identificate con l’una o l’altra confessione. Si ritrova, nell’approccio, un errore spesso compiuto dal pensiero umano: la confusione tra vittima e carnefice.
Come mostra la terribile vicenda che gli ebrei hanno sofferto in Europa nella prima metà dello scorso secolo, quando le comunità umane, organizzate o meno in stato, transitano dalla pacifica convivenza interreligiosa alla discriminazione, precostituiscono le condizioni per la catastrofe. Le repressioni religiose in aumento non sono quindi un buon segnale per la pacificazione del sistema internazionale. Il fatto che, secondo il rapporto, si manifestino soprattutto in Asia è un pessimo indicatore qualitativo dello sviluppo socio-economico che quella parte del mondo sta realizzando.












