Pubblichiamo la prefazione di Germano Dottori al libro La minaccia nucleare in Medio Oriente, di Amir Madani, Alessandro Politi e Rodolfo Guzzi (Clueb 2013)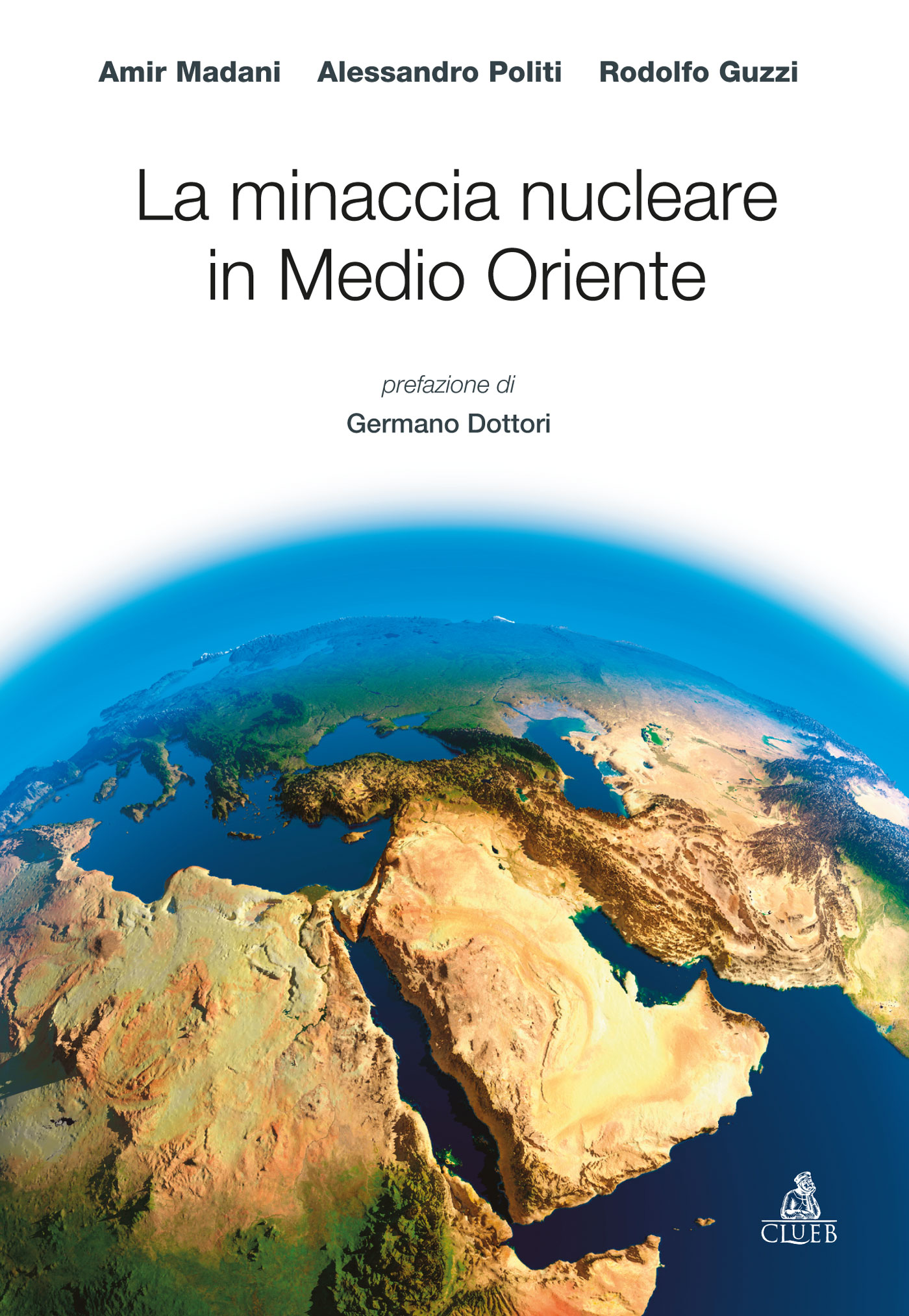
La minaccia Nucleare in Medio Oriente di Amir Madani, Alessandro Politi e Rodolfo Guzzi affronta una questione di stringente attualità, che peraltro si trascina da lungo tempo. Ho accettato con grande piacere la proposta di presentarlo con una mia Prefazione per almeno tre ordini di motivi.
Il primo è la grande amicizia che mi lega a due degli autori, Madani e Politi, con i quali ho avuto più volte l’occasione di collaborare, con mio grande beneficio e spero soddisfazione reciproca, mentre a Guzzi mi vincola la gratitudine che deriva dall’aver facilitato la pubblicazione di “Afghanistan, crisi regionale problema globale”, uscito due anni fa per i tipi di Clueb.
Il secondo invece è l’opportunità che mi viene offerta in questo modo d’inserirmi in un dibattito molto serrato e non di rado condizionato da pregiudizi ideologici duri a morire, approfittando dell’eccellente lavoro svolto da chi ha redatto il volume per veicolare un punto di vista differente e tuttavia complementare rispetto a quelli sostenuti nelle pagine che seguono.
Il terzo, infine, è la volontà di sfruttare l’occasione per ricordare alcune delle conclusioni d’intensi anni di attività svolta nell’ambito del Centro di Studi Strategici e di Politica Internazionale, dedicati specificamente alla questione del controllo della proliferazione nucleare, sotto l’attenta direzione di Enrico Jacchia, scomparso a Roma nel dicembre 2011. In qualche modo, quindi, questo testo vuol anche essere un piccolo tributo alla memoria di una persona al fianco della quale ho vissuto un significativo periodo della mia vita professionale.
Le questioni che il saggio solleva sono numerose. Ma alla fine l’intera opera ruota intorno ad un triangolo politico-strategico costituito dagli Stati Uniti, dall’Iran e da Israele. Le conclusioni sono sorprendenti, nel senso che dalla lettura delle pagine emerge con forza tutto l’insieme delle ragioni che renderebbero improbabile un conflitto tra queste tre nazioni, pure da tanto tempo dato per inevitabile ed imminente.
Madani ricostruisce efficacemente la storia del programma nucleare iraniano, evidenziando come rifletta un’ambizione di lungo periodo del paese, che aspira dall’epoca dei Pahlevi a vedersi riconoscere lo status di grande potenza. Nella ricostruzione di Amir, peraltro oggetto anche di sue precedenti ricerche, sono altresì poste in risalto le cause della profonda sfiducia che condiziona tuttora i rapporti tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica Islamica dell’Iran: dal rovesciamento del governo Mossadegh al sostegno lungamente assicurato ad una monarchia assai raramente popolare tra gli iraniani, fino all’inclusione di Teheran nel cosiddetto “Asse del Male”, deliberata dall’Amministrazione di George Walker Bush a dispetto del sostegno assicurato dall’Iran alla campagna contro il regime talebano in Afghanistan. Sarebbe stata proprio questa scelta, tra l’altro, a compromettere la posizione interna dei riformisti, facilitando nel 2005 l’ascesa sul palcoscenico politico iraniano di un presidente radicale e populista come Mahmud Ahmadinejad.
Sono valutazioni in larga misura condivisibili. D’altra parte, se non si considerano i risentimenti e la sfiducia accumulatisi nel tempo, risulta davvero incomprensibile il fallimento dei molteplici tentativi fatti anche in seguito per riannodare il filo di un dialogo. Ad esempio, in coincidenza con la nomina dell’afghano-americano Zalmay Khalilzad alla testa dell’ambasciata statunitense a Baghdad, in cui molti osservatori credettero di riconoscere il sintomo di una volontà di Washington di discutere con emissari iraniani i termini di un’intesa informale sui nuovi equilibri nel Grande Medio Oriente.
L’attuale Amministrazione democratica, dal canto suo, non ha certamente contribuito a migliorare le cose, stante il comportamento ondivago e spesso francamente sconcertante tenuto da Barack Obama.
Questi ha inizialmente dischiuso le porte, nella primavera del 2009, al riconoscimento americano del diritto iraniano a sviluppare un programma nucleare civile, probabilmente nell’intento di preparare su basi nuove un confronto costruttivo tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica.
Sull’effettiva valenza di questo passo, poco si è detto ed ancor meno si è scritto. Eppure, le implicazioni erano notevolissime: giacché, come amava ripetere Jacchia, la tecnologia richiesta per la produzione indigena di energia elettronucleare è la stessa che occorre per la fabbricazione di ordigni atomici, Obama stava in effetti operando una scommessa sulla leadership iraniana, offrendole nulla di meno che la disponibilità statunitense ad accordarle la possibilità di praticare di una politica di ambiguità nucleare assai simile a quella israeliana. Tutto ciò che l’America avrebbe preteso in cambio era la rinuncia di Teheran ad effettuare un test, che ne avrebbe dichiarato ufficialmente lo status di paese dotato di armi atomiche.
Washington era chiaramente interessata a trattare e perseguiva forse ancora quel famoso “grand bargain” di cui per tanto a lungo si era favoleggiato. L’interesse era talmente elevato che quando, di lì a poco, alla rielezione di Ahmadinejad fecero seguito le proteste popolari contro i presunti brogli e le dimostrazioni scatenate dall’Onda Verde, la Casa Bianca rimase silente.
Si spiegò quella scelta con la volontà di non danneggiare i manifestanti offrendo loro una sponda esterna che ne avrebbe sicuramente compromesso le sorti. Ma un quotidiano assai vicino all’establishment liberal, il Washington Post, scese in campo al fianco del neorieletto Presidente iraniano, sostenendo di possedere sondaggi in base ai quali risultava che le percentuali ottenute da Ahmadinejad corrispondevano all’effettivo consenso di cui questi godeva nel Paese. L’America desiderava negoziare ed era disponibile, magari sottobanco, a farlo persino con un presidente giudicato impresentabile a causa delle posizioni negazioniste assunte relativamente all’Olocausto e delle frequenti intemperanze verbali nei confronti di Israele.
Quello che però preme soprattutto sottolineare qui è il grande pregiudizio arrecato da questa incauta politica all’immagine degli Stati Uniti proprio presso quella parte dell’opinione pubblica iraniana dalla quale ci si aspettava che sorgesse la sfida al regime.
Poi, almeno in apparenza, Obama ha cambiato le linee guida della propria politica: abbracciando lo smart power, giocando spregiudicatamente la carta dell’Islam politico popolare sunnita e scommettendo sull’ascesa della Fratellanza Musulmana in particolare. Cioè, stringendo un’intesa con degli acerrimi avversari dell’Iran, invisi anche ad Israele.
Nel contempo, ha preso vigore l’attacco cibernetico all’infrastruttura fisica del programma nucleare della Repubblica Islamica, perfetto per rassicurare non solo lo stato ebraico, ma altresì e forse soprattutto sauditi ed emiri del Golfo. Così è arrivato Stuxnet, con l’effetto che adesso la Casa Bianca non ha più simpatizzanti – di amici non si è in effetti mai parlato – né sulla piazza né dentro i palazzi del potere iraniani. La sfiducia è ulteriormente aumentata. Il resto lo hanno fatto i giochi di guerra nello Stretto di Hormuz e la narrativa bellicista di questi ultimi mesi.
D’altra parte, anche la Repubblica Islamica ha le proprie responsabilità: a partire dalla storica presa in ostaggio del personale dell’ambasciata americana a Teheran tra il 1979 ed il 1980, che costituisce uno dei momenti fondativi del regime attualmente al potere in Iran, proseguendo con la disinvolta pratica del terrorismo internazionale, per giungere al sostegno assicurato pubblicamente al Hizb’Allah e ad HAMAS, fortemente risentito negli Stati Uniti specie dopo i fatti dell’11 settembre 2001.
Per effetto di quanto accaduto, riconoscere la controparte ed intavolare un dialogo è divenuto “tossico” e pericoloso tanto per la leadership iraniana quanto per quella americana. Chi tenti imprudentemente di gettare un ponte verso l’altra sponda corre gravi rischi politici. Di qui, la necessità di operare attraverso canali indiretti e coperti, utilizzando gli strumenti della diplomazia segreta, che tuttavia generano immancabilmente diffidenze e sospetti tanto sul piano interno che internazionale.
L’impressione è che gli Stati Uniti intendano mantenersi liberi di scegliere tra un vasto ventaglio di opzioni, se non addirittura conservare la possibilità di effettuare un fine tuning tra scelte apparentemente divergenti, per prevenire l’ascesa di potenze regionali dominanti e, se del caso, tollerare un ragionevole livello d’instabilità nell’area, che dopotutto danneggia più gli interessi degli europei, dei cinesi e, probabilmente, dei russi che non quelli di Washington.
L’inquietudine non turba soltanto gli israeliani e le potenze arabo-sunnite, ma anche la Turchia, che compra il petrolio iraniano pagandolo con oro per aggirare le sanzioni internazionali imposte contro Teheran, salvo però schierarsi tra i Paesi favorevoli alle difese antimissilistiche atlantico-americane ed esigere i Patriot della NATO per difendersi dall’improbabile aggressione di una Siria ridotta allo stremo.
Una deflagrazione regionale di vaste proporzioni non rientra comunque nelle aspirazioni degli Stati Uniti, che anzi desiderano visibilmente ridurre la propria esposizione in Medio Oriente e nel bacino del Mediterraneo.
Il rischio di un conflitto con l’Iran non dipende tuttavia soltanto dalle scelte dell’America. Dell’equazione, infatti, fa parte anche Israele, che reagisce ad input differenti e persegue interessi soltanto in parte sovrapponibili a quelli statunitensi. La prospettiva americana è in effetti globale e dall’angolo visuale di Washington quanto accade nello spazio compreso tra l’Egitto e l’Iran non può avere la stessa importanza che riveste per Israele.
Per l’una, si tratta infatti di uno scacchiere tra gli altri, certo particolarmente delicato, ma non uno da cui dipenda la sopravvivenza degli Stati Uniti come paese sovrano, pur avendo un rilevante peso specifico nel contesto della competizione mondiale per la supremazia politica. Per l’altro, invece, è l’ambito nel quale si generano le minacce immediate alla propria esistenza.
La Guerra Fredda è finita. E certe logiche di schieramento che sembravano immutabili sono venute meno. In effetti, non c’è nulla che leghi ontologicamente Israele all’America, al contrario di quanto comunemente si crede e come ha efficacemente spiegato Samuel Huntington, descrivendo lo stato ebraico come il paese leader di una civilizzazione a sé stante rispetto a quella occidentale e pertanto da questa incoercibile.[1] Anzi, per quanto la cosa sia stata dimenticata da molti, non è un mistero che alla nascita ed alla difesa dell’indipendenza d’Israele l’Unione Sovietica abbia dato un contributo molto più importante di quello di Washington.[2]
Fu il mutare degli allineamenti – dovuto soprattutto alla scelta di Mosca di cambiare cavallo e scommettere sulla causa araba – a provocare la convergenza israeliana sugli Stati Uniti e per giunta dopo un periodo nel quale ad assistere Tel Aviv fu soprattutto la Francia, sino a quando a loro volta i partner si distanziarono. Lo stretto rapporto israelo-americano che avrebbe contraddistinto tutto il periodo bipolare non ha quindi nulla di strutturale. È invece congiunturale, storico se vogliamo, comunque legato ad un complesso di circostanze contingenti, e perciò sempre reversibile, da un lato come dall’altro.
Si tratta di un fattore decisivo alla comprensione degli eventi e delle dinamiche in atto. Per Washington, la prospettiva del decoupling è adesso particolarmente allettante. Si tratta infatti di scambiare il sostegno di uno stato piccolo come quello israeliano con le simpatie di un miliardo di musulmani. E Gerusalemme ne è consapevole.
La miglior carta di cui disponga Israele è e rimane la potenza militare, che poggia su capacità d’avanguardia ed una preparazione assolutamente di punta. Ma le armi possono non bastare ad assicurare il futuro, specie in un contesto marcato dall’instabilità, dall’insicurezza e dalla debolezza demografica.
Il saggio di Politi dimostra, su solide basi tecniche, come Gerusalemme sia perfettamente in grado di assicurare un’efficace dissuasione anche nei confronti di un Iran che fosse armato nuclearmente. Il deterrente israeliano è in effetti imponente, disponendo di diverse centinaia di testate – secondo alcuni analisti sarebbero addirittura 400, ma la stima convenzionalmente accettata è 200 circa – oltreché di mezzi adeguati a veicolarle su una grande quantità di obiettivi strategici; è inoltre tecnologicamente avanzato, comprendendo anche ordigni miniaturizzati, e quindi idoneo a rispondere ad un vasto spettro di possibili impieghi.
Anche il timore connesso all’eventuale trasferimento di qualche ordigno a proxy regionali di Teheran è in realtà molto teorico. Non solo perché le prime, eventuali, testate iraniane saranno certamente troppo voluminose ed ingombranti per esser facilmente contrabbandate ed utilizzate efficacemente da organizzazioni non statuali. Ma anche perché il quadro politico regionale del Medio Oriente sta evolvendo ad una velocità straordinaria.
Il regime siriano sta crollando, privando Teheran di un tramite essenziale e tendenzialmente isolando l’Hizb’Allah libanese. HAMAS, invece, si sta frammentando, con una parte rilevante del movimento incline ad accettare la tutela egiziana assicuratale dal presidente Mohammed Morsi e, per questa via, l’ipotesi di un clamoroso avvicinamento agli Stati Uniti, con l’effetto finale di sigillare rispetto alla penetrazione iraniana anche la Striscia di Gaza.
Eppure, da Israele la gente va via. Quasi un quinto di coloro che detengono un passaporto israeliano vive ormai all’estero. È in questa situazione, cioè in concomitanza con l’ascesa al potere di formazioni politiche che si rifanno ad un programma radicale come quello della Fratellanza Musulmana, che a Gerusalemme si osserva con costernazione e preoccupazione la scommessa fatta dal presidente Obama sull’Islam politico sunnita.
Ecco quindi che il problema strategico di Israele assume adesso una diversa connotazione, collegandosi all’evidente fragilità della posizione del paese ed al crescente isolamento internazionale dello stato ebraico, di cui è parte centrale il forte timore di un prossimo voltafaccia di Washington, che è alimentato non soltanto da alcune scelte fatte dall’Amministrazione in carica e da quella che l’ha preceduta, ma altresì da una pubblicistica americana assai poco rassicurante.
Pochi ricordano come nel corso della sua ultima visita da Presidente ad Israele, ad esempio, George Walker Bush avesse invitato dalle mura di Gerusalemme il governo israeliano a porre fine all’occupazione dei territori invasi nel 1967. E come nello stesso periodo il generale David Petraeus, allora all’apice del suo fulgore e preposto alla guida del Comando Centrale statunitense (CENTCOM), si fosse spinto a definire l’alleanza con lo Stato ebraico come una passività strategica dell’America. Ancora meno sono quelli che alle nostre latitudini hanno letto quanto George Friedman, l’influente fondatore e direttore di Stratfor, scrisse in un suo saggio pubblicato due anni fa, laddove si invitava il governo americano ad abbandonare Israele al proprio destino, per ricucire con l’Iran ed il mondo musulmano più in generale.[3]
Poi, alle parole si sono aggiunti le scelte e i fatti concreti – ed in particolare l’appoggio accordato dalla Casa Bianca alla Primavera Araba, ora apparentemente in procinto di coinvolgere anche la Giordania – che hanno significativamente deteriorato l’ambiente strategico in cui è calato Israele con l’attivo sostegno degli Stati Uniti. Di qui, il bisogno avvertito da Gerusalemme di alterare in qualche modo le direttrici di una politica mediorientale americana percepita ormai come infida e pericolosa ai fini della propria stessa sopravvivenza.
Uno strumento per ottenere questo obiettivo potrebbe essere proprio il ricorso unilaterale alla forza da parte israeliana, finalizzato a costringere l’America ad una chiarificatrice scelta di campo, per quanto i militari di Gerusalemme temano la prospettiva di avventurarsi in conflitti complessi senza avere le spalle coperte da Washington.
L’attacco aereo su Gaza, deciso non a caso all’indomani e non prima delle presidenziali americane, quando cioè non si correva più il rischio di ridurre le già basse possibilità di vittoria dello sfidante repubblicano, è stato senza dubbio un primo test: quello per certi versi tecnicamente più accessibile e politicamente meno rischioso.
L’esito dell’operazione pare per il momento piuttosto soddisfacente per il governo israeliano, che ha incassato l’inequivocabile appoggio formale dell’Amministrazione Obama, seppure la Casa Bianca sia riuscita a trovare il modo di garantire comunque una continuità alla propria politica recente, facendo di Morsi il mediatore della contesa ed il garante ultimo della tenuta della tregua raggiunta, anche rispetto ad eventuali tentativi iraniani di infiltrazione nella Striscia.
Ma è ancora presto per concludere che sia intervenuto un cambiamento decisivo. Altre prove verranno dalle scelte che l’America farà in Egitto, dove è emersa una notevole opposizione al tentativo della Fratellanza Musulmana di dar vita ad un regime autoritario; in Siria, nel riassetto post-conflitto; e ad Amman, se e qualora l’Islam politico tentasse l’abbattimento della monarchia hashemita.
Paradossalmente, pertanto, il vero pericolo di guerra deriva proprio dall’accentuarsi dell’insicurezza israeliana di fronte alla nuova politica mediorientale degli Stati Uniti, che danneggia fortemente anche gli interessi dell’Iran.
Ecco perché, alla fine, la tentazione di utilizzare le armi potrebbe risultare irresistibile, tanto in Israele quanto nella Repubblica Islamica. Non tanto per la questione nucleare in sé, evidentemente – quello sarebbe casomai il pretesto – quanto piuttosto per le geometrie geopolitiche che stanno emergendo in Medio Oriente, obiettivamente poco entusiasmanti sia per Gerusalemme che per Teheran. C’è ragione di ritenere che Washington farà quanto è in suo potere per evitare un conflitto dagli esiti imprevedibili. Ma le tensioni si accumulano. E questo volume di Madani, Politi e Guzzi aiuta a capire perché.
Roma, 14 dicembre 2012









