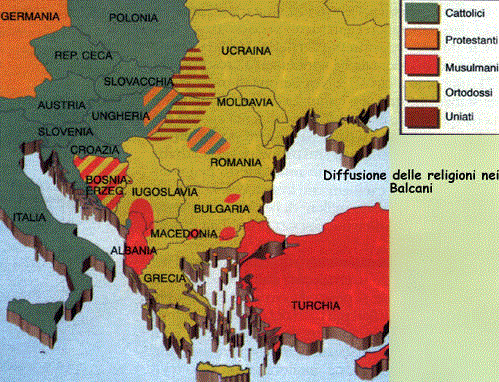Il 30 maggio 1913 viene firmato, a Londra, il trattato che regola gli spostamenti di sovranità nei territori toccati dalla Prima guerra balcanica. La carta geografica imposta dalle potenze, segnatamente Gran Bretagna Francia e Italia, appare subito impraticabile: non tiene conto della geopolitica regionale ed è sconnessa dalle richieste delle popolazioni coinvolte. Con il loro errore, le potenze contribuiscono allo scoppio, in giugno, della Seconda guerra balcanica. Il trattato di pace di agosto, a Bucarest, prova nuovamente a stabilizzare l’area, facendo aggio sull’agonico impero ottomano. Come mostrano le recenti guerre post-jugoslave e le attuali tensioni in Kosovo, Serbia, Turchia, Ungheria, la definitiva stabilizzazione di Balcani e propaggini geopolitiche non è ancora conclusa. Qualche responsabilità va cercata proprio in ciò che accadde a Londra un secolo fa.
Il trattato di fine maggio 1913 ritirava dall’Albania ogni contingente d’occupazione, spartiva tra Serbia e Montenegro il territorio di Sandžak, dava la Tracia alla Bulgaria, ricercava senza trovarla una soluzione per la Macedonia. Il conflitto, che si era sviluppato nel biennio 1912-13 anche attraverso pagine di atrocità interetnica e interreligiosa, aveva mostrato che, scomparso l’impero ottomano, non solo la regione era incapace di trovare equilibrio, ma neppure le potenze sapevano offrigliene uno convincente. Per il “concerto europeo” era già un buon risultato che il “buco nero” balcanico non risucchiasse Intesa e Triplice, scatenando quella guerra mondiale che in effetti sarebbe stata a breve originata, nel quagmire balcanico, dall’assassinio a Sarajevo nel giugno 1914 di Francesco Ferdinando (erede al trono asburgico) e consorte, da parte dello studente bosniaco e nazionalista serbo Gavrilo Princip.
Le due guerre balcaniche si concludevano con un armistizio armato, più che con una pacificazione. Tra gli stati che avevano cosparso di lutti e distruzioni la regione, mutando di continuo fronti e alleanze, guadagnava forse la sola Romania, anche se i paesi a maggioranza ortodossa gioivano comunque per la fine dell’impero ottomano. Ne usciva male il Montenegro che non aveva saputo prendere Scutari agli albanesi. Scontenti erano serbi e bulgari, irrisi ancora una volta nei rispettivi sogni di “grande Serbia” e “grande Bulgaria”. Soffriva una pessima figura il nazionalismo panellenico, sino al giorno prima militante contro l’oppressione turca e ora impegnato nello scippo (non riuscito) di territorio all’Albania meridionale, da dove l’esercito greco si ritira tra vergognosi saccheggi, incendi distruttivi, ignobili stupri. I cugini greci, inoltre, attizzano l’irredentismo nelle isole egee occupate dall’Italia (Dodecaneso), misconoscendo il dettato degli accordi internazionali.
Molti dei fattori di conflitto di un secolo fa, li avremmo rivisti a fine Novecento nelle guerre della dissoluzione jugoslava. Ora come allora, avrebbe giocato un ruolo nefasto la “faglia” della divisione religiosa tra islam e ortodossia, esaltata dal mai sopito nazionalismo serbo-ortodosso: si sarebbe di nuovo esibita la forza attiva delle potenze, con Stati Uniti e Nato. Estinti gli imperi, non si sarebbe però avuto l’innesco di conflitto globale: se le guerre balcaniche di un secolo fa generarono le condizioni per la prima guerra mondiale, con il coinvolgimento anche di paesi dei continenti americano e asiatico, quelle di fine Novecento hanno portato alla formazione dal basso di nuovi stati nazionali, e alla loro scelta di aderire alla grande famiglia democratica dell’Unione europea.
Questo articolo viene pubblicato anche su Oggi7-America Oggi