Parliamoci chiaro, in fondo lo sapevamo già. Lo abbiamo sempre saputo. Ogni volta che condividiamo un articolo di giornale, una foto, ogni volta che scriviamo un pensiero o semplicemente un buongiorno, dentro di noi c’è sempre quella sottile sensazione di avere addosso gli occhi di un convitato di pietra che ne potrebbe fare un uso “improprio”. Non che la cosa ci abbia mai più di tanto intimorito, visto che sui social continua a trovarsi di tutto. Nessuno, per esempio, nonostante l’allarmismo generale e i molteplici appelli lanciati nel tempo, ha mai ben compreso che le foto dei propri figli, soprattutto quelle dei più piccoli, soprattutto quelle dove si vedono nudità innocenti, con la semplice associazione di un hashtag in pochi minuti fanno il giro del mondo e possono finire nel patrimonio degli orchi che guadagno sul traffico di materiale pedopornografico, spalancando peraltro le porte a ben peggiori scenari e pericoli enormi per l’incolumità dei soggetti ritratti. D’altra parte la giurisprudenza italiana conferma sempre più il suo orientamento a tutela della volontà e della salute del minore, vietando ai genitori, soprattutto se non sono d’accordo fra loro, di pubblicare immagini dei propri figli. La cassazione ha sancito che “i social sono luoghi aperti al pubblico, potenzialmente pregiudizievoli per i minori che potrebbero essere taggati o avvicinati da malintenzionati”. Una recente sentenza del Tribunale di Roma ha persino condannato una mamma a risarcire il figlio con diecimila euro per aver pubblicato le sue foto contro la sua volontà.
Ma, in piena onestà, vedete qualche cambiamento? No, anzi, tutti a intenerirsi per Leone, figlio della coppia social per eccellenza, Ferragni-Fedez, recordbaby che, appena nato, ha avuto il suo profilo Instagram e migliaia di followers al minuto. Amore? Felicità? Business? Forse tutte queste cose insieme. D’altra parte la nostra cultura prevede che la mamma faccia sempre tutto per il bene dei figli. Lei che, fin dalla notte dei tempi, sa sempre come stai, cosa provi, chi frequenti, che problemi hai e quali siano le soluzioni giuste, cosa vuoi mangiare, cosa ti piace indossare. Lei che ti segue e ti controlla come nemmeno il grande fratello. A pensarci bene il primo insuperabile algoritmo della storia è stata proprio la mamma e, a giudicare dalle sentenze sempre più frequenti, a volte si comporta esattamente come le app di cui tanto parliamo ora. Dunque perché dovrebbe spaventarci Cambridge Analytica e simili, con quelle loro manovrine di basso profilo che sono il segreto di Pulcinella. Ci rubano i dati, lo sappiamo. E’ ovvio che, qualunque sia il bottino di un furto, l’uso che se ne fa non sia consentito dalla legge.

Possibile, mi chiedo, che ci sia qualcuno tanto ingenuo sulla terra da credere ancora che, se un’azienda ha in mano le nostre anamnesi comportamentali, non pensi di doverle usare per il tornaconto suo o di chi la paga? Questo tipo di accaparramento nasce proprio a questo scopo. E’ su questo semplice principio che si basa la fortuna economica di Facebook. Davvero mi risulta incredibile che ci sia ancora chi pensa che basti da parte degli sviluppatori di app promettere di cancellare i dati acquisiti per farci salvi dal loro abuso. Siamo così ingenui? Non credo. La risposta degli utenti di Facebook è stata molto più equilibrata e calma di chi ha raccontato sui giornali la storia dei dati usati da Cambridge Analytica per “influenzare” il voto. Nessun panico o esodo di massa. A reagire male sono state le borse, confermando che si tratta di una enorme questione di affari e non di un problema di psicologia di massa. Allora, se residuasse qualche dubbio, scriviamolo chiaramente: quando sul più importante e noto social network del mondo partecipate ai test per sapere chi eravate nella vostra vita passata, come sareste se foste una stella di Hollywood, che faccia avreste se foste dell’altro sesso, qual è il vostro livello di preparazione sulla storia del cinema o se conoscete alla perfezione la grammatica italiana, state dando a quelle simpatiche canaglie degli sviluppatori di app, l’accesso ai vostri dati, alla vostra lista di amici (e quindi ai loro dati), a tutto quello che pubblicate sulla pagina Facebook.
Ve lo chiedono proprio espressamente prima di iniziare qualsiasi giochetto e tutti voi, ogni volta, cliccate ok con entusiasmo (lo capisco dal tono trionfante con cui poi pubblicate il risultato sulla vostra pagina, contenti di aver scoperto che in un’altra vita eravate Marilyn Monroe con una laurea a Oxford e uno yacht di 200 metri ormeggiato a Montecarlo).
Su cosa dovremmo invece indignarci davvero: che ci sia un colossale business basato sul convincimento che noi votiamo in base a cosa l’algoritmo ci propina nel micro (nemmeno tanto micro) cosmo della nostra vita in rete. Questo è il punto della questione, perché tentare di arginare un fenomeno non commensurabile come il furto di dati e il suo utilizzo improprio, nell’era di internet, è praticamente un’utopia e chi vi racconta che ha la soluzione e la panacea per tutti i mali digitali vi sta solo dicendo una scemenza e lo fa, a sua volta, per questioni di interesse economico (un po’ tipo quello che è successo col millennium bug che alla fine risultò solo una grande operazione commerciale).
A scanso equivoci voglio subito dire che io non credo che il voto possa essere influenzato in questo modo tanto da determinare un cambio radicale dell’orientamento politico di un paese. Sarò un’inguaribile ottimista ma, davvero, non penso che i miei simili possano scegliere un partito invece di un altro solo in base a quello che leggono su Facebook. La scelta di un candidato, nell’era delle post ideologie, è il risultato di una serie di fattori tra cui i più importanti sono la vita reale, le difficoltà che si incontrano, le sofferenze, i problemi. Così come non credo che Facebook o qualsiasi altro social, siano diversi da quanto sia sempre accaduto con tv, giornali, sezioni di partito, comitive, circoli di tennis e vita sociale in genere. Viviamo da sempre tutti avvolti dai nostri piccoli ambiti dove scegliamo di frequentare chi ci è affine. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, si diceva. Significa che gli ambienti che frequentiamo ci influenzano per il solo fatto di frequentarli, niente di nuovo sotto questo cielo.
Pensiamo agli anni d’oro delle sezioni di partito, ci si andava persino per giocare a carte. I partiti negli anni sessanta e settanta provvedevano a tutto, ti organizzavano persino le vacanze, facevano le balere dove andavi a ballare, le librerie dove andavi a prenderti i libri, i cineforum dove proiettavano film, tutto era politicamente allineato. I sindacati idem. Persino quando andavi a pregare in chiesa il prete ti diceva per chi votare (per non parlare della mamma, sempre lei, o del papà che ne facevano una questione educativa). Erano tutti perfetti microcosmi, dove ci si nutriva della stessa fede o idea (o ideologia) per tutta la vita senza cambiare mai opinione. Semplicemente andavi in quei posti, che oggi molti rimpiangono con nostalgia, dove ti dicevano quello che volevi sentirti dire, tutto qui. Io credo, invece, che oggi sia tutto molto più laico, disincantato, per certi versi persino più cinico e smaliziato, per questo, al contrario di cosa dice la vulgata comune, meno soggetto ad essere influenzato. I social network sono una porta aperta sul mondo e se una cosa dobbiamo fare è imparare ad usarli, non mettere loro la mordacchia. Soprattutto adesso che ne conosciamo i meccanismi e, quindi, i limiti. Non c’è bisogno di essere particolarmente alfabetizzati. Tutti noi, nella nostra beata ignoranza digitale, ci siamo accorti che se cerchiamo in rete un bed & breakfast in Puglia, per mesi poi ci sorbiamo la pubblicità di ogni bed & breakfast d’Italia.

Altra cosa, però, è la questione politica. Ogni volta che leggo di voto manipolato tramite social network, resto molto perplessa. Primo: quali saranno mai questi fantomatici dati che ci sottraggono per influenzare il nostro voto? La foto della vacanza in Puglia di cui sopra? L’articolo di giornale che abbiamo condiviso sull’ultima strage in Siria? O semplicemente la nostra età? Mi sembra un po’ poco per dire “ok ti conosco, so come prenderti per farti votare chi dico io”. Perché è questo che si sta affermando, il convitato di pietra segue i tuoi movimenti sui social, poi li comunica al candidato che gli ha commissionato la ricerca e quello capisce cosa ti deve far arrivare dall’algoritmo per indurti a votare per lui. È vero, oggi forse avremo una prova in più che questo accade, ma nessuno ha la riprova scientifica che il meccanismo ottenga quello che vuole. A me sembra un meccanismo troppo farraginoso e costoso per un risultato molto aleatorio. Se pubblichi compulsivamente frasi razziste sei tu che stai dicendo agli altri chi voti, non il contrario.
C’è poi un altro elemento che m’infastidisce non poco quando, periodicamente, viene fuori questa storia dei dati usati per manipolare le coscienze politiche. Attenzione perché qui si entra in un terreno spinoso e so che le parole che seguiranno potranno scatenare la fiera dello slogan e del luogo comune, oltre che dell’etichetta politica. Pongo questa semplice domanda con il massimo della serenità: come mai ogni volta che si parla di manipolazione di massa verso un voto, s’intende sempre un voto, diciamo, “anti-sistema”? O c’è qualcosa che mi sfugge o la manipolazione, qui, è un’altra. Non mi sembra che fino a che il mondo s’informava esclusivamente dalla carta stampata e dalla televisione, persino quando contro alcuni direttori del servizio pubblico dichiaratamente di parte si raccoglievano centinaia di migliaia di firme per mandarli via, qualcuno abbia mai gridato al voto manipolato su commissione. Eppure, se parliamo dell’Italia, per esempio, il nostro è un paese in cui il conflitto d’interesse è diventato proverbiale, dove da una parte esistono giornali di partito, dall’altra giornali comunque palesemente di area. Un paese dove lo slogan “fuori la politica dalla Rai” (servizio pubblico radiotelevisivo pagato con i soldi del contribuente) è entrato persino nelle campagne elettorali (paradosso dei paradossi) tanto che i politici stessi (per tabulas origine del male) si pongono il problema di come auto cacciarsi dall’informazione pubblica di cui, evidentemente a sentir loro, hanno fatto scempio.
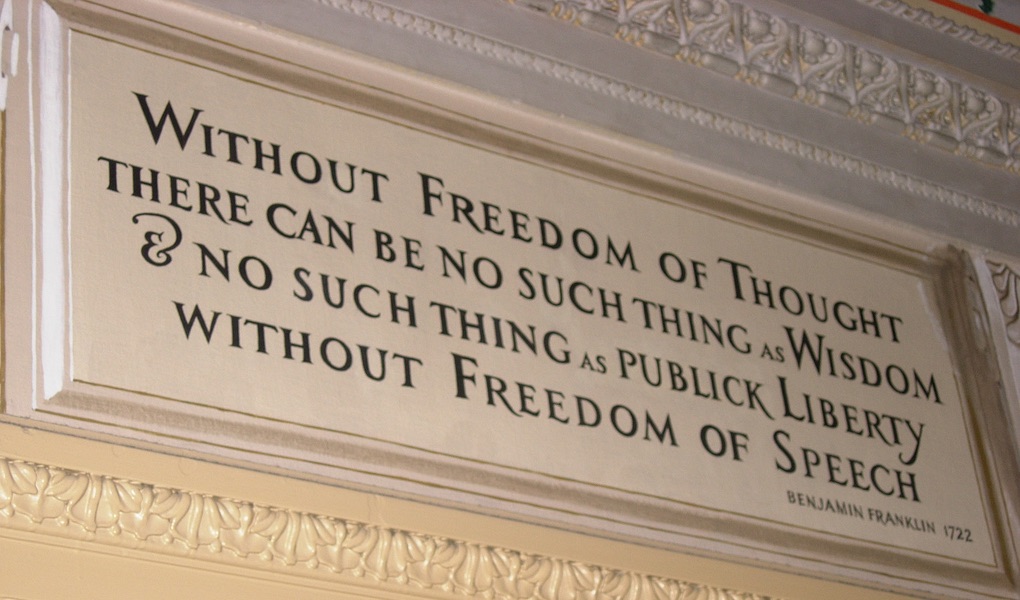
Ora che l’elettorato ha smesso di informarsi esclusivamente da giornali e tv e ha allargato il suo orizzonte con un mezzo d’informazione potenzialmente straordinario, con tutte gli inconvenienti del caso ovviamente, chi può dunque arrogarsi il diritto di dire se la coscienza collettiva sia più consapevole o più manipolata? Su quale criterio? Quale sarebbe il parametro? Il partito che poi vince alle elezioni? Il fatto che negli Stati uniti sia stato eletto Trump piuttosto che Clinton? A me sembra una visione un tantino di parte. Attenzione qui non stiamo parlando di brogli elettorali, argomento serio e concreto che però sembra interessare a pochi. Qui siamo in un campo talmente fluido, talmente attinente alla sfera intellettuale e cognitiva che ogni definizione e regolamentazione finisce per essere più pericolosa e manipolatoria del sedicente algoritmo plagiatore. Perché di plagio 4.0, in fin dei conti, trattasi. Ma il plagio ci riporta direttamente nelle aule di tribunale. Il reato di plagio, in Italia, fu cancellato proprio per questo, perché era molto difficile, se non impossibile, stabilire se un’idea, un atteggiamento, una convinzione, fossero frutto di una coercizione psicologica o di una libera espressione della volontà autodeterminata. Nel 1981 la Corte Costituzionale italiana stabilì “l’inverificabilità del fatto contemplato dalla fattispecie, l’impossibilità comunque del suo accertamento con criteri logico-razionali, l’intollerabile rischio di arbitri dell’organo giudicante”. Vale la pena citare il passo saliente della storica sentenza:
“Fra individui psichicamente normali, l’esternazione da parte di un essere umano di idee e di convinzioni su altri esseri umani può provocare l’accettazione delle idee e delle convinzioni così esternate e dar luogo ad uno stato di soggezione psichica nel senso che questa accettazione costituisce un trasferimento su altri del prodotto di un’attività psichica dell’agente e pertanto una limitazione del determinismo del soggetto. Questa limitazione, come è stato scientificamente individuato ed accertato, può dar luogo a tipiche situazioni di dipendenza psichica che possono anche raggiungere, per periodi più o meno lunghi, gradi elevati come nel caso del rapporto amoroso, del rapporto fra il sacerdote e il credente, fra il maestro e l’allievo, fra il medico e il paziente ed anche dar luogo a rapporti di influenza reciproca. Ma è estremamente difficile se non impossibile individuare sul piano pratico e distinguere a fini di conseguenze giuridiche l’attività psichica di persuasione da quella anch’essa psichica di suggestione. Non vi sono criteri sicuri per separare e qualificare l’una e l’altra attività e per accertare l’esatto confine fra esse”.
Non c’erano criteri nel mondo reale, figuriamoci in quello virtuale che all’epoca non esisteva. La legge che identificava la fattispecie di plagio, dunque, contrastava con i diritti costituzionalmente garantiti. Prima dell’intervento della Suprema Corte, in Italia si rischiava fino a dieci anni di carcere per un reato che facilmente sconfinava nelle scelte amorose, sessuali, politiche e religiose “non allineate”.

Se non è possibile stabilire i criteri di un presunto plagio de visu, come si possono stabilire i criteri di una scelta politica di massa? Con quale sicumera si afferma che Donald Trump, Matteo Salvini, il Movimento Cinque Stelle, siano stati scelti da gente plagiata dagli algoritmi? Chi può decidere e in base a cosa che la scelta delle urne sia dettata da persuasione occulta piuttosto che da maggiore consapevolezza e capacità di informarsi? Ci risiamo. Se voti Clinton sei un elettore intelligente, se voti Trump sei manipolato da Cambridge Analytica. Se voti PD i social vanno bene e Renzi, come Obama, sono degli straordinari esempi di come la politica sui social sia sinonimo di modernità e stile, se voti Di Maio sei un burattino lobotomizzato nelle mani di Casaleggio. Se questo è l’approccio sociale e analitico al problema, sinceramente, non ci siamo.
Delle due l’una: o esiste un problema, e allora esiste per tutti (destra, sinistra, centro e forze antisistema), oppure la questione è altra. Potrebbe essere, per esempio, la paura di chi ha difficoltà ad accettare che in rete di fatto si allarga l’orizzonte delle informazioni (sia per chi le scrive, sia per chi le legge) e quindi si deve fare i conti con la fine del monopolio pubblicistico. Forse il dato che alla tv creda una platea sempre più ristretta getta nello sconforto perché, ovviamente, è un fatto che rosicchia anche il potere di certi dirigenti e di chi informazione vuole continuare a farla in termini propagandistici, allargando la frattura nel patto di fiducia con i telespettatori, esattamente quello che poi fa perdere ascolti e fa preferire altri canali di approvvigionamento notizie.
Certo ora Mark Zuckerberg deve fare i conti con le ripercussioni economiche che tutto questo avrà sulle sue casse. Ma anche con quelle giudiziarie, visto che sono in molti a non credere alla sua buona fede. Per me si tratta sempre e solo di una guerra di soldi. Dà molto fastidio che il fondatore di Facebook sia stato il primo e il più bravo a capire che i dati personali sono un’immensa fonte di guadagno e che quindi abbia trovato il modo di averne molti e gratis da tutti noi. Potrebbe essere anche questo che oggi fa gridare al complotto e alla deriva democratica. Fra poco entrerà in vigore il nuovo regolamento per la protezione dei dati personali varato dall’Unione Europea, la commissaria Ue alla Giustizia, Vera Jourova, le ha cantate chiare al patron di Facebook, occhio che uno svarione simile dopo ti costerà un patrimonio.
Ma il punto che a me interessa è un altro: nessuno che abbia il minimo della consapevolezza di essere al mondo si sognerebbe mai di scegliere un partito con lo stesso criterio con cui sceglie un brano da sentire o una vacanza da prenotare. Se questo accade, ripeto se accade, in maniera tale da determinare le sorti del mondo, allora non è in quel senso che dobbiamo lavorare. Dovremmo cercare di rendere le persone più consapevoli, ma è un lavoro culturale importante che non passa solo attraverso le leggi (anzi quasi mai). È un fattore sociale che necessita la rifondazione dell’educazione civica digitale (oltre che dell’educazione civica tout court), non solo per gli utenti, soprattutto per chi la rete la possiede e la sfrutta. La questione dell’innalzamento del livello culturale dei popoli non nasce con internet e non si risolverà con internet. È un problema che esiste da sempre. La televisione è stata la grande maestra d’Italia, ha alfabetizzato il paese, eppure è anche quella che ha creato la cultura della donna velina, che ha costruito il successo politico di molti, che ha indottrinato. Internet ha lo stesso destino. Sta a noi decidere come usarlo ma a farci lezioni di etica digitale, per favore, non siano quelli che voglio un mondo dove chi vota in un modo è un giusto e chi vota in un altro modo è un imbecille. È questa la manipolazione più subdola e violenta.









