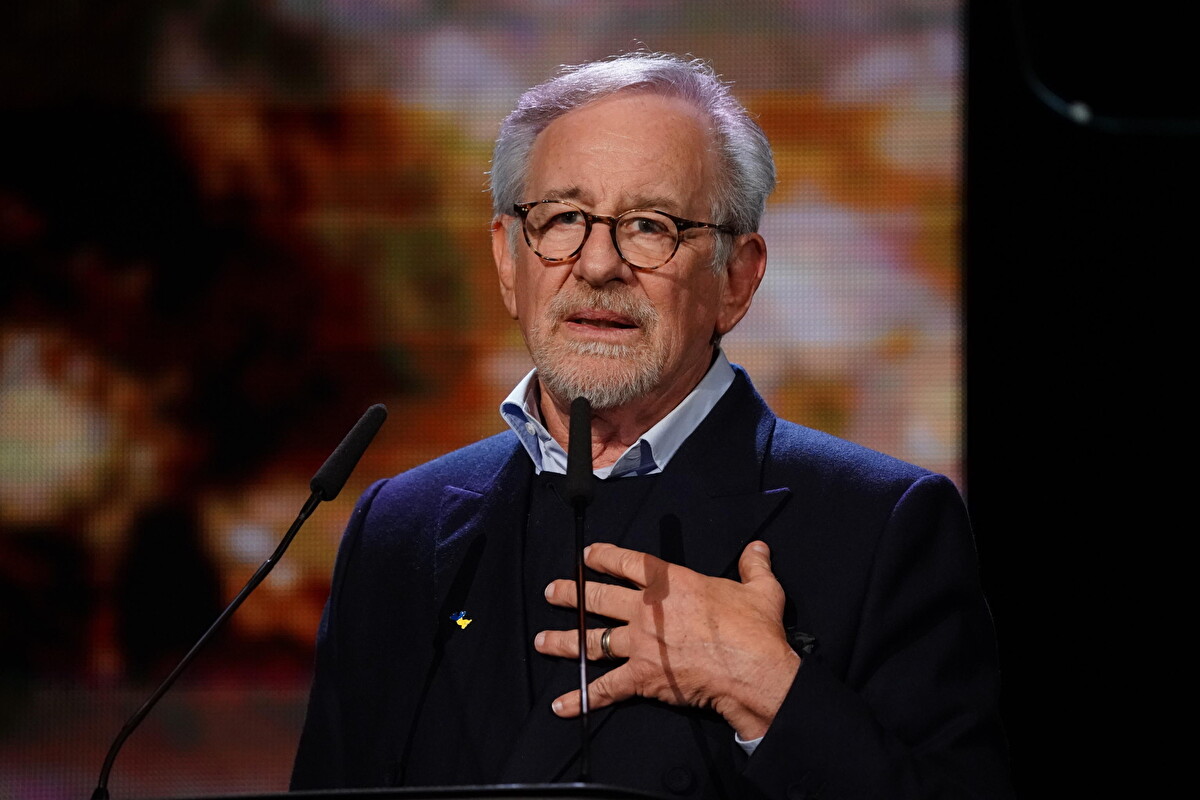La Shoah: il dovere della memoria e la responsabilità di tramandare alle giovani generazioni. I Presidenti della Repubblica italiana: l’esempio e l’impegno.
Sabato 27 gennaio del 1945, faceva particolarmente freddo nella parte meridionale della Polonia, non lontano da Cracovia. Erano quasi le tre del pomeriggio quando un’avanguardia della divisione di fanteria dell’Armata rossa si trovò davanti ad un cancello con la scritta “Arbeit Macht Frei” (Il lavoro rende liberi). Era Auschwitz: il più grande campo di sterminio costruito dai nazisti nel cuore dell’Europa. Ricollegandosi a quella data si celebra il “Giorno della Memoria”, istituito dal Parlamento italiano nel 2000 con voto unanime. Le forze politiche espressero un comune sentire e un identico impegno.
Grazie alla risoluzione, del 1o novembre 2005, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha indicato, sempre il 27 gennaio, “Giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime dell’Olocausto”. Una data fondante per costruire quel “percorso della memoria” tracciato dalla Presidenza della Repubblica per rafforzare la coesione e l’identità nazionale. Il Quirinale protagonista di una politica della “memoria condivisa”, un esempio di pedagogia civile e di valorizzazione di date e di simboli.
La volontà di mantenere viva la memoria della Shoah, di generazione in generazione, è il tema centrale di tutte le celebrazioni che si svolgono al Quirinale. Accanto alle più alte cariche dello Stato significativa è la presenza di sopravvissuti e di studenti che partecipano ai “Viaggi della memoria” e al concorso “I Giovani ricordano la Shoah”. Hanno portato le loro drammatiche testimonianze, solo per citarne alcuni: Sami Modiano, la Senatrice a vita Liliana Segre, Pietro Terracina, la scrittrice Edith Bruck, Alberto Sed e Franco Schonheit.
Le reti televisive e in particolare la Rai dedica alla Shoah ampi spazi di riflessione e di approfondimento con servizi giornalistici, dirette, interviste e testimonianze. La legge istitutiva del “Giorno della Memoria” è entrata in vigore durante la presidenza di Carlo Azeglio Ciampi. Figura da sempre vicino alla comunità ebraica anche per la sua provenienza da una città, Livorno, patria di una prospera comunità che ha dato all’Italia e all’ebraismo un grande maestro di vita, il Rabbino Capo Elio Toaff legato a Ciampi da una lunga e affettuosa amicizia.

Ricorda il Presidente: “da giovane entrai nella casa paterna a Livorno per chiedere un consiglio di studio a suo padre allora stimato e rispettato Rabbino della comunità ebraica di Livorno, poi ci siamo ritrovati, dopo tanti anni, a Roma ma i sentimenti di stima e di amicizia non erano certamente diminuiti nei confronti della famiglia Toaff e di Elio: esempio di grande dignità e ispiratore di sentimenti di fiducia sia come custode fedele delle tradizioni del suo popolo che come cittadino italiano”.
Ciampi fu il primo ad effettuare, nell’ottobre del 1999, una visita di Stato in Israele, nel corso della quale visitò la Sinagoga italiana trasportata a Gerusalemme nel 1952 da Conegliano Veneto, dove era stata costruita nel 1701. Quando la delegazione italiana visitò a Gerusalemme il Museo Yad Vashem ci rendemmo conto, con un nodo alla gola, di non essere mai abbastanza preparati. Ciampi fin dalle prime cerimonie al Quirinale affermò: “C’è anzitutto il dovere della memoria nei confronti di coloro che la barbarie del secolo condusse alla morte, spesso con una ferocia inimmaginabile”.
In più occasioni ha ricordato: “La mia generazione ha vissuto la drammatica esperienza degli ebrei italiani. Le leggi razziali del 1938 segnarono anche il più grave tradimento del Risorgimento e dell’idea stessa della nazione italiana, al cui successo gli ebrei avevano contribuito in modo determinante”.
Ciampi, nel corso del settennato, conferì, onorificenze motu proprio a: Don Aldo Brunacci, Canonico della cattedrale di San Rufino di Assisi, Agata Herskovitz, nota come Goti Bauer, deportata il 16 maggio 1944 ad Auschwitz, Mario Rigoni Stern, scrittore, deportato tra i campi della Prussia orientale e dell’Est europeo e Piero Terracina, deportato il 16 maggio 1944 ad Auschwitz.
Il 25 aprile del 2006 consegnò alla vedova e al figlio di Gino Bartali la medaglia d’oro al valore civile. Nella motivazione si ricorda come il campione con la sua assistenza a quanti fuggivano ai rastrellamenti nazi-fascisti consentì di salvare ottocento cittadini ebrei.
Lo Yad Vashem ha assegnato, nel 2013, a Gino Bartali il titolo di “Giusto fra le Nazioni”. Giorgio Napolitano visitò Israele, nel 1986, come responsabile Esteri del Pci, una visita storica per un dirigente del Partito comunista, incontrò Rabin, Peres e Shamir, riportando le posizioni del partito verso una maggiore attenzione alle istanze della comunità ebraica.
Il nome del Presidente Napolitano è legato a quello di Stefano Gaj Taché ucciso, a solo due anni, nell’ottobre del 1982, nell’attacco terroristico alla Sinagoga di Roma. Il Presidente volle l’inserimento del bambino nelle liste delle vittime di terrorismo e nel 30° anniversario dell’attentato alla Sinagoga, consegnò la medaglia d’oro a ricordo della “Vittima del Terrorismo” Stefano Tachè al fratello Gadiel.

Fu un riconoscimento importante, la morte del piccolo Stefano non più vista come una tragedia solo ebraica ma una tragedia italiana. Al Presidente per il continuo impegno nella lotta all’antisemitismo fu conferito il titolo di Doctor Philosophiae Honoris Causa dell’Università Ebraica di Gerusalemme. Shimon Peres, nel 2014, gli consegnò al Quirinale “The Presidential Award of Distinction”, la più alta onorificenza civile del Paese, per la prima volta la cerimonia avvenne al di fuori del territorio israeliano. Napolitano è stato il Presidente che nel corso delle iniziative per il Giorno della Memoria, ha lanciato un appello inequivocabile per combattere ogni forma di antisemitismo, compreso l’antisionismo.
Queste le sue parole: “Ritengo di poter dire che si sono consolidati – nella coscienza democratica del nostro paese – alcuni fondamentali punti fermi. Innanzitutto, il rifiuto intransigente e totale dell’antisemitismo in ogni suo travestimento ideologico come l’antisionismo: perché in giuoco non è solo il rispetto della religione, della tradizione storica, della cultura ebraica, ma insieme con esso, inscindibilmente, il riconoscimento delle ragioni spirituali e storiche della nascita dello Stato di Israele, e quindi del suo diritto all’esistenza e alla sicurezza”.
Il Presidente nel 2008 volle dedicare le celebrazioni all’epopea dei Giusti: “coloro che salvarono anche le nostre coscienze e che furono i pionieri e i primi costruttori di un mondo di pace”. Nel decimo anniversario dall’entrata in vigore della legge, la cerimonia, con Napolitano, si svolse alla Camera dei Deputati, dove intervenne il Premio Nobel per la Pace, Elie Wiesel. Per Sergio Mattarella è indicativo il suo primo gesto da Presidente, il 31 gennaio 2015, rende omaggio alle Fosse Ardeatine, il luogo dove i nazisti perpetrarono l’eccidio di 335 vittime per rappresaglia contro l’attentato di via Rasella.
Una visita privata che mette subito in evidenza la sensibilità del Capo dello Stato sul tema della “memoria storica” base delle istituzioni democratiche. Nel discorso d’insedamento, del 3 febbraio, ricorda Stefano Tachè “Era nostro bambino, bambino italiano” e il 1 aprile riceve al Quirinale i familiari di Stefano.
Sul tragico episodio ritorna nel trentacinquesimo anniversario dell’attentato parlando di crimine contro l’umanità e gesto vile contro Roma e l’intera Italia. Il 25 aprile del 2017, Mattarella visita a Carpi il campo di Fossoli: “un luogo della memoria tra i più importanti e peculiari del nostro Paese” e incontra i familiari degli internati.
Il Presidente vuole sottolineare come la Costituzione ha le sue radici non solo nella Resistenza ma anche in quell’immane tragedia che è stata la Shoah. Il 30 ottobre dello stesso anno, nel suo intervento all’inaugurazione dell’Anno accademico dell’Università ebraica di Gerusalemme rinnova la condanna del regime fascista: “che aveva ripudiato in modo odioso una componente del suo stesso popolo, quella di origine ebraica, che aveva contribuito – da sempre – alla vita civile del Paese a partire dalla pagina fondante del Risorgimento”.
Nell’ottantesimo anniversario delle leggi razziali, nomina Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, senatrice a vita: per il suo costante impegno a mantenere viva la memoria dell’Olocausto. Il Quirinale nel 2018 allestisce la mostra “1938: l’umanità negata. Dalle leggi razziali italiane ad Auschwitz”, fortemente voluta dal Presidente e curata da Giovanni Grasso e Paco Lanciano.
Mattarella ha nominato Cavalieri di Gran Croce “motu proprio”: Sami Modiano, Edith Bruck, Stella Levi. Sami Modiano ha parlato in diverse occasioni al Quirinale raccontando gli orrori dei campi di concentramento. Edith Bruck, scrittrice, ha portato la sua testimonianza di sopravvissuta raccontando dell’impegno preso, in quelle tragiche circostanze, con le sue compagne di spendere il resto della vita a mantenere viva la memoria. L’onorificenza conferita dal Presidente ricorda il gesto di Papa Francesco che aveva reso omaggio alla scrittrice recandosi nella sua casa di Roma.
Stella Levi fu deportata ad Auschwitz, di tutta la famiglia solo lei e la sorella Renée sopravvissero. Da molti anni vive a New York dove ha contribuito alla fondazione del Centro Primo Levi, impegnandosi nella condivisione della testimonianza e per la conservazione della memoria.
Mattarella in occasione del Giorno della Memoria è sempre intervenuto, lo scorso anno ricordò: “. Gli anni che sono passati da quegli eventi luttuosi non attenuano il senso di sconforto, di vuoto esistenziale, di pena sconfinata per le vittime innocenti che si prova di fronte alla mostruosità del sistema di sterminio di massa – degli ebrei e di altri gruppi considerati indegni di vivere – pianificato e organizzato dal nazismo hitleriano e dai suoi complici in Europa”.
La memoria della Shoah vuole essere, per Mattarella, anche una condanna definitiva delle leggi razziali e delle deportazioni degli Italiani nei campi di sterminio nazisti. Nei suoi discorsi rimarca la vergogna delle leggi razziali che: “rappresentano un capitolo buio, una macchia indelebile, una pagina infamante della nostra storia”.
Il Presidente ricorda i militari italiani deportati nei campi di concentramento tedeschi: “Pochi cedettero in cambio di cibo e di condizioni di vita più accettabili. La stragrande maggioranza, la quasi totalità, rimase compatta, nonostante la fame, i patimenti, il freddo e i maltrattamenti”. Mattarella spesso richiama la necessità di vigilare sulle nuove forme di diffusione dell’odio attraverso il Web. Si tratta di un aspetto che gli sta molto a cuore perché si rivolge ad una platea di giovani che dei social e degli strumenti digitali fanno un uso quotidiano.
Il 18 Aprile del 2023, il Presidente ha partecipato alla “Marcia dei Vivi” l’annuale marcia dei sopravvissuti all’Olocausto che si svolge ad Auschwitz, dove ha incontrato le sorelle Tatiana e Andra Bucci sopravvissute agli orrori di Birkenau. Tra le iniziative volte a preservare la memoria ne ricordiamo due per la loro peculiarità. La cerimonia organizzata, ogni anno, davanti al Consolato Generale d’Italia a New York con la partecipazione di diplomatici, rappresentanti del mondo ebraico, della collettività italiana ed italo-americana impegnati nella lettura di tutti nomi degli ebrei deportati dall’Italia e dai territori italiani.
E l’iniziativa “Le Pietre d’Inciampo” nate dall’idea dell’artista berlinese Gunter Demnig: piccole targhe di ottone della dimensione di un sanpietrino poste davanti all’abitazione delle vittime su cui sono incisi nome e cognome, data di nascita, luogo di deportazione e data di morte. “Un inciampo – come sottolineò Napolitano nel gennaio del 2015 – non fisico, ma visivo e mentale, per far fermare a riflettere sulle atrocità naziste ogni volta ci si passa vicino”.