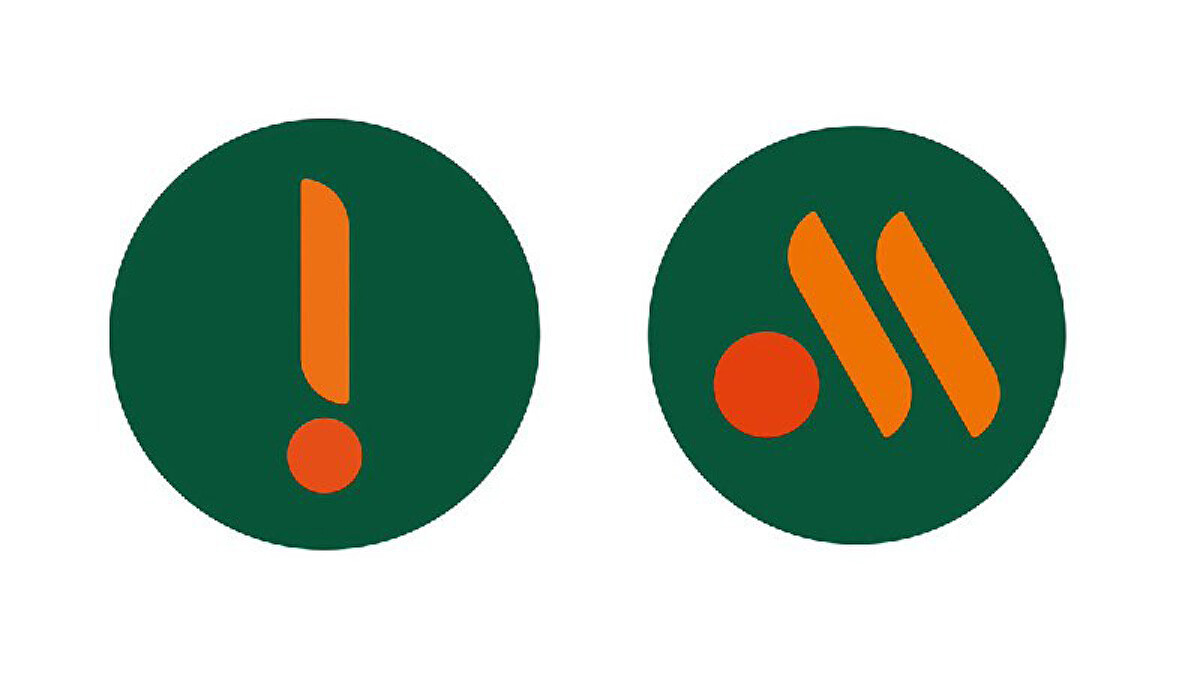Nel 2023 saranno 150 anni dalla nascita di Enrico Caruso, ma non è per un omaggio formale che il grande tenore è stato celebrato all’Istituto Italiano di Cultura con la proiezione del documentario Enrico Caruso: The Greatest Singer in the World, che ho realizzato e diretto grazie alla produzione della Direzione per gli Italiani all’estero (MAECI), rappresentata dal ministro plenipotenziario Luigi Vignali. La Direzione infatti sta investendo in programmi che valorizzano il contributo italiano alle culture di immigrazione, riconoscendo il circolo virtuoso dell’emigrazione e del suo ritorno in patria arricchita dall’esperienza, fino al “turismo delle radici” che supporta la curiosità dei nipoti degli italiani emigrati a visitare i loro paesi d’origine e riscoprirne tradizioni e caratteri.
Progetto ricercato a fondo per anni, questo ritratto inedito del tenore che ha reso il Metropolitan il tempio dell’opera, oltre che nel documentario ha trovato espressione in una mostra dal significativo titolo Da Napoli a New York, che si è tenuta, con grande successo, al Museo Archeologico Nazionale di Napoli da dicembre 2021 alla fine di aprile 2022 ed è stata raccontata in un illustratissimo catalogo bilingue, mostra che verrà replicata a New York nel futuro prossimo. Caruso infatti è il capofila di una schiera di artisti dello spettacolo italiani (in particolare meridionali) che hanno animato i media americani dalla fine dell’800 fino ad oggi, ai quali ho dedicato il volume Napoli/New York/Hollywood pubblicato in inglese da Fordham University Press, e tradotto in italiano nel 2021. New York infatti al tempo della grande emigrazione era la più grande città italiana fuori dal territorio nazionale, caratterizzata da una vivace comunità di performers che hanno esportato la macchietta (Farfariello, Eduardo Migliaccio, che ha scritto anche un paio di canzoni per Caruso) e la sceneggiata, composta per esempio da Francesco Pennino, napoletano, nonno materno di Francis Coppola.
Caruso rappresenta l’introduzione all’opera del verismo, uno stile interpretativo lontano dai virtuosismi della Grand Opera, con arie cantabili, vicine alla sensibilità moderna, composte da Puccini e Mascagni, che trovano l’interprete perfetto in lui, che con i dischi porta l’opera nei salotti della borghesia del mondo intero, e con le incisioni di canzoni napoletane, frutto della prima industria culturale moderna in Italia, raggiunge il pubblico popolare e sdogana il napoletano come lingua franca degli emigrati della costa Est, figli per lo più del regno delle due Sicilie.

Parlare di Caruso oggi significa andare oltre il mito per ragionare su come egli rappresenti la modernità, l’innovazione delle tradizioni operistiche e mediatiche, in effetti la prima celebrity , il primo utilizzatore intelligente delle tecnologie dei media, che con la sua voce e le sue precoci incisioni ha creato l’industria discografica là dove c’era il progetto di una macchina per l’ufficio. Un napoletano spontaneo e carismatico che affascina (e utilizza) la stampa, i cinegiornali e i media, raggiungendo, da New York, capitale della comunicazione planetaria dopo il primo conflitto mondiale, incluso il cinema non ancora migrato in California, un pubblico vastissimo, internazionale e interclassista.
Tale è la sua presa sui newyorchesi che riesce a superare lo “scandalo dello zoo”, una montatura scaturita dal profondo pregiudizio antitaliano che circondava allora l’immigrazione meridionale negli Stati Uniti, considerata non del tutto bianca. Mentre si osannavano gli artisti dell’opera, del balletto, del teatro, come Tommaso Salvini e Eleonora Duse, che, ricordiamolo, recitavano in italiano, e si conosceva persino D’Annunzio, gli americani disprezzavano i meridionali di carnagione olivastra che hanno costruito (e abbellito con stucchi e mosaici) grattacieli e la metropolitana, emarginandoli e costringendoli in uno stereotipo duro a morire. E’ la cultura WASP che associa l’italiano alla mafia; niente di tutto ciò accade in America Latina, dove gli italiani diventano classe dominante, o nel Mediterraneo. L’unico modo per sconfiggere luoghi comuni e pregiudizi è conoscere la storia dell’emigrazione italiana, le sue differenze regionali e tra costa e costa, riconoscere che il pregiudizio anti-meridionale nasce in Italia e che quella italiana è un’emigrazione cosmopolita, che si porta dietro e impone la propria cultura, coltivando la vite e le arance in California, trasformando la pizza in fast food, e definendo gli standard della moda, dell’arte, dell’architettura, del Made in Italy, anche quando non si chiamava così. Mai pensato che i primi grattacieli ricalcano l’immagine del campanile di san Marco a Venezia?