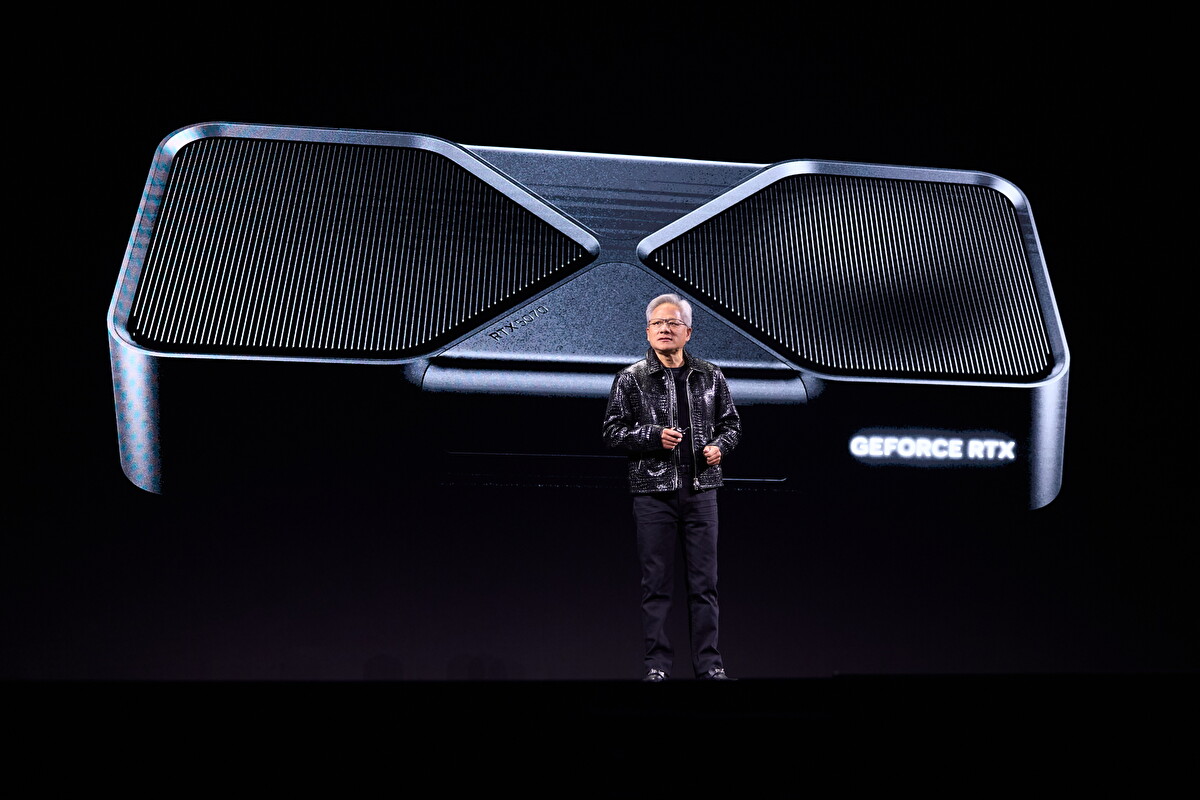Tribeca Film Festival 2018. La storia dell’arte, intesa davvero come racconto della nascita, vita e talvolta morte di un’opera, è un viaggio affascinante e sorprendente. Lo ha dimostrato il meraviglioso quadro rinominato “Woman in Gold”, il ritratto di Adele Bloch-Bauer dipinto da Klimt ed esposto alla Neue Gallerie di New York. O si nota nei viaggi avventurosi intrapresi dalle creazioni di Raffaello e Da Vinci, rubati e nascosti sotto ai letti e oggetto di progetti politici utopici e strumentali. Gli artisti e ciò che producono permettono di raccogliere tanti pezzi di un vasto puzzle, il tempo in cui viviamo, e di prendere coscienza di ciò che accade di generazione in generazione. “The Man Who Stole Banksy”, documentario diretto da Marco Proserpio e presente al Tribeca Film Festival 2018, parte anche da qui, dalla storia di un’opera dipinta su un muro che rappresenta anni di battaglie politiche, faide, scontri religiosi e questioni irrisolte, e soprattutto che divide la Striscia di Gaza da Israele.
Banksy ha creato di recente un murales politico qui a New York, in questo caso dedicato all’incarcerazione della pittrice e giornalista-attivista Zehra Doğan. Come cambia l’importanza di un’opera di street art a New York e in Palestina?
“Per rispondere userò un concetto di Ron English (artista che ha disegnato a sua volta il West Wall in Palestina, ndr) spiegato poi nel documentario. Con Banksy accade la stessa cosa che accadde con John e Yoko. Ovunque lui va i media lo seguono, tutti lo cercano. Di conseguenza Banksy ha capito che può portare l’attenzione dove vuole. Il contesto cambia sicuramente, New York è una vetrina”.
Per questo motivo Walid, un taxista palestinese “protagonista” del documentario, decide che il murale della discordia, il soldato israeliano che chiede i documenti a un asino, deve sparire. Perché poi non approfittarne per creare un servizio ancora più utile: venderlo. Walid taglia letteralmente la porzione di muro con l’opera di Banksy ed è pronto a lasciarlo a qualche ricco collezionista d’arte. L’asino offende la comunità palestinese e, mi spiega Marco, “qui subentra la relatività dell’importanza di un’opera d’arte. Banksy è un’artista per noi occidentali, ma in Palestina si domandano cosa vuole insegnare questo londinese graffittaro a loro”.

Banksy lo possiamo trovare sui magneti da frigorifero e su un muro che ogni giorno separa un problema da un altro problema. Lavorando su questo progetto credi che la street art stia perdendo il controllo e i diritti su ciò che produce?
“Fa parte del gioco: puoi sfruttare la strada come luogo pubblico, e non puoi impedire foto e diffusione di quelle foto. A livello pratico è difficile reclamare un tuo diritto e copyright: in teoria la street art è illegale e se fai qualcosa d’illegale puoi non avere la possibilità di chiedere il diritto d’autore. Ha senso, altrimenti il giudice diventerebbe critico d’arte e dovrebbe stabilire se e quando un murales è da proteggere. Con Banksy è come appendere una banconota per strada, è così famoso che tagliare un muro con una sua opera significa entrare nel mercato di scambio delle opere di strada, vendute anche a grosse cifre a insaputa degli artisti. Era nata come voce per gli emarginati, ora questa tendenza a staccare e rivendere le opere, credo, cambierà il loro approccio”.
Tagliare un’opera da un muro significa anche tagliarla dal contesto in cui si trova. E questo può voler dire che stiamo privando di senso il lavoro dell’artista. Se spostassimo il murale di Zerocalcare da Rebibbia non capiremmo al 100% cosa significa uscire dalla metropolitana ed entrare nel quartiere. Per non parlare del muro di Berlino smembrato al punto che si può bere un caffè a NY in una piazzetta dove troneggia proprio una sezione.
“Visitando Betlemme, prima di Banksy, si notava che il turismo era legato alla religione e alla nascita di Gesù. I turisti scendevano da un autobus, entravano nella chiesetta e se ne andavano a casa. L’economia di Betlemme ora è anche artistica: è cambiata la rotta, ci sono tantissimi giovani in quartieri improbabili che vogliono assolutamente vedere gli artwork. Intendo dire che le location sono scelte appositamente, puntigliosamente, proprio dove ci sono i clashes o nei refugee camps. L’opera è fatta per portarti esattamente lì e nel suo contesto, che ha intorno. Senza quel luogo l’opera perde valore e probabilmente anche interesse, ma quando ho seguito questo pezzo di Banksy ho notato che comunque faceva parlare di Palestina. Quindi il messaggio continua a circolare se non succede quello che è successo a Donkey Documents: finire chiuso in una scatola dove nessuno lo può vedere o farsi un’idea critica. L’arte che finisce così non parla più a nessuno”.

Credi che si possa parlare anche di “preservare” la street art grazie al mercato che ci hai mostrato nel documentario, o siamo solo davanti a una caccia all’opera da mettere in salotto?
“Ogni caso è a sé, dipende dall’opera e dalla sua storia. Non c’è bianco e nero, diversi personaggi hanno fatto ciò che ha fatto Walid, ma le motivazioni o l’approccio sono differenti. Esistono critici e studiosi che vogliono proteggere la street art, perché ormai non è più arte da ragazzini, come si è cercato di mantenere traccia degli affreschi”.
Gli street artist della western society sono presuntuosi?
“I Palestinesi sono abituati ad avere il biggest canvas al mondo. La polemica è più profonda: vanno, fanno un disegno o lo cercano per una foto, scattato il selfie sono già a Tel Aviv per il prossimo volo aereo. C’è una forma di tourism activism, termine interessante e che credo vedremo sempre di più. Lo stesso Banksy, che fa ragionare ed è provocatorio, e ha a cuore la situazione in Palestina, non sta comunicando a loro o lavorando per loro: sta mostrando all’Occidente qualcosa che l’Occidente non vede”.
“The Man Who Stole Banksy” è diretto da Marco Proserpio, prodotto da Filippo Perfido e Rai Cinema, con la voce narrante di Iggy Pop.