Lucchese, 34 anni, esordiente sul podio a 22, diplomata in pianoforte, composizione e direzione d’orchestra al Conservatorio Verdi di Milano (con il massimo dei voti e la lode), vanta un curriculum lungo due pagine. Ha ricoperto il ruolo di direttore principale ospite dell’Orchestra della Toscana e del Festival Puccini a Torre del Lago, si è esibita alla Fenice e al Teatro Colon di Buenos Aires, ha collaborato con le Fondazioni del Maggio Fiorentino e dell’Arena di Verona oltreché con interpreti del calibro di Placido Domingo, Carla Fracci, Eleonora Abbagnato. Ciò detto, è diventata famosa anche fuori dal recinto esclusivo della musica seria, affermandosi come fenomeno mediatico. Amata o detestata in egual misura e per identici motivi. Quali? Possiede bellezza e telegenia che elargisce con generosità; si distingue per i capelli biondi fluenti che ne fanno la vibrante testimonial di uno shampoo; non veste il frac d’ordinanza ma l’abito lungo da sera, nero o rosso fuoco; è stata inserita da Forbes Italia fra i cento leader giovani del futuro; Amadeus l’ha voluta in giuria a Sanremo; stuoli di ragazzi disertano rap e trap per affollarne i concerti; è seguitissima sui social dove posta le sue playlist — tra Schubert, musica elettronica, pop e rock — e la ricetta del sauté di vongole agrumato che le piace cucinare. “Fa strategia di marketing”, è l’accusa di chi la denigra. Unita a un tranciante: “E’ bravissima, ma a vendere il proprio brand”.
Visualizza questo post su Instagram
Sono altresì divisivi due elementi su cui insistono i detrattori — e le detrattrici, altro che sorellanza. Il primo è politico: consigliera culturale del ministro Sangiuliano, governo Meloni, ha pubblicato su Instagram una foto assieme alla premier con la didascalia “Giorgia ti meriti tutto” e ha ricevuto il premio Atreju da Fratelli d’Italia. Il secondo consiste nel definirsi direttore d’orchestra, al maschile, anziché direttrice. Il motivo? “Nei manifesti trovo scritto abitualmente: orchestra diretta dal maestro tal dei tali, quando si tratta di un uomo. Se sono io, la dicitura è invece: orchestra diretta da Beatrice Venezi. Come se non avessi titolo”. Di qui la scelta: “Voglio essere chiamata direttore perché considero discriminatorio il termine direttrice: sottolinea a priori una differenza di genere. Quel che conta è il ruolo, l’autorevolezza sul podio. La musica classica è un sistema di potere dove il sessismo è ancora ben radicato: siamo lontani da una effettiva parità e questo è il vero problema, non il lessico. E poi inglesi e americani usano la parola conductor, che è neutra, così come direttore nel vocabolario italiano è un sostantivo maschile inclusivo”. Peccato che alle colleghe non piaccia affatto. Una per tutte, l’ucraina Oksana Lyniv, direttrice musicale del Teatro comunale di Bologna: “Per secoli determinate professioni erano destinate agli uomini. Chiedo che mi si chiami direttrice, altrimenti sarei l’eccezione in un sistema patriarcale”. Qualche altra collega è stata molto meno soffice: “Rischia di riportare indietro di oltre 50 anni le conquiste delle donne”.
Inutile citare Plautilla Bricci, che si fece architettrice nella Roma del Seicento, oppure Giulia Lama, pitora con una bottega tutta sua nel Settecento veneziano: la discussione prosegue senza che si veda il traguardo. Nel frattempo Beatrice si applica alla scrittura. Dopo Le sorelle di Mozart — ritratti di donne eccellenti nella musica dimenticate dai libri di testo — ha appena pubblicato Puccini contro tutti, edito da Utet, nel centenario della morte. Sottotitolo: arie, fughe e capricci di un genio anticonformista. Sospettato oggi di maschilismo più o meno latente..
Visualizza questo post su Instagram
Perché contro tutti, chi erano i nemici?
“Il panorama dell’epoca era tradizionalista e conservatore. Per le avanguardie esisteva solo la musica mitteleuropea: un rivoluzionario come Puccini, innovatore attento a ogni aspetto della modernità, era impossibile da digerire. Così avversavano la sua battaglia. Che consisteva, come ha sintetizzato lui stesso, nel fare opera di melodia”.
Il pubblico come rispose?
“Il successo fu immediato. Puccini entrò in sintonia con chi si sedeva a teatro, la sua capacità comunicativa si fondava proprio sulla melodia. Era il sentimento a parlare alla gente, la forza espressiva, l’intensità. In una lettera ai librettisti si raccomandava: Forza, spremetevi il cuore e il cervello e preparatemi quella tal cosa che faccia piangere il mondo. Emozione e commozione lasciavano la platea e il loggione in uno stato di sospensione, nell’attesa di scoprire quel che sarebbe accaduto. Esemplare è il soggetto di Edgar, che ruota attorno a una frase: fra la coppa e le labbra c’è ancora spazio per una sciagura. Lo rimproveravano di essere retorico e mirare alle corde più semplici. Tutto il contrario: non è stato un autore facile, piuttosto un genio della musica colta del Novecento, tuttora uno degli autori più rappresentati ovunque. Con lui si chiude la grande stagione del nostro melodramma”.
Gli fecero pagare il trionfo?
“Manon, la terza opera, l’aveva issato sulla vetta a 35 anni. Troppo presto e troppo in alto per l’Italia, che da sempre pratica l’invidia come sport nazionale. La critica prezzolata lo attese al varco: una gazzarra inscenata ai suoi danni accolse la prima milanese della Butterfly nel 1904. Il capolavoro eterno annegato tra i fischi: un linciaggio, lo definì Giacomo furioso. Però l’ispirazione non ne risentì, del resto era nato agonista. Viveva per la musica, la sua religione, che voleva appartenesse a tutte le epoche e a tutto il mondo”.
Era l’incubo dei librettisti, perfino quelli più famosi. Non si capivano?
“La collaborazione con d’Annunzio non decollò per un contrasto fra due ego giganteschi. Inoltre la scrittura del Vate non si confaceva alla sua costruzione narrativa, che rispondeva a un’azione drammaturgica immediata. Certo la forma della parola era importante, ma doveva essere funzionale al teatro del melodramma più che alla letteratura in sé. Stesso problema lo afflisse nel rapporto con Pascoli, Verga e De Roberto. In fondo, a soddisfarlo pienamente furono solo Illica e Giacosa, anche se il tocco finale portava sempre il marchio di Giacomo: e muoio disperato, nell’aria celeberrima di Cavaradossi, è una sua invenzione”.
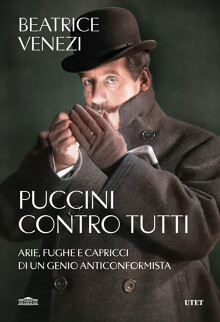
Amava le barche e le auto veloci, la caccia e il buon cibo. Ma più di tutto le donne?
“Tra vita e palco costituiscono un elemento intercambiabile. Puccini mette in scena eroine tragiche già in principio, perché è nella loro natura che diventino tali nello svolgimento della trama. Se le fa morire non è per odio o disprezzo, anzi: è stato un grande curioso delle donne che incontrava, per poi proiettarle nell’opera con una profondità psicologica superiore ai personaggi maschili”.
Ne ha avute tante?
“Tante, sì. Chissà quante volte avrà usato nella realtà lo stratagemma della gelida manina da riscaldare. Ma nessuna s’è mai sentita abbandonata al momento del congedo. Elvira, sua moglie, è stata la donna per la vita. L’unica. La chiamava con il nomignolo Topisia: era Tosca la gelosa ed era l’algida Turandot. Accettò i tradimenti di Giacomo, a malincuore, perché riconobbe un suo bisogno: devo amare per poter scrivere, ripeteva. Ed era vero”.
Oggi non gliela farebbero passare liscia.
“Sicuramente. I testi di certe lettere, firmate Giacomo Puttani, lo porterebbero direttamente davanti al plotone della censura. E la cosiddetta cultura della cancellazione ne bollerebbe l’animo di toscanaccio politicamente scorretto, l’uomo delle zingarate che pare uscito da Amici miei“.
Aveva un modo di vivere in anticipo sui tempi?
“È stato un precursore, l’uomo che ha incarnato il gusto e la sensibilità del secolo breve. Fu tra i primi a diffondere immagini e video della sua vita privata, come fanno gli influencer in rete. Reclamizzò un dentifricio che finì in tutte le case. Viaggiò instancabilmente in giro per il globo, celebrato sulle prime pagine dei giornali da star qual era. Soprattutto la sua concezione della regia operistica anticipò il ritmo incalzante del cinema, unendo al plot una cura straordinaria nel ritratto interiore dei personaggi. Il procedimento porta lo spettatore all’identificazione: lo stesso motivo per cui ci attraggono le serie televisive”.
Puccini un secolo dopo: che cosa è cambiato nella musica?
“Nel tempo grandi direttori hanno scansato il suo repertorio, viziati dal pregiudizio deteriore sull’autore pop. Passati cent’anni è ora di fare la pace con la Storia e ristabilire la verità, che è chiarissima nei suoi capolavori. Puccini l’aveva predetto: all’alba vincerò“.












