Andare alle radici dei fenomeni storici è operazione sempre molto complessa. Risulta particolarmente vero quando sono in campo sommovimenti sociali, perché ne sono protagonisti attori collettivi spesso di difficile decifrazione sotto il profilo sociologico e ideologico. Anche per questa ragione è apprezzabile lo sforzo compiuto da Antonio Alosco (già docente di Storia Contemporanea presso l’università degli Studi di Napoli), con Alle origini del sindacatoconfederale italiano: socialisti e cattolici, poi i comunisti, saggio edito da D’Amico editore, dedicato alla Confederazione Generale del Lavoro. La Cgl fu soggetto di grande rilevanza per la storia sociale della prima metà del Novecento, scarsamente indagato dalla storiografia sociale e sindacale italiana per le ragioni che di seguito appariranno evidenti.
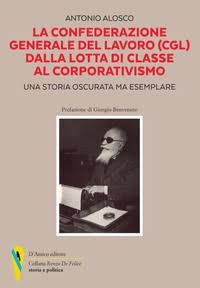
Nella storia unitaria, la Cgl (1906-1927, poi in clandestinità ed esilio), è la prima grande organizzazione di rappresentanza dei lavoratori. Costituita a Milano come sintesi tra strutture verticali (federazioni delle categorie produttive) e orizzontali (Camere del lavoro, su base territoriale) dei movimenti esistenti (Leghe di resistenza, ad esempio), deve la nascita e gran parte dell’indirizzo strategico, all’opera di Rinaldo Rigola, socialista molto legato a Filippo Turati, leader mai domo nonostante il limite della cecità rimediata in un incidente sul lavoro, dirigente di grande visione nonostante fosse autodidatta.
Rigola (diresse la Cgl sino al 1918) ha ben chiaro che il sindacato non è un partito. Se questo punta al potere per attuare politiche di interesse generale, il sindacato deve operare perché siano realizzate riforme utili ai ceti operai, attraverso giusto salario, condizioni di lavoro umane, misure di welfare eque e garantiste.
La fedeltà a quest’impostazione si dimostrerà preziosa in tre momenti topici della vita politica, e di converso sindacale, della nazione. Quando, nel biennio rosso delle lotte e occupazioni (1919-1920, agitazionismo e massimalismo si sommeranno al tradizionale riformismo confederale. Quando, nel 1921, i comunisti abbandoneranno il partito Socialista per mettersi al servizio delle strategie bolsceviche e russe. Quando il fascismo, con legge n. 563 del 3 aprile 1926, varerà lo stato corporativo, cancellando lo spazio di agibilità del sindacato confederale libero: solo l’azione dei sindacati fascisti aveva ora corso legale, e a sostegno del principio una magistratura speciale era chiamata a risolvere le controversie sul lavoro.
Nel caso del biennio rosso, mentre il partito Socialista diventa il primo del paese sorpassando i Popolari di Sturzo, Cgl (e Federazione dei metalmeccanici, Fiom) conducono un’intelligente occupazione delle fabbriche, ottenendo il taglio degli orari di lavoro e il riconoscimento di maggiori diritti e tutele per le rappresentanze nelle fabbriche. Nel 1921, gli scissionisti socialisti che danno vita al partito Comunista non riescono a tirarsi dietro pezzi significativi di Cgl, fortemente ancorata al riformismo socialista e al principio dell’autonomia dalla politica. Tra i comunisti circola già il principio del sindacato come cinghia di trasmissione della volontà dei politici.
L’avvento del corporativismo e della legislazione che proibisce le azioni di lotta e gli scioperi, comporta l’autoscioglimento della Confederazione, nei primi giorni del gennaio 1927, salvo la sua ricostituzione in esilio, un mese dopo, per volontà di Buno Buozzi, segretario generale dal 1925. Buozzi, fuoriuscito a Parigi, porta la Cgl nella Federazione Sindacale Internazionale, con sede ad Amsterdam (Alosco racconta che il segretario generale succeduto a Rigola, Ludovico D’Aragona, nel 1920 aveva sottoscritto a Mosca l’accordo per una centrale internazionale alternativa a quella dei sindacati liberi di Amsterdam).

La vicenda sulle Internazionali, fa capire quanto fosse stato importante, per evitare certe derive della confederazione, l’autorevole ruolo di Rigola, esercitato anche dopo l’abbandono della segreteria. Alonso dedica attenzione al personaggio e ai suoi movimenti nel ventennio: lo trova mai organico al fascismo, ma sempre cocciutamente impegnato nel sociale offrendo cultura ed esperienza ai sindacati corporativi, il che spiega il dissidio che insorgerà con Buozzi. Nel dopoguerra Rigola si batterà per l’unità sindacale e collaborerà nel costituire nel 1950 l’Unione Italiana del Lavoro, Uil, confederazione radicata nell’esperienza laica e socialista.
Nonostante i dissensi tra il riformista socialdemocratico Rigola e la galassia sindacale comunista, nel dopoguerra quella figura storica del sindacalismo meriterà, dal leader comunista della Cgil Di Vittorio – come documenta Alosco – “sentimenti di gratitudine” e il riconoscimento di “una statura culturale superiore alla media”. L’autorità, anche morale, di Giuseppe di Vittorio si spingerà, come ricorda Alosco, sino a decidere di sostenere finanziariamente Rigola, così onesto e disinteressato da essere in stato di indigenza.












