Non che si sentisse particolare bisogno di un’ennesima pubblicazione sulla caduta per mano giudiziaria della cosiddetta “prima repubblica”. Tuttavia il libro messo insieme da Alessandro Bernasconi ha più di un pregio, approfondendo temi rimasti meno esplorati nel trentennio trascorso dai processi del pool di Milano. Bernasconi è uno che di giustizia penale ne mangia, e parecchio.
Da sempre impegnato nella diffusione di cultura giuridica su temi come l’esecuzione penale, i collaboratori di giustizia, la criminalità organizzata, le prove in giudizio, è avvocato specializzato in diritto penale dell’economia, presidente di organismi di vigilanza sulla responsabilità amministrativa da reato, professore ordinario di Diritto processuale penale all’università di Brescia. Nel saggio Montesquieu non abita qui inserito nell’opera collettanea Mani pulite, pubblicata dall’editrice Luni, così come nell’Introduzione al libro, rileva la serie di “abdicazioni” (non tanto la politica, quanto la stampa e la tv, un quarto potere che si fece fiancheggiatore invece di voce vigile e critica) che hanno consentito, tra il 1992 e il 1994, che la magistratura tracimasse fuori dal percorso assegnatole dalla costituzione, aprendo un conflitto di poteri senza precedenti.
Il libro edito da Luni è suddiviso in quattro parti: il contesto internazionale, i partiti politici, i giornali, il sistema della giustizia penale. Ne scrivono, con Bernasconi, professori universitari (Zeffiro Ciuffoletti, Igor Pellicciari), avvocati (Salvatore Sciuto, Giuliano Spazzali), magistrati (Piero Tony), giornalisti (Stefano Zurlo, Ugo Finetti, Luca Fazzo, Filippo Facci). Il linguaggio, rigoroso sotto il profilo della ricostruzione storica e dei riferimenti accademici, è discorsivo e di appetibile lettura. Agli autori preme sostenere la tesi del sottotitolo: che negli anni novanta dello scorso secolo, l’Italia abbia sperimento un “governo dei giudici”, e che quell’aberrante conflitto tra poteri costituzionali si sia reso possibile grazie a complicità che non l’hanno né impedito né limitato. Lo fanno con argomenti solidi, anche se non sempre documentati (documentabili?).
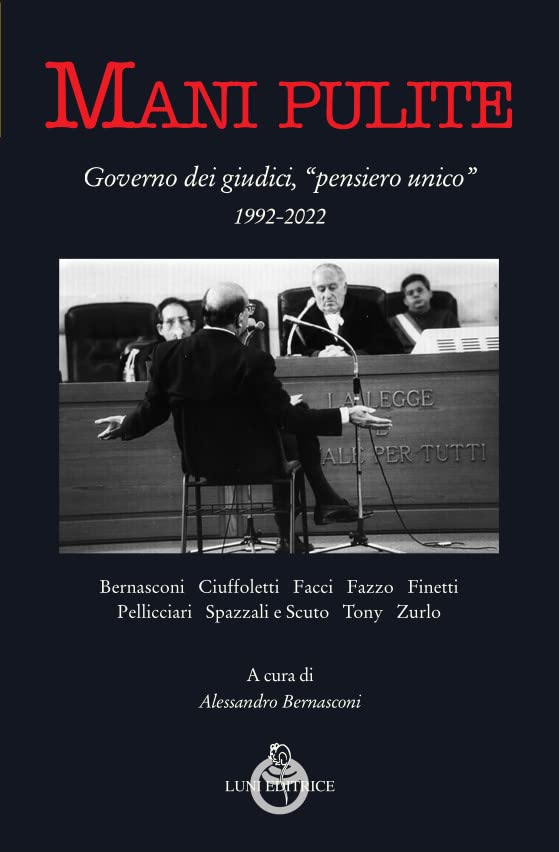
Tangentopoli cambiò la storia dell’Italia, spazzando via il ceto politico al governo dagli anni sessanta (riassumibile nella formula “centro sinistra”), eliminando dal gioco le personalità al vertice dello stato o candidate ad occuparlo (il Caf Craxi, Andreotti, Forlani), aprendo una falla nella diga dei partiti politici eretta dall’art. 49 della costituzione repubblicana (attraverso di essa sarebbe passata la pletora di raggruppamenti populisti monocratici da Forza Italia a Lega, M5S, con annessi grillismi, calendismi, renzismi), generando il non cessato trentennio italiano d’impoverimento economico, sociale e morale. In quella stagione si registrò anche il primo governo tecnico della storia repubblicana, con l’incarico a Ciampi dell’aprile 1993: un precedente che avrebbe autorizzato abusi successivi.
Queste evidenze non comportano che le inchieste del pool milanese (Francesco Saverio Borrelli, Antonio Di Pietro, Gerardo D’Ambrosio, Ilda Boccassini, Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo, Armando Spataro, Francesco Greco, Tiziana Parenti) non avessero ragioni da vendere per essere condotte. In discussione, anche nel libro curato da Bernasconi, è il come siano state condotte, e se, negli inquisitori, non vi fosse un animus pugnandi anche politico e ideologico, oltre che strettamente legato all’applicazione della legge.
L’interrogativo è da sempre radicato in almeno tre circostanze obiettive: le modalità ai limiti del codice di procedura penale con le quali venivano condotti indagini e interrogatori (ampiamente documentate nel libro coordinato da Bernasconi), la loro unidirezionalità (i comunisti, nonostante prove evidenti a carico, furono esclusi da indagini approfondite), la continua fuga di notizie dalla procura con il titillamento mai pago che il gruppetto di giornalisti collaterali esercitava sull’opinione pubblica muovendola a piacimento del pool contro questo o quell’obiettivo politico e imprenditoriale.
Sono elementi di giudizio che portano gli autori del libro a chiedersi se Mani pulite abbia avuto “origini solo interne o sia stata in qualche modo eterodiretta”. E poi, guardando alla prospettiva paese, se il costume e la cultura italiani siano rimasti intrappolati, in conseguenza della campagna mediatica di Tangentopoli, in un “pensiero unico fondato su logiche moralistiche e giustizialistiche.”
Come ha scritto il magistrato Piero Tony nel suo contributo, la “sindrome della sentinella” della legalità, “sbocciò” nella procura di Milano per la pretesa di sostituire metodi spicciativi a “regole di rito e debito di ruolo”. Così facendo la procura accantonò gli unici strumenti in grado di combattere nel profondo la corruzione: “cultura e giustizia sociale”. Sono i due fattori, sottolinea Tony, che nella medesima stagione italiana, guidarono l’azione del magistrato Giovanni Falcone.












