Uscito nel 2003 e pubblicato in Italia da Adelphi nel 2004, “Leggere Lolita a Teheran” è uno di quei best seller mondiali la cui forza è quella di rimanere sempre attuale, oggi più di ieri.
Tradotto in 32 paesi, il libro è il più rappresentativo della scrittrice iraniana Azar Nafisi, professoressa di letteratura inglese prima presso l’università Allameh Tabatabei di Teheran e poi della Johns Hopkins University di Washington, dove si trasferì nel 1997. Leggendo o ascoltando le notizie che da giorni ci vengono dall’Iran e da Teheran, dove da settimane imperversano manifestazioni per una ragazza uccisa a causa di un velo portato male, è stato naturale riprendere tra le mani questo libro dove ognuna delle ragazze protagoniste potrebbe essere, oggi come allora, una combattente per la libertà.
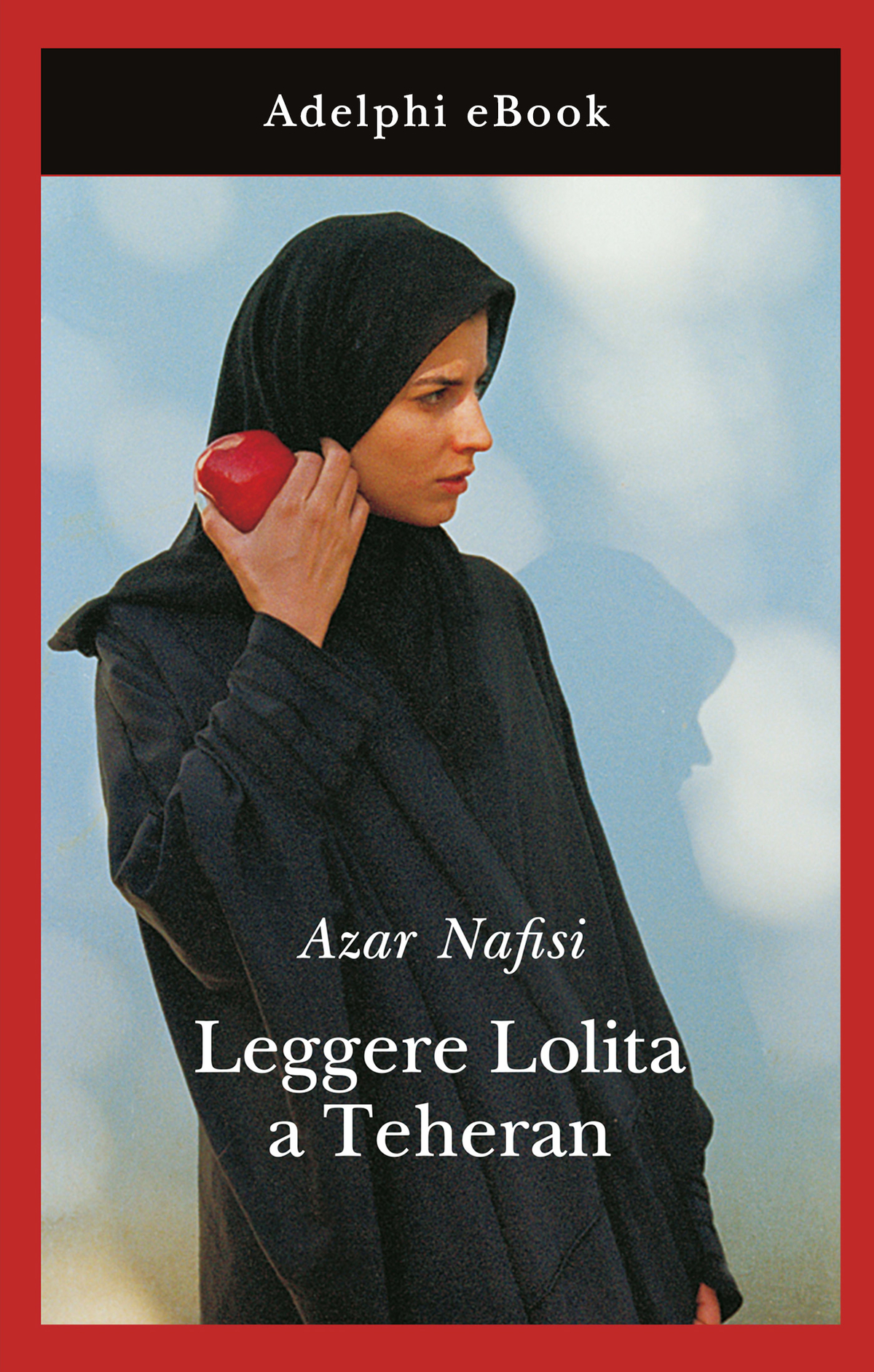
Analizzando “Leggere Lolita a Teheran”, infatti, ci rendiamo conto di come la scrittrice, camuffandolo da libro di analisi letteraria dei capolavori occidentali, scriva in realtà un libro di denuncia sociale e politica, dove l’amarezza più grande non è quella della perdita di un sogno, ma della cecità che a quella perdita ha portato. “Non abbiamo capito” scrive la Nafisi, ”non abbiamo voluto capire”.
Il libro prende avvio dalla decisione della scrittrice di lasciare l’Università per organizzare un seminario segreto di letteratura occidentale, i cosiddetti libri proibiti, con le sue sette migliori studentesse. Il contesto storico in cui veniamo catapultati è quello della rivoluzione islamica del 1979, che porta alla destituzione del sovrano Mohammad Reza Pahlavi e alla sua sostituzione con l’ayatollah Khomeini, che instaura un regime dittatoriale basato sulla negazione totale di qualunque diritto e libertà le donne avessero mai avuto. La letteratura assume qui, per tutte loro, un’importanza vitale, al punto da mentire a tutti, mariti, padri, figli, famiglie, pur di riunirsi il giovedì mattina, in quel salotto dove ognuna di loro può essere se stessa.
L’immagine delle ragazze che entrano e si spogliano della veste lunga e del velo è indimenticabile nella nostra fantasia, così come agli occhi commossi di chi raccontando ricorda. Ci viene in mente un’immagine con cui la Fallaci descriveva le donne iraniane mortificate dalle vesti nere: sembrano sciami di pipistrelli umiliati. La letteratura per tutte loro rappresenta la libertà, quel mondo immaginario che allarga i loro orizzonti, le loro vedute, che le lascia sbalordite in desideri che non conoscono e che spingerà quasi tutte loro, alla fine, a lasciare il paese. Libertà, donne e letteratura sono qui strumento di ribellione, perché, come mette in evidenza la Nafisi, a capire dove stessero andando le cose furono le donne per prime. “Quante storie per un pezzo di stoffa“, le dice uno dei suoi studenti più brillanti quando iniziano le espulsioni per le insegnanti che si rifiutano di portare il velo.
“Se un giorno perdessi la fede, sarebbe lo stesso che morire e dover ricominciare da capo in un mondo senza garanzie”, confessa una delle ragazze. Ma se agli uomini era vietato bere alcolici che nessuno infatti serviva e vendeva, era però concesso non soltanto di sposarsi più e più volte – l’età per contrarre matrimonio venne abbassata per le donne/bambine a nove anni – ma potevano anche avere infinite amanti stipulando quelli che furono chiamati contratti temporanei. Alle donne, di contro, era vietato persino stringere la mano ad un uomo. Tutto questo dopo gli anni in cui l’iran, pur sotto il potere assoluto dello Scià, aveva goduto di una certa libertà: si poteva bere il vino, la birra, la vodka e il whisky, anche se si continuavano a torturare gli arrestati con sevizie da Medioevo; si poteva ballare e nuotare in costume da bagno e lavarsi i capelli dal parrucchiere mentre dagli elicotteri gettavano i prigionieri politici nel lago Salato; non si fucilavano gli omosessuali, le prostitute, le adultere e si viveva solo per vendere il petrolio agli europei. In parole povere si viveva all’Occidentale, mentre si insegnava ad odiare l’America soprannominata il Grande Satana e gli americani.

Dicono che il privato è politico: non è vero, naturalmente, scrive la Nafisi, anzi al centro della lotta per i diritti politici c’è proprio il desiderio di proteggere noi stessi, di impedire al politico di intromettersi nella vita privata. Pubblico e privato sono legati da un rapporto di interdipendenza, ma ciò non significa che siano la stessa cosa. E qui che entra in gioco la letteratura, vista come un ponte che li modifica di continuo l’uno rispetto all’altro, per sopravvivere a quel mondo, a quella società, a quelle leggi, a quella mancanza di libertà bisognava per forza crearsi un mondo immaginario dove ognuna fosse l’eroina del libro che più amava.
Anche se l’eroina era un personaggio negativo, la si invidiava perché era libera di fare qualunque cosa: amare, tradire, offendere, non è la realtà che le ragazze cercano nella letteratura, ma “un’epifania della verità”.
Leggere per loro non è un lusso ma una necessità, ed è solo parlando di libri che riescono ad aprirsi, a emozionarsi e a raccontare ognuna la propria storia. Il peggior crimine di un regime totalitario è costringere i cittadini, incluse le vittime, a diventare suoi complici. L’unico modo per spezzare il cerchio e smettere di ballare con il carceriere è tentare di conservare la propria individualità, ciò che sfugge a ogni possibile descrizione eppure distingue ciascun essere umano dai suoi simili. L’intellettuale “fallito” è quello che merita più stima perché non piegandosi al regime è rimasto fedele a se stesso, felicemente povero ed emarginato, ma libero.

La Nafisi resiste fino al suo limite perché insieme a pochi cerca di salvare almeno l’università, che come l’Iran avevano tutti contribuito a distruggere, scrive, rimanendo sempre più convinta che la più grande libertà concessa all’uomo è l’indipendenza di pensiero, e in quel contesto era come se la situazione politica avesse divorato tutto, tutto tranne la letteratura. Con la piena acquiescenza e la complicità di tutti noi, scrive con rammarico, alla morte di Khomeini : gli abbiamo concesso tutto, non solo le torture, gli assassinii, la guerra, ma anche di plasmare quel sogno di cui adesso, con la sua morte, piangevamo la fine.
La scrittrice non fugge infatti nemmeno durante gli otto anni di guerra con l’Iraq di Saddam Hussein, nonostante i figli piccoli, il pericolo costante, gli allarmi, i rifugi, la chiusura a intermittenza delle lezioni. Rimane finché, finalmente, non si rende conto che il futuro si sta allontanando da lei. Interessante alla fine è l’interpretazione che insieme alle ragazze da riguardo alla sharia e alla visione della donna nell’islam, vivere nella repubblica islamica dell’Iran è come fare sesso con un uomo che ti disgusta, scrive, fingi di essere da qualche altra parte, provi a dimenticarti del tuo corpo, anzi lo odi il tuo corpo, e lo stesso facciamo qui, tutti. Fingiamo sempre di essere altrove, oppure progettiamo di andarci o magari lo sognamo soltanto.
Solo chi è ossessionato dal sesso ne impone una visione peccaminosa, e vive il corpo come qualcosa di cui vergognarsi. Quello che ci rendeva cosi vicine a Lolita, afferma la Nafisi, era proprio la perversa collusione fra vittime e carnefice. Un bel romanzo è quello che riesce mostrarci la complessità degli individui e fa si che tutti i personaggi abbiano una voce, e non c’è rigo di questo romanzo da cui non ci arrivi l’eco di una o più voci che difficilmente riusciremo a dimenticare, nel bene e nel male. La scrittrice riesce nel suo intento che è quello di farci leggere il suo romanzo come se fosse qualcosa da inalare e da tenere nei polmoni.












