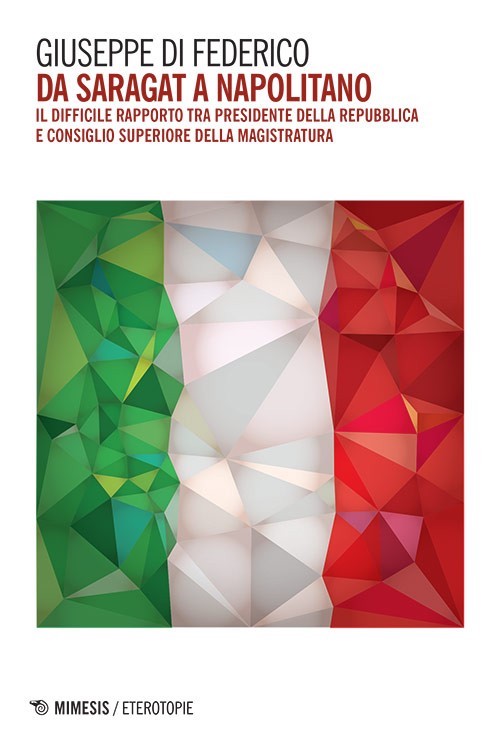 Da Saragat a Napolitano. Il difficile rapporto tra Presidente della Repubblica e il Consiglio Superiore della Magistratura” (Mimesis, 2017), di Giuseppe Di Federico, indiscussa autorità in materia di Ordinamento Giudiziario, è un saggio: perciò, dottrina, analisi, fonti. Ma è anche il documento di una sofferenza. Vi si tratta di “difficili rapporti”: “fra CSM e Presidente della Repubblica”, che è anche Presidente del CSM. Ed essendo il Quirinale “Garante della Costituzione”, a ben vedere, vi si tratta, semplicemente, di democrazia. Così, mentre, le movenze di una Repubblica Giudiziaria paiono sempre più incupire animi e istituzioni, a chi si volesse chiedere come ci siamo arrivati, e dove stiamo ruzzolando, quest’opera offre un’ipotesi.
Da Saragat a Napolitano. Il difficile rapporto tra Presidente della Repubblica e il Consiglio Superiore della Magistratura” (Mimesis, 2017), di Giuseppe Di Federico, indiscussa autorità in materia di Ordinamento Giudiziario, è un saggio: perciò, dottrina, analisi, fonti. Ma è anche il documento di una sofferenza. Vi si tratta di “difficili rapporti”: “fra CSM e Presidente della Repubblica”, che è anche Presidente del CSM. Ed essendo il Quirinale “Garante della Costituzione”, a ben vedere, vi si tratta, semplicemente, di democrazia. Così, mentre, le movenze di una Repubblica Giudiziaria paiono sempre più incupire animi e istituzioni, a chi si volesse chiedere come ci siamo arrivati, e dove stiamo ruzzolando, quest’opera offre un’ipotesi.
Vi imbattete in una formula come “Attribuzioni del Consiglio” e certi cognomi, Saragat, Leone, presto evocano la grandezza della scena; le pagine vi prendono per mano e il timore dell’inadeguata conoscenza svanisce. Comincia qui, sembra suggerire l’Autore, il guasto, lo squilibrio costituzionale ed istituzionale tra Giustizia e Politica. Il CSM, il Parlamento, la Presidenza della Repubblica. Attraverso questi tre Soggetti si svolge la trama di un assedio e di una penetrazione.
Il primo strappo si consuma quando il CSM afferma di voler istituire, mediante una Commissione Speciale “per la programmazione giudiziaria”, un rapporto diretto con il Parlamento; niente da fare, dice Saragat nel 1968: uno scrive le leggi, l’altro le applica. Altrimenti chi deve applicarle finirebbe, per lo meno, per collaborare alla loro stessa scrittura; fra Palazzo dei Marescialli e Parlamento occorre la mediazione del “Duplice Presidente”, come vuole la Costituzione. Sembra che non ne venga altro. Incidente chiuso.
Ma Di Federico, pronto, ci mostra alcune parole: si adotti, scrive il CSM, “una soluzione diluita nel tempo, ‘anche sotto il profilo tattico’ ”, “senza però considerare ciò un fatto compiuto”. Ed ecco che, dietro l’armistizio sulle “Attribuzioni del Consiglio”, si schiude un CSM-Temporeggiatore: che china la testa per poi rizzarla più alta.
Così può accadere che, otto anni dopo, eletto Leone, la pretesa di “interloquire” direttamente con il Parlamento, non solo verrà riproposta, ma diviene oggetto di espressa previsione normativa: il nuovo Regolamento Interno del CSM, tenacemente, obliquamente, ammette ciò che era stato proibito: il Consiglio, d’ora in poi, potrà presentare una sua “Relazione al Parlamento sull’amministrazione della giustizia”.
E, con Leone, viene in luce anche un altro carattere di questi “difficili rapporti”; è l’intersecarsi del piano “ordinamentale”, vale a dire: gli uffici, la catena di comando, con il piano processuale, quello in cui l’Apparato si fa “operativo”: dunque, indagini, processi. Saragat era stato vistosamente sconfessato: perchè, si chiede l’Autore?
Avanza un’ipotesi: fondata sulla viva testimonianza di alcuni consiglieri. Fino ad allora, leggiamo, quel Presidente aveva serbato “un certo malanimo verso la magistratura”; ma, dopo l’insorgere dello scandalo Lockheed, “era improvvisamente cambiato”; “La riforma dello statuto (Regolamento Interno, n.d.r.) del CSM venne messa a punto proprio nel periodo di maggiore crisi di Leone”; quindi, l’intersecarsi dei piani: “ed i consiglieri erano pienamente consapevoli che Leone non avrebbe fatto obiezioni”.

E Pertini, Cossiga.
Il primo interviene ancora su questo “diritto all’attrito”, perseguito verso Governo e Parlamento. Correva il caso del dott. Carlo Palermo (che pure si concluse con gravi censure a suo carico). Il CSM disse: il Procuratore Generale è un magistrato, il magistrato male ha fatto a considerare un “esposto” del Governo (Craxi) su un altro magistrato; questo tema va portato in Consiglio; e se Pertini dice che non si può, sbaglia. Non si disputa, dunque, di dirette censure a questo o quello: ma di “Ordine del giorno”, e di quali poteri abbia il Presidente nel comporlo. La forma e la sostanza.
Come uscirne, senza che l’attrito accenda uno scontro? Semplice: conta avere affermato “il principio” che Egli non può autonomamente “interloquire”; poi, sul caso specifico, ci si può anche fermare: se non oggi, certo domani, si affermerà la “soluzione diluita nel tempo”, e censurare il Governo diventerà un “Ordine del giorno” come un altro. “Interloquire” direttamente: stessa espressione, ma impiegata in modo opposto: il CSM può con il Parlamento; il Presidente non può con il CSM.
A Cossiga, “un amico” a cui il saggio è dedicato, espressamente vanno pochi accenni. Mancherebbe “il dovuto distacco”. Ma aleggia nel testo.
Altro giro. Elezioni del Vicepresidente”. Il Vice presiede “Il Comitato di Presidenza”, governa nascita e sviluppo dell’Ordine del Giorno, sotto il quale, si è visto, scorre la linea di faglia fra i Poteri. Deve essere scelto extra ecclesiam, cioè fra i componenti eletti dal Parlamento. Per il CSM, componente “togata”, è allora di decisiva importanza, rileva Di Federico, “propiziare un rapporto di tipo solidale” con il candidato.
Come? “Sulla base di impegni programmatici”. Cossiga, conscio di quell’alfabeto semiesoterico, aveva saputo obiettare alla pari: l’elezione del Vice-Presidente avviene, senza soluzione di continuità, nel corso della prima seduta; e, quando lo vota, il Consiglio “è seggio elettorale”: non si può discutere mentre si vota, ci mancherebbe. Poco male, si era abbozzato in Consiglio; c’è la regola aurea: attesa e poi rilancio.
Infatti, con Scalfaro che, in quanto Presidente, della Repubblica e del CSM, ha “per primo partecipato al Congresso dell’ANM” (un associazione privata), tutto scorre; la seduta non viene dichiarata chiusa durante l’elezione: semplicemente, viene sospesa “per un giorno”. E un altro crinale è superato.
Acquisita l’elezione del Vice Presidente, secondo “un rapporto di tipo solidale”, un’altra questione si affaccia: le “pratiche a tutela”. Un assoluto inedito, che traduce il “tutti per uno uno per tutti”; basta una dichiarazione, un’intervista di un qualsiasi soggetto, più o meno severamente critiche su un episodio, ed è “un vulnus” all’autonomia, all’indipendenza, al prestigio e alla credibilità dell’intera magistratura.
Di Federico, vigile, ricorda cosa bolle in pentola: la “tutela” implica una censura, verso chi avrebbe “pregiudicato”, con le sue parole, indipendenza e autonomia della magistratura; dunque, implica un contegno istituzionale attivo da parte del CSM.
E, quando esso si volge ad istituzioni elettive o di governo, rileva l’Autore, ci si pone su un crinale scivolosissimo: si tratta di atti “assolutamente e radicalmente estranei alle competenze attribuite al CSM dalla Costituzione e dalle leggi”; perchè, “l’organo di autogoverno in nessuna misura deve intestarsi poteri di indirizzo politico.”. Si fa echeggiare Cossiga. E invece, per Scalfaro, le “pratiche a tutela” sono “un mio dovere di fronte alla Costituzione”.
Ciampi, Grand commis d’etat, si pone fra prudenza e competenza. Non è del tutto arrendevole; tuttavia, è certo un CSM che ha ormai conquistato l’“accesso diretto” al Parlamento e al Governo. Il Consiglio era stato concepito dai Costituenti entro un equilibrio: nei limiti di “Ordinamento Giudiziario” o “Amministrazione della giustizia”, poteva rilasciare pareri sui disegni di legge del Ministro Guardasigilli: ma solo se richiesto; ora, sia, anche, su quelli di iniziativa parlamentare, che sugli emendamenti durante la discussione, e pure se non richiesto: cioè, in via “preventiva”.

Eppure, sui ritardi con cui si coprono le direzioni degli uffici giudiziari, sulle correnti che, ormai, impropriamente governano il Consiglio, Ciampi non manca di essere ironicamente deciso: “comprendo ‘le affinità elettive’, ma non le ‘discipline di gruppo”. Vorrebbe che i capi degli uffici diventassero tali dopo “una seria e approfondita valutazione”, e non “sulla base di puri e semplici dati anagrafici o di anzianità ovvero di semplice assenza di demerito” . Ma Di Federico nota “il suo pessimismo”.
Le valutazioni di professionalità ridotte a fraseggio burocratico, ci accompagnano fino a Napolitano, che “ha fatto gli interventi più numerosi e puntuali”: tanto da averne tratto, caso unico, una raccolta ufficiale, pubblicata dallo stesso Quirinale (e dedicata alla memoria del dott. Loris D’Ambrosio, suo Consigliere Giuridico per sei anni, fatto oggetto, sue parole, “di una campagna violenta e irresponsabile”).
Si ripercorrono, e aggravate, tutte le maggiori piaghe (inefficienza; dirigenza; profili disciplinari; ordini del giorno; pareri sulle proposte di legge); ma il discorso, parole del Presidente, si fa “spinoso” sull’ufficio del Pubblico Ministero: sorta di compendio di ogni “difficile rapporto”.
Secondo lui, la durata dei processi è “il problema più grave della giustizia”, e “rende poco credibile l’argomento secondo il quale ogni provvedimento giudiziario può trovare nel sistema le sue correzioni” (prima piaga).
L’inefficienza, però, potrebbe essere almeno parzialmente ridotta, grazie al potere di direzione dei Procuratori-Capo; ma il CSM nega “qualsiasi forma di gerarchia” interna agli uffici giudiziari, perchè si pone esso quale unitario “vertice organizzativo della magistratura”, all’insegna di una vera e propria “ideologia organizzativa” (seconda piaga), che si vorrebbe animata dalla “diffusione del potere fra tutti i magistrati”: “una favola”, nella icastica espressione di un autorevole Consigliere (Aniello Nappi).
Così, però, si consolida solo una sfuggente “atomizzazione” della funzione inquirente, facile preda di una logica perversa, fatta di “…pratiche spartitorie…”, “…interessi lobbistici…”, “…malsani bilanciamenti fra le correnti…”, che incide, infine, pure sulla effettiva responsabilità disciplinare (terza piaga). E se interviene una nuova legge, avendo il Consiglio acquisito il preponderante governo sull’Ordine del giorno (quarta piaga), si possono facilmente formulare circolari che la esautorino: non solo un parere via via “espanso”, ma, peggio, un compiuto potere interpretativo che, rileva il Presidente, fa assumere al Consiglio “ruoli impropri”, “in via paranormativa” (quinta piaga).
Di Federico pare concludere, con Napolitano: ha provato “a lanciare messaggi nella bottiglia, non sapendo chi vorrà raccoglierli. E bisognerebbe che li raccogliessero tutti, perchè abbiano effetto”. E solo la metafora del naufrago poteva suggellare queste limpide pagine.
Il saggio non arriva a Mattarella. Ma ci arriviamo noi, facendo nostro il suo dirsi “sconcertato” dal presente spettacolo: frutto putrido di una lunga, corale, organica, deliberata e perseguita “corrosione”.












