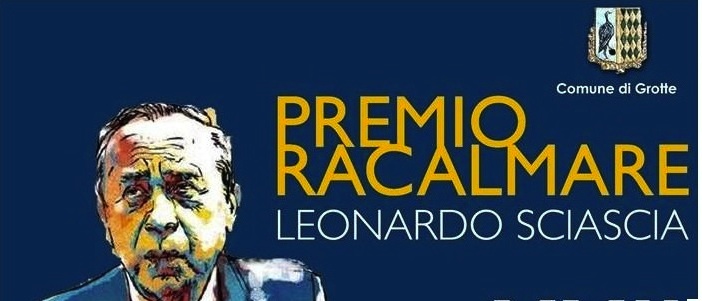Giuseppe Grassonelli è un pluriomicida. E’ siciliano, di Porto Empedocle, e sul finire degli anni ’80 cominciò a sparare. Uccise molte persone. Dal 1991 è recluso: la sua pena è l’ergastolo. Ha scritto un libro, a quattro mani con il giornalista Carmelo Sardo. E’ stato incluso nella terna delle tre opere letterarie che, per il 2014, concorreranno per il premio “Racalmare”, intestato a Leonardo Sciascia. Uno dei giurati, il critico Gaspare Agnello, per protesta si è dimesso. Ha motivato le sue dimissioni contestando che “un ergastolano che si è macchiato di crimini efferati, e le cui ferite sono vive nelle carni delle sue vittime” possa ambire ad unire il proprio al nome di altri storici protagonisti del premio, come lo stesso Sciascia, Consolo e Bufalino.
Giuseppe Grassonelli è un pluriomicida. E’ siciliano, di Porto Empedocle, e sul finire degli anni ’80 cominciò a sparare. Uccise molte persone. Dal 1991 è recluso: la sua pena è l’ergastolo. Ha scritto un libro, a quattro mani con il giornalista Carmelo Sardo. E’ stato incluso nella terna delle tre opere letterarie che, per il 2014, concorreranno per il premio “Racalmare”, intestato a Leonardo Sciascia. Uno dei giurati, il critico Gaspare Agnello, per protesta si è dimesso. Ha motivato le sue dimissioni contestando che “un ergastolano che si è macchiato di crimini efferati, e le cui ferite sono vive nelle carni delle sue vittime” possa ambire ad unire il proprio al nome di altri storici protagonisti del premio, come lo stesso Sciascia, Consolo e Bufalino.
La dichiarazione è perentoria, come si addice ad una frase che sostiene un moto di indignazione e di passione. E tuttavia, fuori di quel contesto emotivo, rimane sospesa in un limbo di pretensione moralistica e affanno logico.
Il critico dimissionario, ha infatti voluto imprimere uno stigma supplementare alla sua protesta: “non è nemmeno collaboratore di giustizia”. Che se tale fosse stato, pare d’intendere, la sua indignazione sarebbe stata un po’ meno indignata, l’indegnità un po’ meno indegna, gli omicidi un po’ meno omicidi.
E così, per l’inevitabile destino che sempre avvince le vittime della retorica -la retorica del premio, la retorica della memoria, la retorica del premio alla memoria- Leonardo Sciascia risulterebbe postumo e comprensivo interprete della delazione, del “pentito”. C’è da credere che il critico, di cui prontamente è stata divulgata la risalente amicizia con Sciascia -e sempre in Sicilia, e non solo in Sicilia, in vista di un uditorio sorge maestoso il vezzo di esibire comunanze e confidenze con un nobile caduto o semplicemente trapassato, di stendere le insegne dell’appartenenza ad un circolo ristretto, ad un gruppo di intima e quasi esoterica elezione, il siciliano “buono” invece essendo quello che non ha il genio del gruppo, rilevava Sciascia a proposito di Ettore Majorana- c’è da credere, dicevo, che il critico si sia distratto dall’opera e si sia rappreso nella critica: la sua personale e insondabile critica.
Giacchè, altrimenti, rimarrebbe inspiegabile accostare il nome di Sciascia ad un’idea men che distante, men che sprezzante verso l’ambigua figura del “pentito” e alla pretese di comprensione e meritevolezza che il “collaborare con la giustizia” implicherebbero, così come risalta da quel “nemmeno”: forse sfuggito a significare l’unica ragione possibile, ammissibile, accettabile, perchè un omicida, mono o pluri, condecentemente figurasse ad esigere lustro letterario.

Giuseppe Grassonelli e Carmelo Sardo
Ma, come sempre nelle cose di ogni giorno, l’imprevisto è dietro l’angolo, a scompaginare ordini e lindure che si vorrebbero concluse e, quasi ducescamente, tetragone. E non stupisce, se pensiamo che Sciascia seppe sempre cavare inquietudine feconda dalla minuta osservazione del semplice e del consueto, dell’apparentemente semplice e dell’apparentemente consueto, s’intende: quel “le cose sono semplici”, fatto declinare al suo Candido Munafò, risuona di inconcussa ironia volterriana, di epigrafe del contrario, e di tutta la dolorosa sapienza della scepsi solitaria e immedicata che a Vitangelo Moscarda, personaggi fra i più presenti alla corda pirandelliana del Maestro, fa dire che lui è vivo e non conclude, perché la vita non conclude.
Perciò nemmeno io (e torna il “nemmeno”) ardisco concludere: anche perché nel racconto di Grassonelli c’è una frase che più sciasciana non avrebbe potuto essere. Scrive costui che quando decise di cominciare a vendicare gli omicidi subiti con omicidi inflitti, lo fece perché convinto che “lo Stato e Cosa Nostra fossero la stessa cosa”. Pensiero fiacco e disfattista, che tuttavia pare rinvigorirsi di inquietante autonomia se sostenuto da 23 anni di reclusione senza “pentirsi”, senza negoziare, statualmente, legalmente, perché così fan tutti, morti con verbali, sangue con protocolli dichiarativi.
A questo vigore del debitore che paga, e perché paga ritiene di preservarsi una sia pur ammalata e minima dignità, una certa idea dell’Italia è indefessamente estranea. Ancor più estranea se l’autonomia non passa per il lavacro del “pentimento”, della simonia, del baciare le mani giuste e capaci di risollevare agli onori del mondo.
Contro questo tramestio losco e ai suoi occhi fariseo e immondo, Sciascia si è speso tutta la vita, non temendo di spingere la sua polemica fino ad autoescludersi dalla comunità, fino a porsi, socraticamente, ai margini della Pòlis: né con lo Stato, né con le Brigate Rosse, scrisse. Immolando sé stesso pur di salvare un principio.
Ecco, avendo presente un simile sfondo etico e artistico, umano e civile, quella frase, magari corriva e arrogante perché di Grassonelli, proprio nella cornice sciasciana avrebbe però meritato più meditata indagine, più sofferto confronto. Senza fughe o dimissioni.