Il “Salvator Mundi” di Leonardo Da Vinci è stato venduto per 450.3 milioni di dollari da Christie’s il 15 novembre 2017. Può sembrare una cifra scioccante per molti di noi che non siamo dei collezionisti ma anche se risulta essere il più costoso pezzo d’arte, non è certo l’unico. Infatti, ecco gli altri 4 della top 5:
“Les Femmes d’Alger”, 1955 (“Versione O) di Pablo Picasso, venduto da Christie’s l’11 maggio 2015 per $179.4; “Nu Couché”, 1917-18, di Amedeo Modigliani, venduto da Christie’s il 9 novembre 2015 per $170.4; un’altra versione dello stesso dipinto di Modigliani, “Nu Couché – Sur le Côté Gauche”, dello stesso anno, venduto da Sotheby’s il 14 maggio 2018 per $157.2 e “Tre Studi di Lucian Freud”, 1969, di Francis Bacon, venduto da Christie’s il 12 novembre 2013 per $142.4.

Se non siete appassionati di arte classica, forse preferite il “Triple Elvis” di Andy Warhol (1963) che avreste potuto aggiudicarvi come affarone il 12 novembre 2014 presso Christie’s, per soli 81.9 milioni di dollari. Basta dire che solo le prime dieci vendite più quotate al mondo arrivano ad una valutazione totale di un miliardo di dollari.
Il punto è questo: come mai i collezionisti sono disposti a spendere cosi tanto per un quadro che molto probabilmente terranno nascosto in qualche salotto dove solo loro e pochi amici potranno goderne? In molti casi non se ne potranno neanche vantare per evitare il rischio di furto o per ragioni di assicurazione e per questo molto spesso gli acquisti avvengono in forma anonima e tali rimangono.
Sono l’ultima persona al mondo a voler denigrare o minimizzare l’importanza dell’’arte’ in tutte le sue forme. In fondo, come studiosa, docente e critica sociale, ho speso la mia vita da adulta esaminando, analizzando e spiegando le opere d’arte. Eppure, allo stesso tempo, mi interrogo spesso circa il valore di quest’ultima in un mondo in cui una buona fetta della popolazione muore di fame.
Una delle caratteristiche precipue della ‘civilizzazione’ è la produzione di arte. Un popolo ‘civilizzato’ è impegnato nella produzione di diverse forme d’arte ma di solito questo accade solo dopo aver provveduto a garantire i livelli minimi di sussistenza, sicurezza ed armonia sociale. La storia dell’arte consiste nella produzione umana di arti visive con valore estetico, cioè create e valutate solo ed esclusivamente per la loro bellezza. L’aratro può essere utile e certamente segno di progresso nello sviluppo di una comunità ma non può essere considerato arte – solo nel mondo post-moderno dove acquisterebbe un significato ironico e autoreferenziale. Non sto contestando l’importanza dell’arte ma sono diventata irremovibile sul concetto che in un mondo dove le risorse sono limitate e la gente è affamata, comprarla a prezzi astronomici non dovrebbe più essere una priorità e costi eccessivi dovrebbero essere moralmente ingiustificati.
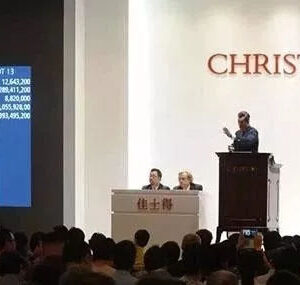
820 milioni di persone nel mondo non hanno cibo a sufficienza. Secondo l’UNICEF più di tre milioni di bambini muoiono di malnutrizione ogni anno. Fame e denutrizione sono le cause di circa la metà della mortalità infantile nel mondo, rendendo i bambini più esposti a malattie o aggravandone il decorso. Inoltre, lì dove la fame non arriva ad uccidere, causa disturbi della crescita in 149 milioni di bambini all’anno. Una stima di quale sarebbe il costo per porre fine alla fame nel mondo è di solo sette miliardi di dollari. Il mercato d’arte globale – che comprende gallerie, fiere e case d’asta – ha generato più di 67 miliardi di dollari in vendite solo nel 2018. In altre parole, le opere vendute ed acquistate in un anno avrebbe potuto risolvere la fame nel mondo più e più volte. E anche se prendiamo la stima più elevata citata dalla UNICEF come punto di riferimento, quella di 65 miliardi di dollari, questa cifra basterebbe per sfamare il mondo.
Come si calcola il valore di un Van Gogh o di un Picasso? È una questione di domanda e offerta? I numeri sono talmente bassi che è impossibile parlare di domanda e offerta. Come sostiene un esperto, “queste vendite sono condotte da un piccolo gruppo di facoltosi collezionisti che pagano cifre astronomiche per opere compiute da un ancor più piccolo gruppo di artisti che a loro volta sono rappresentati da un esiguo numero di gallerie d’alto profilo.”
Se non è la domanda e l’offerta, cosa genera questi prezzi astronomici?
“La ragione per cui alcuni lavori sono venduti per milioni di dollari è che nel mondo dell’arte è opinione diffusa che quelle opere debbano essere vendute a quelle cifre e poiché quello dell’arte è un mercato di ‘opere uniche’, aggiunge Velthius, vi è un senso di sacralità – anche quando artisti come Jeff Koons e Damien Hirst sfornano opere su scala industriale”.
È corretto dire che questa situazione è un esempio lampante di ragionamento circolare: il valore viene calcolato artificialmente sulla base del fatto che le persone ‘giuste’ pensano che quello sia il valore adeguato e quindi quella diventa la valutazione ufficiale.
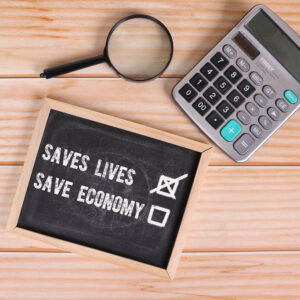
A volte capita pure scoprire che il lavoro di un artista non sia autentico, che sia un falso, e quindi non è nemmeno giustificato come raro prodotto di un talento.
Non è un segreto che le ‘Belle Arti’ siano un allettante mezzo di riciclaggio di denaro. Si possono nascondere o contrabbandarle. Le transazioni sono spesso private e i prezzi possono essere soggettivi e manipolati – così come molto alti. Secondo il The Globe and Mail “una volta comprata, l’opera può sparire dalla circolazione per anni, addirittura decenni. Molti dei lavori comprati nelle aste finiscono in zone franche – depositi ultra segreti per le collezioni di milionari e miliardari che spaziano dai Picasso all’oro, dalle Ferrari d’epoca al vino pregiato”.
In breve, l’acquisto di ‘belle arti’ ad alti prezzi non solo è moralmente indifendibile ma potrebbe pure implicare attività illecite. Questi mega-acquirenti potrebbero riciclare denaro, aggirare il governo, manipolare la micro economia. Dal loro punto di vista, potrebbero replicare che lo scopo sia quello di proteggere le preziose opere e preservarle per i posteri. Ma è sufficiente? O addirittura vero?
Ad oggi, stiamo affrontando una pandemia di Covid-19 e uno dei punti centrali del dibattito, che ha addirittura acceso proteste armate, è l’importanza relativa dell’economia rispetto al benessere e alla sicurezza della gente. Quanto limitanti devono essere le restrizioni in quarantena? Che danno comportano all’economia? A che punto si potranno revocare?
In tempi di pandemia, si pensa a sopravvivere; la paura della morte per Covid-19 ha imposto domande circa il valore della vita come prioritaria e centrale nella nostra coscienza di nazione. Da una parte ci sono paesi e alcuni stati negli US che si sono rifiutati di chiudere tutto per paura di colpire l’economia, dall’altra quelli che sostengono che quest’ultima possa essere ricostruita ma non si possa riportare in vita i deceduti. Il Covid-19 finirà prima o poi ma la fame nel mondo persisterà a meno che non si faccia qualcosa di concreto a riguardo. Quanto vale una vita se solo un paio di quadri potrebbero sostenerne milioni?
Traduzione di Lenni Lippi












