Ventuno romanzi, milioni di copie vendute, una carriera tra televisione, cinema e teatro. Adriana Trigiani è una delle voci più amate della narrativa americana. Il suo nuovo libro, The View from Lake Como, in uscita l’8 luglio per Dutton, torna a parlare di famiglia, identità e donne. Ma questa volta lo fa da un luogo preciso: Lake Como, New Jersey.
“Esiste davvero”, dice a La Voce di New York con un sorriso. “È lì che ho ambientato il romanzo, ma la vera direzione della storia è un’altra: l’Italia. Le Alpi, Carrara, le cave di marmo. Volevo raccontare quel legame tra americani e italiani che non si spezza mai, anche quando sembra dimenticato”.
Protagonista del romanzo è Jess Capodemonte, donna indipendente e stanca, che eredita l’impresa di marmo dello zio e si ritrova, quasi suo malgrado, a dover fare i conti con le proprie origini. Tra drammi familiari e viaggi a ritroso, il romanzo si muove tra due continenti e due linguaggi: quello del sangue e quello della scelta.
“Non è solo una geografia, è un percorso di riconciliazione con la propria identità italiana”, racconta Trigiani. “È lì che Jess inizia a definirsi da sola. Non è più qualcuno che vive nel riflesso delle aspettative altrui. È una donna che finalmente dice: “non sarai tu a definirmi, mi definirò io””.
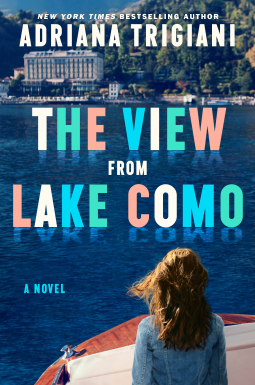
Nel libro, come in ogni genealogia italoamericana, la famiglia è tutto. Ma non in modo statico. Trigiani la racconta come una materia viva, che si scolpisce e si reinventa. Ci sono i Capodemonte, i Burana, i Balancia, famiglie legate tra loro da un filo continuo che unisce la costa del Jersey all’Italia. “Tutti i miei libri parlano di famiglia”, dice. “Ma qui volevo mostrare anche come i ruoli ci vengono assegnati, specie alle donne. E come possiamo riscriverli”.
È un femminismo domestico, il suo. Non ideologico, ma profondamente politico. “Le donne italiane hanno una determinazione incredibile, ma devono affrontare il padre, il fratello, il marito… Nelle nostre famiglie veniamo istruite a fidarci, ma questo non sempre protegge. Le mie nonne erano delle pioniere: una lavorava in una fabbrica in Pennsylvania, l’altra aveva un negozio da sarta in Minnesota. Hanno lottato, e io sono la beneficiaria di quei sacrifici”.
Proprio a loro – alle nonne, alle zie, alla madre –Trigiani ha voluto dedicare le parole più emozionanti durante la festa della Repubblica, il 2 giugno a New York. Sul palco, davanti alla comunità italiana e al Console Generale Fabrizio Di Michele, ha letto in italiano un discorso scritto per l’occasione. “Fabrizio mi ha detto: No, non farlo!”, ride, “ma l’ho fatto lo stesso. Amo la lingua, l’assorbo come una spugna. Se vivessi in Italia per un mese, lo parlerei fluentemente”.
L’idea di resistenza attraversa tutto il romanzo. L’umorismo diventa un contrappunto necessario, quasi una strategia di sopravvivenza. “È innato,” spiega l’autrice, “l’ho imparato in anni di spettacoli, club, sceneggiature. Nasce dalla ribellione ai ruoli imposti. Funziona perché parte sempre da un personaggio”.
Anche il rapporto tra italiani e italoamericani è più sfumato di quanto si pensi. “Molti in Italia ci guardano con diffidenza. Ma il nostro legame è reale. La mia famiglia in Italia mi ha sempre sostenuta. E questa è la base della mia narrazione”. Spiega che le storie italiane parlano al mondo perché uniscono parabole e quotidianità, arte e cibo, favole e famiglia. “Tutti si sentono accolti. Quando racconti bene l’Italia, il mondo si riconosce”. Quanto agli Stati Uniti, la fiducia non vacilla: “Protestare è una prova di vitalità democratica. Le voci si alzeranno, e troveremo un punto d’incontro. Siamo un popolo buono”.












