Un Occidente prigioniero (Adelphi 2022) di Milan Kundera raccoglie una serie di scritti dell’autore moravo, che invita a riflettere su come proteggere la cultura nel continente europeo sia la medicina per salvare l’Europa oggi. Kundera è uno scrittore di successo, ricorda nella prefazione al volume Jacques Rupnik; scrisse nell’epoca d’oro della cultura cecoslovacca, gli anni Sessanta. Con Pavel Kohut fu membro nel 1967 del Congresso degli Scrittori, il cui obiettivo, in tempo di censura, era di fare il punto sulla situazione cultural-letteraria del paese. Kundera condannò i censori comunisti, definendoli “vandali” sia al Congresso che negli anni Ottanta, in autoesilio a Parigi. Pubblicato su Le Débat col titolo “Un Occidente prigioniero o la tragedia dell’Europa centrale”, l’articolo ebbe molto eco. Lo ricorda Pierre Nora, nella premessa. Un impatto dall’Est fino alla Germania e alla Russia, con reazioni politiche di ogni sorta.
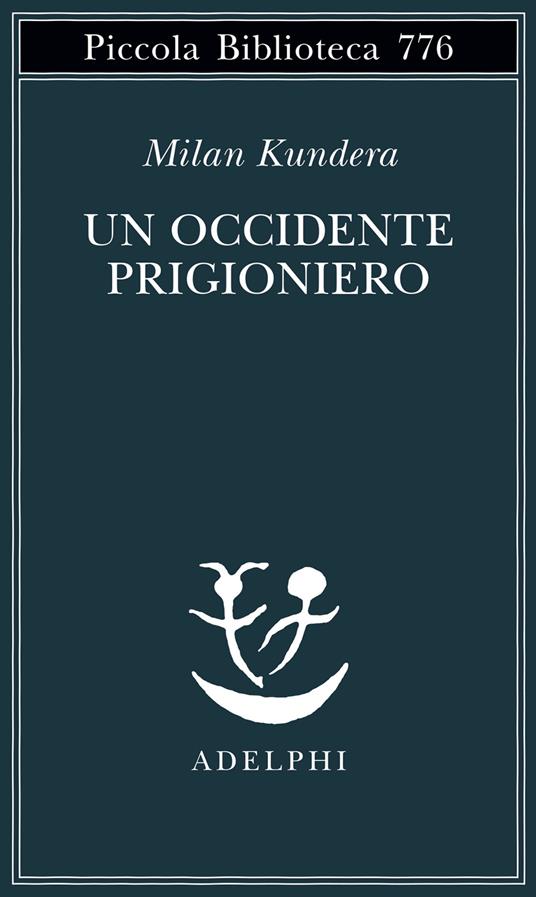
Kundera parlava della «storia assai poco felice e frammentata della nazione ceca, che ha conosciuto l’anticamera della morte». Un esordio significativo: lo scrittore riportava indietro la mente alla fragilità istituzionale del paese e alla non-certezza dello stesso nello scacchiere della Guerra Fredda. Per far rinascere il paese, secondo l’autore, era necessario un risveglio nazional-culturale ceco. Significative le parole di František Palacký: «Se non indirizziamo lo spirito della nazione verso attività più elevate e nobili […] non potremo […] garantire la nostra esistenza». Fece eco Jan Neruda: «Dobbiamo elevare la nazione al livello di consapevolezza e istruzione […] in modo da garantirne […] la sopravvivenza». Quella culturale era ed è una vera e propria missione. Per raggiungere l’obiettivo di maggiore coscienza nazionale occorre lo sforzo di un’intera nazione. Kundera ripercorre la storia della letteratura ceca e spiega che lo Stalinismo l’ha isolata dal mondo, svilendone le sfumature.
«Il vandalismo contemporaneo non si manifesta unicamente in forme condannabili agli occhi della legge. Se un comitato di cittadini oppure di burocrati […] stabilisce che una statua […] è inutile e decide di eliminarla, non fa che mettere in atto una diversa forma di vandalismo». Kundera auspicava una cultura libera. «La repressione di qualsiasi opinione […] va, in fondo, contro la verità, quella verità che si raggiunge solo attraverso il confronto di idee libere ed eguali. Qualsiasi forma di interferenza nella libertà di pensiero o di espressione […] è […] uno scandalo». L’arte prolifera solo con la libertà di pensiero. Ostacolare lo scrittore, tramite la censura, vuol dire ostacolare il popolo, secondo Kundera. La cultura è l’identità di un popolo. Cancellando una cultura, si cancella un popolo. Ed infatti è quanto è successo sotto il Patto di Varsavia.
Nell’articolo su Le Débat Kundera ricordava come le culture oltre-Cortina fossero parti integranti dell’Europa in senso più ampio. Formavano e aiutavano a comporre l’Occidente in senso lato. «L’identità di un popolo o di una civiltà si riflette e si riassume nell’insieme delle creazioni spirituali che solitamente definiamo “cultura”». La cultura è il valore vivo attorno a cui il popolo si stringe. In questo, secondo Kundera, gli scrittori hanno un ruolo importante. Teatro, cinema e letteratura aiutarono a portare la Cecoslovacchia alla sua primavera culturale. La messa al bando di uno spettacolo di Adam Mickiewicz scatenò in Polonia una rivoluzione sessantottina. Cultura, libertà e indipendenza devono essere viste non come questioni separate, ma come elementi imprescindibili che contribuiscono a formare l’identità di un popolo. L’Europa centrorientale è stata ed è tutt’ora una culla di tanti popoli che si intersecano con confini immaginari e identitari.
I genitori di Sigmund Freud venivano dalla Polonia, ma il piccolo ha passato la sua infanzia in Moravia come, tra gli altri, Karl Kraus, Edmund Husserl e Gustav Mahler. Joseph Roth aveva radici polacche. Franz Kafka era un ebreo boemo che parlava e scriveva in tedesco. «Non sono dunque confini politici […] a delineare e determinare l’aggregazione centro europea, ma le grandi situazioni comuni che riuniscono i popoli, e li raggruppano […] entro i confini immaginari e sempre mutevoli». Sarà stata forse l’esperienza del Comunismo e della Cortina di ferro che hanno tolto lo sguardo occidentale verso l’Europa orientale, ma nel complesso la cultura centro-europea è stata dimenticata per molti anni, ricorda Kundera. L’Europa non ha notato la scomparsa di questo enorme crogiolo culturale, perché non ne avvertiva l’unità culturale, spiega Kundera. Per salvare l’Europa è necessario un’unificazione culturale tra Est ed Ovest.
Salvare e preservare la cultura, vuol dire salvaguardare identità e libertà dei popoli. Franz Werfel, che passò un terzo della sua vita a Praga, poi a Vienna e poi negli Stati Uniti, in un convegno a Parigi nel 1937 propose l’istituzione di un’accademia mondiale di pensatori. Un gran consiglio dei sapienti non delegati dagli Stati, ma indipendente dalla politica e volta a fronteggiare l’imbarbarimento del mondo. Potrebbe sembrare ingenuo sapendo quel che è successo dopo, ma per salvare la cultura e l’identità europea occorrono proposte credibili e funzionali agli obiettivi dell’Europa di oggi. Per salvare la cultura da propaganda, mistificazione e indifferenza occorre un’unità culturale europea. Infine, «l’Europa centrale deve dunque opporsi alla forza schiacciante del suo grande vicino [la Russia], e insieme anche alla forza immateriale del tempo, che lascia irrimediabilmente dietro di sé l’Europa della cultura». Una riflessione valida ancora oggi. E non solo in ambito culturale.












