Bella e coraggiosa operazione di bisturi storico, quella messa in piedi da Alessandro Masi, segretario generale della Società Dante Alighieri, col suo Idealismo e opportunismo della cultura italiana 1943-1948. Ne è venuto fuori un libro colto e insieme onesto, da leggere tutto d’un fiato, tanto è denso di fatti, episodi, nomi, confidenze, mai incappando in parzialità, sempre validando, con un lavoro certosino di documentazione, ogni affermazione.
Peccato che un testo così equilibrato, sia introdotto da uno scritto di Andrea Riccardi, apparentemente ideologico, meno rispettoso della ricchezza e articolazione della vita politica e culturale di quel quinquennio, che interpreta un periodo fondamentale nella costruzione dell’Italia repubblicana come una partita che riguardava esclusivamente democristiani e comunisti, epifania del compromesso storico (peraltro mai consumato, per la fortuna delle italiche sorti!) dei successivi anni settanta.
Eppure dalle quasi cinquecento pagine del libro appare evidente come, dalla fronda fascista alla rigogliosa fioritura di pensiero e azione degli ambienti laici e socialisti resistenziali e post resistenziali, esistesse in Italia uno spettro culturale e politico né cattolico né marxista-leninista di tutto rispetto anche, e non solo, per lo spessore dei suoi leader. Si ricordi che al voto del 2 giugno 1946 il Psiup, Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria risultò secondo (20,7% dei consensi) alla sola Democrazia Cristiana (35,2%). I socialisti ebbero 115 eletti rispetto ai 207 della Dc e ai 104 del Pci (18,9% dei consensi).
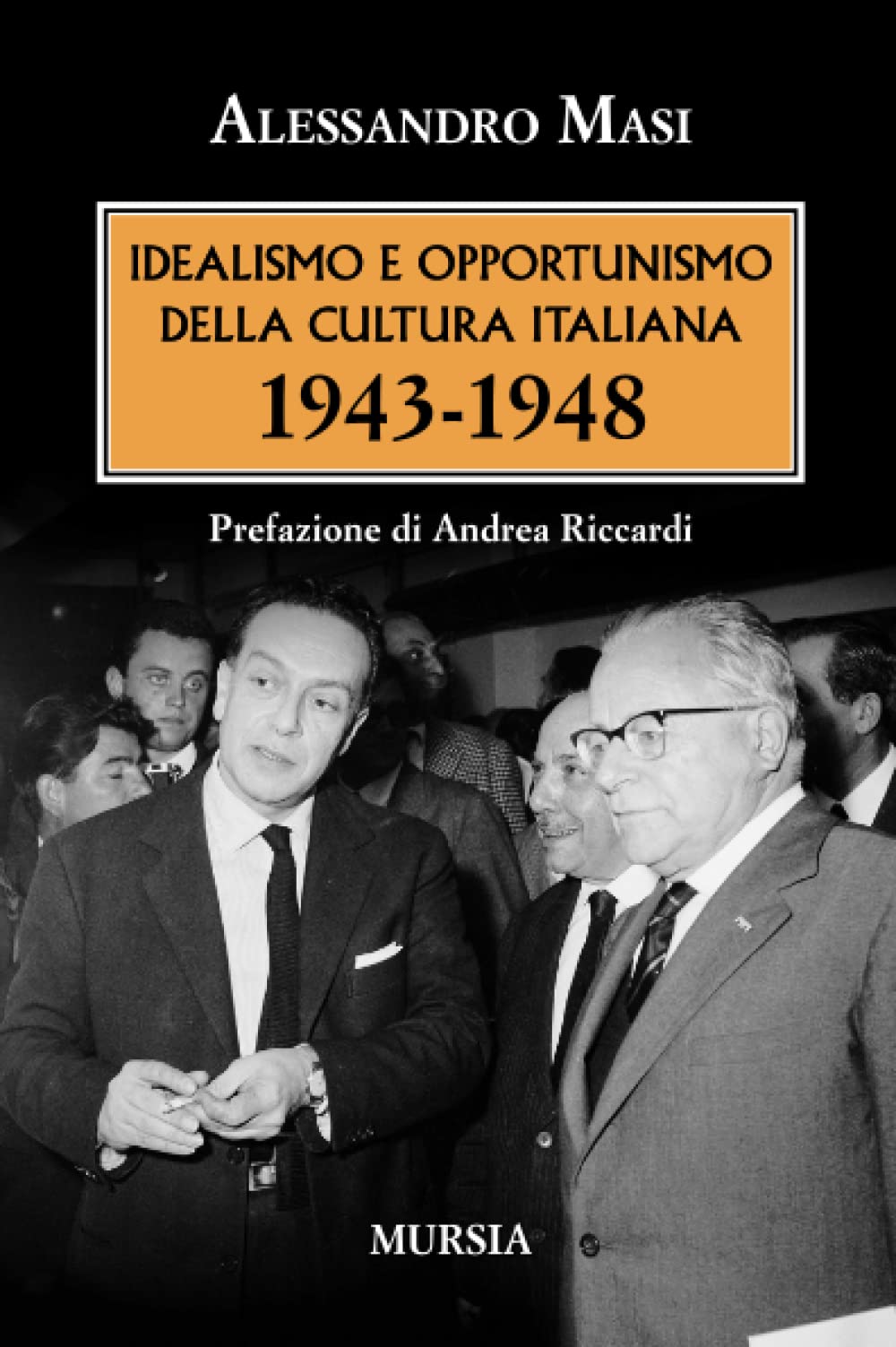
Tre le chiavi con le quali Masi legge quel tempo: storica (la successione dei fatti), politica (come i leader del tempo abbiano oscillato tra idealismo e opportunismo), culturale (come gli intellettuali si siano rapportati al cambiamento e abbiano espresso lo “spirito del tempo”). Nel periodo fascista, esemplari due figure sulle quali si esercita la capacità di ricostruzione dell’autore. La prima è di Giuseppe Bottai, stretto fra la fedeltà al duce e la consapevolezza del cambiamento in arrivo, che Masi ha occasione di rappresentare con una serie di sfumature che, al contrario di altre narrazioni, mai trascendono nel caricaturale. Mussolini non vuole ascoltarne le ragioni (come, su un altro piano, più intimo, non ascolta quelle di Margherita Sarfatti, costretta infine ad autoesiliarsi, racconta Masi), fino ad arrivare, nel febbraio 1943, a togliergli la responsabilità di orchestrare da ministro la cultura nazionale, affidandola a un tirapiedi. Come riporta Masi, Bottai già due mesi dopo l’entrata in guerra, il 12 agosto aveva consegnato al duce una lettera che illustrava la crisi del nazionalismo e dell’idealismo, rappresentando la cultura italiana di fronte alla guerra con “nessuna capacità di parteciparvi, disanimata, indifferente, addirittura ostile, in stato di reazione dinnanzi al moto rivoluzionario che gira intorno all’asse Roma-Berlino”.
La seconda, quella di Giovanni Gentile, filosofo che l’autore coglie nell’ultimo atto di regime, il Discorso agli Italiani del 24 giugno 1943, alla vigilia del voto del Gran Consiglio che sfiducerà il suo padrone politico. Se dopo il 25 luglio, e soprattutto dopo l’8 settembre, la gran parte di intellettuali e studenti si trovarono fuori dal fascismo e indisponibili a difenderlo, lo si dovette anche al fatto che l’idealismo di quel maestro si era scoperto essere bolsa retorica e asservimento a un potere che aveva lesionato il rapporto tra popolo e stato, fondamento della stabilità di qualunque regime, sia esso democratico o autoritario. Masi evoca il termine “inganno”, così come attribuisce alla ”ingenuità” il tradimento negli ideali subita da una generazione “finalmente libera di scegliere”.
L’analisi degli anni successivi, fino alla costituzione repubblicana e all’avvio del parlamento democratico, diviene giustamente sempre più “politica”, visto che essa può ora esprimersi sempre con maggiore ampiezza e libertà. Masi la esamina nel rapporto con la cultura, l’economia, i media. Ed è qui che il ragionamento sull’opportunismo trova modo di esprimersi con pienezza. Non riguarda, ovviamente, fenomeni del tutto nuovi e alti come Togliatti e la rivista Rinascita, sulla sponda ufficiale dei comunisti, o Il Politecnico di Vittorini nei paraggi, ma la galassia dei tantissimi transfughi che dalla militanza fascista passeranno armi e bagagli alla corte dei nuovi leader dei partiti democratici, molti dei quali non schiferanno di finire addirittura comunisti. I più coerenti avranno fatto la resistenza e, non casualmente, si ritroveranno – durante il periodo esaminato – nel neorealismo. Accanto alla letteratura, brilleranno soprattutto pittura e cinema.












