
L’11 aprile scorso ci ha lasciati il grande poeta, traduttore, saggista e accademico Jopseph Tusiani, una delle figure più rappresentative della cultura e della letteratura del nostro tempo. Joseph Tusiani era arrivato negli Stati Uniti 73 anni fa, il 6 settembre 1947, giovane laureato in lettere classiche. Raccontò che quella mattina, dal parapetto del transatlantico Saturnia, scrutava la folla assiepata sulla banchina del porto di New York. In mezzo a tanti volti, cercava quello del padre che non aveva mai visto, se non in una sbiadita foto appesa al muro della cucina nella casa natia, a San Marco in Lamis, sul Gargano. Giuseppe Tusiani aveva attraversato l’Atlantico con la madre Maria e ora la famiglia stava per ricongiungersi per la prima volta, dopo 24 anni. Giuseppe ne aveva 23. Quando suo padre Michele era partito, lui non era ancora nato. Arrivava in America con le sole credenziali della sua laurea in lettere classiche e una lettera di presentazione del suo professore Cesare Foligno, illustre dantista e docente di Letteratura Italiana prima a Oxford e poi a Napoli, per Padre Gerald Groveland Walsh, anch’egli famoso dantista, già allievo del Foligno, gesuita e presidente della Fordham University di New York.

Tusiani si era brillantemente laureato all’Università di Napoli, nonostante la difficile condizione economica della famiglia. Con enormi sacrifici, la madre era riuscita a far studiare questo figlio, volenteroso e intelligente, coi magri guadagni del suo lavoro di sarta. Il forte legame tra madre e figlio, sviluppato in quegli anni di solitudine e ristrettezze, continuerà per tutta la vita. Più difficoltoso fu, all’inizio, creare un rapporto col padre. Quell’uomo incontrato sulla banchina a ventitré anni era praticamente un estraneo per Giuseppe. Quando la madre glielo indicò, tra la marea di gente che premeva contro le transenne del Molo 86 di Manhattan, guardandolo mentre sventolava il fazzoletto e gridava “Marì, Marì”, sentì che la parola ‘Papà,’ sulla quale “mi ero esercitato per anni, non mi sarebbe venuta sul labbro. Quelle due sillabe, per altri facili e naturali, erano per me un intoppo irto e tremendo.”
Sentimenti forse non troppo diversi provava il padre Michele nei confronti di questo figlio, che aveva forse immaginato bambino e che si vedeva ora davanti nelle sembianze di un uomo. Anche per lui non sarà facile pronunciare la parola “figlio”. La prima sera in America, arrivati nell’alloggio che il padre aveva preso nel “Bronchese”, il Bronx nella parlata degli italiani di New York di quegli anni, prima di ritirarsi nella camera da letto con la moglie, per la prima volta dopo 24 anni, si avvicinò al figlio per mostrargli il contenuto del frigorifero, invitandolo a servirsi liberamente di tutto il ben di Dio che conteneva: “Se ti svegli e hai fame, apri e mangia e non pensare alla giobba. Buona notte, fi … felice.” Col tempo, naturalmente, anche il rapporto col padre si sarebbe consolidato e Tusiani avrà sempre sentimenti di orgoglio e tenerezza verso di lui.
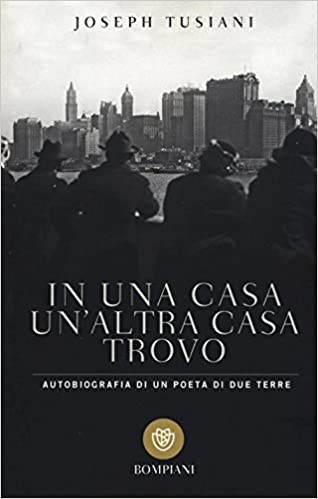 Alla “giobba”, al lavoro, Giuseppe pensava senza posa e non vedeva l’ora che qualcuno lo accompagnasse alla Fordham University. Tuttavia, dovette attendere il ritorno di Padre Walsh dall’Europa. Nel frattempo, esplorò la “Little Italy” del Bronx, frequentando ambienti ed esponenti della cultura italiana di New York. Nella sua autobiografia In una Casa un’Altra Casa Trovo (Bompiani, 2016), Tusiani ci descrive l’atmosfera delle strade attorno ad Arthur Avenue, dove la famiglia abitava all’inizio, gli odori, il vocio, il trambusto che gli ricordavano “il pandemonio giornaliero di Forcella a Napoli”, o la fiera d’autunno che un tempo si celebrava nei paesi del Gargano, se non fosse per i richiami, in un inglese molto nostrano, che lanciavano i venditori ambulanti.
Alla “giobba”, al lavoro, Giuseppe pensava senza posa e non vedeva l’ora che qualcuno lo accompagnasse alla Fordham University. Tuttavia, dovette attendere il ritorno di Padre Walsh dall’Europa. Nel frattempo, esplorò la “Little Italy” del Bronx, frequentando ambienti ed esponenti della cultura italiana di New York. Nella sua autobiografia In una Casa un’Altra Casa Trovo (Bompiani, 2016), Tusiani ci descrive l’atmosfera delle strade attorno ad Arthur Avenue, dove la famiglia abitava all’inizio, gli odori, il vocio, il trambusto che gli ricordavano “il pandemonio giornaliero di Forcella a Napoli”, o la fiera d’autunno che un tempo si celebrava nei paesi del Gargano, se non fosse per i richiami, in un inglese molto nostrano, che lanciavano i venditori ambulanti.

I circoli italiani di New York si dimostrarono ben presto asfittici, specie quello che si riuniva nella casa dell’architetto Nicola Giusto, sulla porta del quale era affissa la scritta “In questa casa non si parla il maledetto inglese”, per via del fatto che l’architetto aveva rinunciato ad impararlo, non essendo mai riuscito a pronunciare il suono del “th”. Tuttavia la frequenza di questi circoli, presso i quali, comunque, Tusiani resterà sempre attivo, gli permise di entrare in contatto con intellettuali come Onorio Ruotolo, Giuseppe Antonio Borgese e, soprattutto, Arturo Giovannitti, sindacalista, attivo sostenitore delle rivendicazioni della classe operaia italoamericana degli anni ’20, giornalista e poeta, autore, tra l’altro, del poema The Walker (1919).
… Per tutta la notte inquieta ascolto passi sulla mia testa,
chi cammina? Non lo so. E’ lo spettro del carcere, è il
cervello insonne, un uomo, l’uomo, l’Uomo che cammina.
Uno-due-tre-quattro: quattro passi ed il muro.
Uno-due-tre-quattro: quattro passi e il cancello di ferro. …”

L’anno dopo il suo arrivo a New York, Tusiani ottenne l’incarico di docente di letteratura italiana al College of Mount Saint Vincent. Vi resterà fino al 1972, quando decise di accettare un contratto con il Lehman College della City University of New York. A casa di Onorio Ruotolo, Giuseppe Tusiani aveva visto per la prima volta il ritratto di Frances Winwar, la scrittrice di origini italiane che avrebbe avuto su di lui un’influenza determinante. Nata a Taormina nel 1900, Francesca Vinciguerra aveva americanizzato il suo nome, traducendolo letteralmente in inglese, dopo aver acquisito la cittadinanza americana. Di fatto era stato il suo editore a chiederle di cambiare nome e cognome come condizione per pubblicare il suo primo libro, The Ancient Flame (1927), in modo da facilitarne la circolazione oltre la ristretta cerchia degli intellettuali e dei lettori italiani d’America. Tusiani la incontrò nel 1953, nella casa estiva che la scrittrice aveva nel Vermont. La loro amicizia, immediata, sarà inossidabile negli anni. Tusiani andava a trovarla tutti i giorni a Manhattan appena finite le lezioni. Nel 1954 l’accompagnerà in un viaggio in Italia. Andarono insieme anche a Gardone Riviera, al Vittoriale degli Italiani, per le ricerche che la scrittrice stava conducendo per suo il libro su Gabriele D’Annunzio e Eleonora Duse (Wingless Victory: a Dual Biography of Gabriele D’annunzio and Eleonore Duse, 1956; edizione italiana: Con D’Annunzio, di Fuoco in Fuoco, Mondadori, 1960). Sarà la Winwar a stimolare Tusiani ad aprirsi sempre di più alla cultura del Nuovo Mondo, a perfezionare l’inglese, a scrivere nella lingua della sua nuova patria, a introdurlo negli ambienti della grande cultura newyorkese. Nel 1956, Giuseppe, ormai Joseph, Tusiani divenne cittadino statunitense.

Nel corso di quel primo viaggio in Italia dopo sette anni in America, Tusiani visitò, naturalmente, anche San Marco in Lamis, dove scrisse, in inglese, il poema “The Return”. Frances Winwar lo invierà a sua insaputa in Inghilterra, a un concorso poetico. Tusiani lo saprà solo quando, per quella poesia, gli fu assegnato il prestigioso Greenwood Prize della Poetry Society of England. In seguito tradurrà lui stesso “The Return” in italiano, intitolandolo “M’Ascolti Tu, Terra Mia?” È un canto d’amore al paesello e alla “sua” montagna:
“My cradle-land, who suffered? I did not,
Nor did I ever miss your wonderbreeze,
If my sad eyes can see you, lucent still,
And still maternal. Over savage seas
My fear alone has groped; through winds, and weird
Valleys, and moonless paths, only my thought
Has ventured; but the soul,
Blood through the veins, has passed through your roots wild
Eternally, and the man
Has not outgrown the child. …”“Terra natale, io non ho mai sofferto,
io non ho pianto e non son mai partito
se alla mesta pupilla,
che ti ritrova, tu sei bella ancora
e sei materna. Forse per selvaggi
mari avanzò la sola mia paura;
forse per venti e valli e per sere
illuni procedé, sempre sgomento,
il mio pensier soltanto;
ma l’anima, qual sangue tra le vene,
passò per tue radici eternamente
e l’uomo restò bimbo e fu sereno. …”
| Nella sua lunga carriera accademica, Tusiani ha accumulato una monumentale bibliografia, pubblicando fondamentali saggi sulla letteratura italiana, inglese e americana, traduzioni, poesie in quattro lingue: italiano, inglese, latino e anche nel dialetto garganico, la lingua delle radici. L’amore per la terra natia è stata, infatti, una delle sorgenti più generose che hanno ispirato la poesia di Tusiani. Le sedici raccolte di poesie in vernacolo sono state pubblicate nel volume Storie del Gargano, Poesie e narrazioni in versi dialettali (2006). Le poesie in inglese e in latino sono state raccolte a cura di Emilio Bandiera e pubblicate, in Italia, da Congedo Editore (Carmina Latina 2, 1998; Collected Poems, 2004; Fragmenta ed Aemilium, 2009). Il primo volume di Carmina Latina era stato pubblicato nel 1994 da Schena Editore. Tusiani ha pubblicato, tra l’altro, la prima traduzione in inglese di tutte le poesie di Michelangelo, The complete Poems of Michelangelo (1960), della Gerusalemme Liberata (1970) e del Morgante del Pulci (1982). |

Probabilmente, per il lettore, è proprio la poesia di Tusiani, oltre agli scritti autobiografici, a costituire l’aspetto più affascinante, per mole e, soprattutto, per la finezza, la musicalità della versificazione e la delicatezza dei sentimenti. In essa, come nota Emilio Bandiera, nell’introduzione a Collected Poems, si rintracciano vari temi, da quelli della vita quotidiana, che fanno apparire queste composizioni come una specie di diario intimo, ai ricordi nostalgici dell’infanzia e dell’adolescenza trascorse nel paese ormai lontano nello spazio e nel tempo.
“Enmeshed in mist, an alpine peak expects
sunrise and song. What is a summit, then,
’til rays and rhythm liven it afresh?
Longing for valleys where the streaming light
already brightens buds and tickles birds;
longing for the arcane, new happiness
of music heard and limpidness beheld.
But, mantled yet in night, the lonesome peak
cannot remember all it does possess –
a regal robe to wear, made of entrancing
rubies and pearls and gold (oh, bold, enfolding
prancing of lively hours) and so forgets
the only reason for its blissful height,
the ultimate enchantment of its life. ….”
(da “A Garland for Manhattan”)
|
| Ciò che maggiormente colpisce, però, è il senso di una visione della vita, di una religiosità che Bandiera definisce, acutamente, platonica e francescana. Una religiosità mai bigotta, anzi a volte quasi rivoluzionaria, come nella poesia “Caino, offerente migliore”, nella quale il poeta, cito sempre Bandiera, “capovolge l’esegesi che la tradizione religiosa ha sostenuto e diffuso per secoli”, facendo di Caino il fratello buono. |
Per le sue opere e la sua straordinaria carriera di studioso, Joseph Tusiani ha ricevuto i più alti riconoscimenti in America e, a sfatare il proverbio Nemo propheta in patria, anche in Italia. Quando lasciò l’insegnamento attivo, nel 1983, il Lehman College lo nominò Professor Emeritus e istituì il Joseph Tusiani Scholarship, per borse di studio agli studenti italoamericani. Il Congresso degli Stati Uniti gli ha conferito, nel 1984, la Congressional Medal of Merit. Nel 1999, ha ricevuto dal Governatore di New York, Mario Cuomo, il Governor’s Award of Excellence. Tusiani è anche stato insignito della Laurea honoris causa in Lettere e Filosofia dall’Università di Foggia e del Premio Puglia, istituito dalla Regione Puglia per i pugliesi che si sono distinti nel mondo. Numerosi sono i convegni organizzati in suo onore e gli accademici che studiano le sue opere. A Lecce, il Prof. Emilio Bandiera, traduttore ufficiale della produzione poetica in latino di Tusiani, ha istituito il Fondo Tusiani presso l’Università del Salento, una raccolta completa degli scritti del grande sammarchese di New York e degli studi critici sulle sue opere.
Il 9 gennaio 2016, il Governatore Andrew Cuomo, aveva nominato Tusiani “Poeta Laureato” dello Stato di New York. Joseph Tusiani ha continuato a scrivere fin quasi alla fine dei suoi giorni e, finché ha potuto, è venuto ogni anno, in primavera inoltrata, nella sua San Marco in Lamis, a respirare i profumi del Gargano. Addio e grazie, Maestro!
Bibliografia essenziale
Joseph Tusiani, La natura nella poesia di William Wordsworth, Napoli, Università di Napoli, 1947.
Joseph Tusiani, Petali sull’onda : poesie, New York, Euclid publishing, 1948.
Joseph Tusiani, La poesia amorosa di Emily Dickinson, New York, The Venetian press, 1950.
Joseph Tusiani, Dante in licenza, Verona, Nigrizia, 1952.
Joseph Tusiani, Mallo e gheriglio; La quinta stagione, traduzione di Maria C. Pastore Passaro, Roma, Bulzoni, 1987.
Joseph Tusiani, In una casa un’altra casa trovo : autobiografia di un poeta di due terre, a cura di Raffaele Cera e Cosma Siani, Milano, Bompiani, 2016.
Per la bibliografia completa di Joseph Tusiani, si veda qui.
Qui la lunga intervista video che Vito De Simone realizzò due anni fa con Joseph Tusiani.
Parte di quest’articolo è apparso Sabato 18 Novembre, sul quotidiano foggiano L’Attacco (Anno 11, N. 201. Pag. 18)










